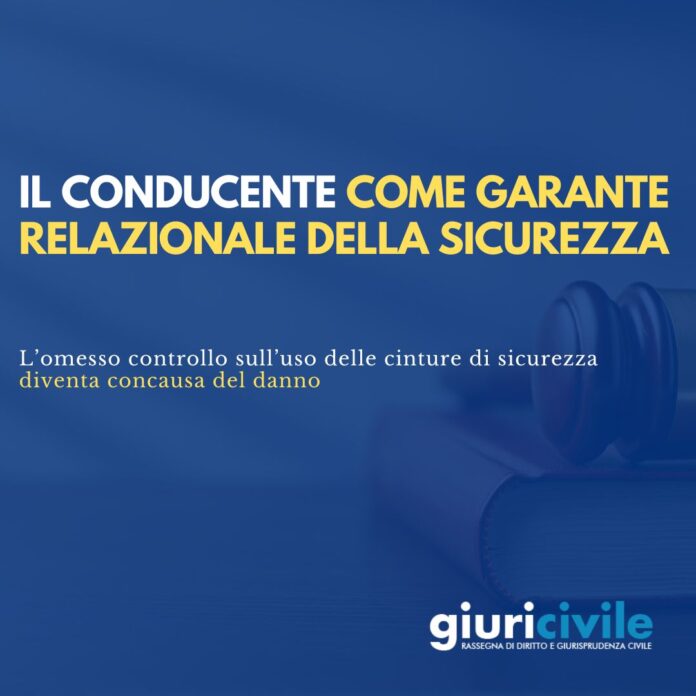
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 26723 del 4 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ridefinisce il ruolo del conducente nella circolazione stradale, trasformandolo da semplice soggetto tecnico a garante relazionale della sicurezza. L’omesso controllo sull’uso delle cinture di sicurezza diventa concausa del danno, fondando la responsabilità su principi di tutela effettiva e prevenzione.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.
Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
Leggi descrizione
Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2025, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.
Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
Premessa. Dalla colpa alla cura: la svolta della Cassazione
La sentenza n. 26723/2025 della Corte di Cassazione segna una svolta profonda nel sistema della responsabilità civile da circolazione stradale. Non si limita a ricalcolare le quote di concorso di colpa: ridefinisce il ruolo stesso del conducente, trasformandolo da soggetto tecnico a garante relazionale della sicurezza. Il conducente non è più solo colui che guida, ma colui che vigila, previene, tutela.
L’omesso controllo sull’uso delle cinture di sicurezza non è più una circostanza marginale: diventa concausa del danno, fondando la responsabilità su principi di prevenzione effettiva e tutela sostanziale. La Corte impone una lettura della responsabilità civile che supera la funzione risarcitoria e si apre a una dimensione educativa e cooperativa, capace di orientare i comportamenti verso la cura dell’altro e la prevenzione del rischio.
In questa prospettiva, la responsabilità civile non è solo imputazione giuridica: è pratica relazionale, è norma che protegge, è diritto che promuove la vita. La sentenza non risolve solo un caso: propone un modello. E il modello è quello di una responsabilità che genera fiducia, sicurezza e cultura della legalità.
Il quadro nazionale. L’art. 1227 c.c. come norma di prevenzione e responsabilità da contatto sociale
Il diritto civile italiano va interpretato come un sistema organico, dove la responsabilità civile si colloca all’intersezione tra norme di prevenzione, obblighi di condotta e tutela della vita.
L’art. 1227 c.c., tradizionalmente letto in chiave risarcitoria, acquisisce una funzione più ampia se considerato insieme alla responsabilità da contatto sociale (Cass. civ., Sez. III, 2001, n. 9556), secondo la quale chi assume una posizione di controllo o influenza su altri soggetti diventa garante della loro sicurezza. In questa prospettiva, la responsabilità civile non si limita a riparare il danno, ma svolge una funzione preventiva e educativa, orientando i comportamenti verso la cooperazione e la cura reciproca.
Dal punto di vista teorico, l’art. 1227 c.c. non è strumento di mera riduzione del risarcimento in caso di concorso di colpa, ma norma quadro che guida l’azione dei soggetti nella vita sociale, anticipando le conseguenze dannose delle omissioni. Il conducente assume una funzione di controllo attivo, assimilabile a quella del datore di lavoro, dell’educatore o del medico, come confermano le più recenti pronunce della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 2025, n. 26723).
Potrebbero interessarti anche:
- Sinistri con veicolo estero e art. 141 cod. ass.: l’azione diretta del terzo trasportato
- Non idoneità del mezzo guidato e concorso di colpa del passeggero in caso di sinistro stradale
- Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale: hanno ancora valore paranormativo?
- Sindacato causale sull’iniquità contrattuale: assicurazione e clausole claims made
Il fondamento sovranazionale. La sicurezza come diritto effettivo e cooperativo
La sicurezza stradale trova un fondamento robusto nel diritto sovranazionale, dove la tutela della vita e della salute è riconosciuta come principio effettivo, vincolante e non derogabile. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 3 e 47) e l’art. 191 TFUE impongono agli Stati — e, per estensione, ai soggetti privati che rivestono ruoli di garanzia — obblighi positivi di prevenzione, orientati alla protezione concreta della persona.
In questa prospettiva, la Corte EDU, nella sentenza Cordella e altri c. Italia (2019), ha chiarito che la protezione della vita non può ridursi a regole formali o a dichiarazioni astratte: essa richiede misure attive, concrete e verificabili, capaci di anticipare il rischio e di neutralizzarne gli effetti prima che si traducano in danno.
Il dovere attivo del conducente si inserisce pienamente in questo quadro: non è una mera prescrizione tecnica, ma un obbligo cooperativo di tutela effettiva, che trasforma la guida in una pratica relazionale di protezione. Il conducente, accettando di trasportare altri, assume una posizione di garanzia che lo vincola non solo al rispetto delle norme, ma alla cura concreta della vita altrui.
La responsabilità civile, in questa visione, non è solo imputazione postuma: è prevenzione sostanziale, è educazione alla legalità, è diritto che protegge prima che punisca. Il fondamento sovranazionale non rafforza solo il dovere del conducente: ne legittima la natura assiologica, collocandolo al crocevia tra diritto interno, cultura della sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.
La ratio della sentenza. Protezione, cooperazione, prevenzione: il diritto che anticipa il danno
La sentenza n. 26723/2025 non si limita a ridefinire il perimetro della responsabilità del conducente: essa promuove una vera e propria cultura della sicurezza fondata sulla cooperazione tra soggetti coinvolti nel trasporto. Il conducente non è più responsabile solo della guida in senso stretto, ma anche della condizione di sicurezza relazionale dei passeggeri, assumendo una posizione di garanzia che impone vigilanza attiva e prevenzione concreta.
Dal punto di vista dottrinale, il dovere di controllo si configura come obbligo relazionale di protezione, secondo la prospettiva elaborata da Bianca e Trimarchi, che attribuisce alla responsabilità civile una funzione non solo risarcitoria, ma educativa e preventiva. Il diritto, in questa visione, non interviene solo dopo il danno: lo anticipa, lo neutralizza, lo trasforma in occasione di cura.
La responsabilità civile diventa così strumento di tutela attiva, capace di orientare i comportamenti verso la cura reciproca, la fiducia relazionale e la legalità sostanziale. Il conducente che controlla non esercita un potere, ma realizza una forma di protezione concreta, che restituisce al diritto la sua funzione più alta: promuovere la vita, educare alla responsabilità, costruire sicurezza condivisa.
Conducente e trasportato. Dall’autonomia responsabile all’affidamento relazionale
Fino agli anni Duemila, la giurisprudenza italiana ha tendenzialmente valorizzato l’autonomia del trasportato, ritenendo che il mancato uso delle cinture di sicurezza costituisse colpa esclusiva o concorrente, tale da ridurre o escludere il risarcimento ex art. 1227 c.c. In questa prospettiva, il passeggero era considerato soggetto pienamente responsabile delle proprie scelte, e il conducente non assumeva obblighi di verifica o di intervento.
La successiva evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente riconosciuto al conducente una posizione attiva di garanzia, fondata non solo su norme tecniche, ma su una relazione di affidamento che lo vincola alla tutela della sicurezza altrui. Il conducente, accettando di trasportare altri, entra in una relazione giuridica di protezione, che impone doveri di vigilanza e di prevenzione.
Le teorie dell’autonomia responsabile e dell’affidamento relazionale
Il confronto tra la teoria dell’autonomia responsabile (Palmieri) e quella dell’affidamento relazionale (Comandé) evidenzia una svolta assiologica nel diritto civile contemporaneo. Mentre la prima si fonda su una visione individualistica della responsabilità, la seconda riconosce che la convivenza sociale genera obblighi di cura reciproca, soprattutto nei contesti in cui uno dei soggetti assume una posizione di controllo o di garanzia.
La teoria dell’affidamento relazionale si rivela più coerente con la funzione moderna della responsabilità civile, che non si limita a sanzionare il danno, ma lo anticipa, lo previene, lo educa. In questo senso, il conducente non è solo un agente tecnico: è un custode della sicurezza condivisa, e la sua responsabilità si fonda sulla cura dell’altro come principio giuridico.
Diritto comparato. L’Europa del conducente garante: Francia, Germania, Spagna
Il diritto comparato conferma il modello del conducente come garante attivo della sicurezza.
In Francia, il Code de la route impone al conducente di verificare che i passeggeri indossino le cinture, attribuendogli una responsabilità diretta in caso di omissione. Non si tratta solo di un obbligo formale, ma di un dovere di cura verso gli altri occupanti del veicolo.
In Germania, il §21a StVO prevede un analogo obbligo di controllo, con conseguenze anche assicurative e sanzionatorie.
In Spagna, la Ley de Seguridad Vial riconosce al conducente un ruolo attivo di prevenzione, ponendo la vigilanza tra le condizioni essenziali della guida responsabile.
A livello sovranazionale, la Direttiva 2003/59/CE e la Convenzione di Vienna del 1968 sanciscono il dovere di vigilanza come standard internazionale di sicurezza.
Questi strumenti non si limitano a dettare regole tecniche, ma promuovono una cultura della responsabilità condivisa, dove la sicurezza nasce dalla cooperazione tra conducenti, passeggeri e autorità di controllo.
Con la sentenza n. 26723/2025, anche l’Italia si allinea a questo modello europeo, riconoscendo che la responsabilità civile del conducente non si esaurisce nella riparazione del danno, ma si fonda su un principio di cura e solidarietà verso l’altro.
Il diritto comparato diventa così orizzonte di coerenza sistemica, nel quale la sicurezza stradale si afferma come valore giuridico e relazionale, condiviso tra i diversi ordinamenti europei.
Il caso concreto. La Cassazione corregge l’apparenza con l’assiologia
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la Corte d’Appello di Milano aveva attribuito alla passeggera un concorso di colpa del 90%, ritenendo il mancato uso delle cinture come condotta esclusiva e determinante ai fini del danno. Tale impostazione, tuttavia, ometteva ogni valutazione sulla condotta del conducente, ignorando il dovere di verifica e la posizione di garanzia che questi assume nel momento in cui accetta di trasportare terzi.
La Corte di Cassazione interviene censurando il deficit motivazionale della sentenza di merito, richiamando il principio elaborato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 2014, n. 8053) secondo cui la motivazione apparente costituisce vizio rilevante ai fini della legittimità della decisione. Ma la censura non è solo formale: è assiologica. La Cassazione opera una vera e propria correzione sostanziale del giudizio, riaffermando il ruolo attivo del conducente come garante relazionale della sicurezza.
La mancata verifica dell’uso delle cinture da parte del conducente viene qualificata come concausa del danno, imponendo al giudice un giudizio comparativo e sostanziale che tenga conto della cooperazione tra i soggetti coinvolti. La responsabilità civile, in questo contesto, non è solo imputazione postuma, ma valutazione relazionale, fondata sulla prevenzione e sulla tutela effettiva della vita.
Prospettive sistemiche. Verso una riforma normativa, assicurativa e formativa
La sentenza n. 26723/2025 non si esaurisce nella risoluzione del caso concreto: essa apre una riflessione sistemica sulla responsabilità civile come dispositivo di prevenzione e cooperazione. Il dovere attivo di controllo del conducente impone una revisione dei modelli normativi, assicurativi e formativi, orientata a una legalità sostanziale fondata sulla tutela effettiva.
Sul piano normativo, l’art. 169 del Codice della Strada — che disciplina l’uso delle cinture di sicurezza — potrebbe essere integrato con un comma che formalizzi il dovere di verifica del conducente:
“Il conducente è tenuto a verificare che i passeggeri abbiano allacciato le cinture di sicurezza prima dell’avvio e durante la marcia.”
Questa integrazione non introduce un nuovo obbligo, ma cristallizza una responsabilità già riconosciuta dalla giurisprudenza, rafforzando la funzione preventiva della norma e rendendo esplicita la posizione di garanzia del conducente.
Prospettive sul piano assicurativo e formativo
Sul piano assicurativo, le compagnie potrebbero introdurre clausole premiali per i conducenti che dimostrano comportamenti attivi di controllo, valorizzando la prevenzione come criterio di merito. La responsabilità civile, in questo senso, si trasforma da strumento risarcitorio a leva educativa, capace di orientare i comportamenti verso la cura dell’altro.
Sul piano formativo, la preparazione dei conducenti — sia privati che professionali — dovrebbe includere moduli dedicati alla responsabilità relazionale, alla gestione dell’affidamento e alla prevenzione del rischio. La Direttiva 2003/59/CE offre già un quadro utile, ma va integrato con contenuti assiologici e giuridici che restituiscano al conducente la consapevolezza del proprio ruolo di garante.
In questa prospettiva, la sicurezza non è un obbligo tecnico, ma un diritto relazionale, che nasce dalla cooperazione tra soggetti e si realizza nella cura concreta della vita altrui. Il conducente che controlla non limita la libertà del passeggero: la garantisce. E il diritto che lo impone non punisce: educa, protegge, abilita.
Conclusione. La responsabilità civile come cura dell’altro
Il dovere attivo di controllo non può essere ridotto a una mera prescrizione tecnica: esso si configura come norma di legalità sostanziale, espressione di un diritto che non si limita a regolare, ma si fa carico della vita dell’altro. In questa prospettiva, la responsabilità civile non è soltanto strumento di imputazione o risarcimento: è pratica di cura, è educazione alla prevenzione, è costruzione di relazioni fondate sulla fiducia e sulla cooperazione.
Il conducente che verifica l’uso delle cinture non esercita un potere, ma incarna un’etica della responsabilità che si traduce in tutela concreta. Il diritto, quando assume su di sé il compito di educare alla cura, non si limita a sanzionare il danno: lo previene, lo disinnesca, lo trasforma in consapevolezza.
In questo senso, la responsabilità civile realizza la sua funzione più alta: non solo proteggere, ma promuovere la vita. E il diritto, quando protegge la vita attraverso la relazione, cessa di essere solo norma: diventa cultura.
Oltre la sentenza. Per una responsabilità civile generativa
La sentenza n. 26723/2025 non è solo una pronuncia giurisprudenziale: è una proposta culturale. Il diritto che protegge diventa diritto che abilita, trasformando la responsabilità civile in strumento generativo, capace di costruire relazioni giuridiche fondate sulla fiducia, sulla cooperazione e sulla prevenzione.
Il conducente che controlla non esercita un potere limitante: genera sicurezza. E il diritto che gli impone tale controllo non reprime, ma abilita alla cura, orientando la responsabilità civile verso una funzione educativa e sostanziale, capace di anticipare il danno e di promuovere la vita.
In questa prospettiva, quindi, la responsabilità civile non è più solo imputazione o riparazione: è pratica relazionale, è educazione alla legalità sostanziale, è cultura della prevenzione. La 26723/2025 non chiude un caso: apre un paradigma. E il diritto, quando protegge attraverso la relazione, cessa di essere solo norma: diventa civiltà.













