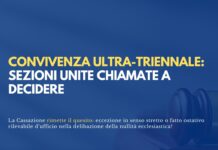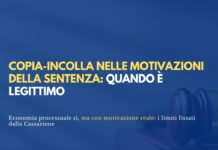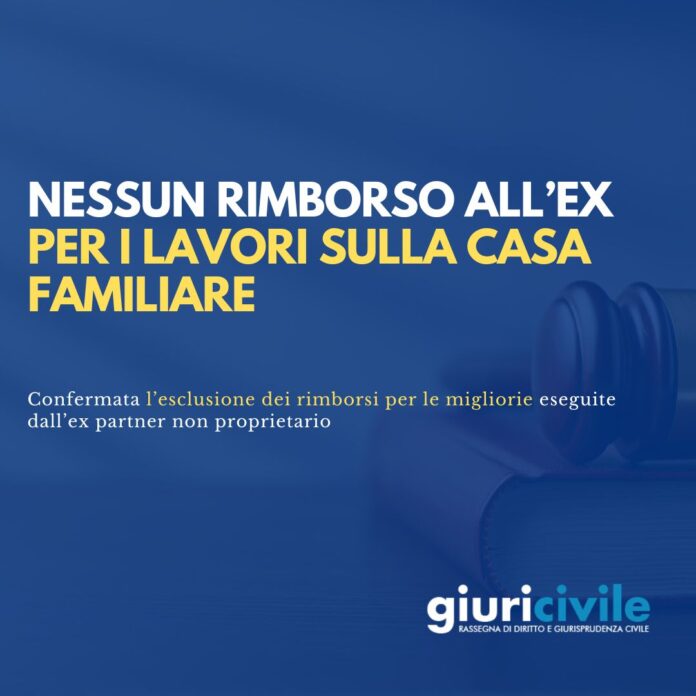
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 28443 del 27 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si è pronunciata su una controversia di particolare complessità sistematica, nella quale si intrecciano profili di diritto dei beni, disciplina del possesso, rapporti familiari e normativa urbanistico-edilizia.
La questione sottoposta al vaglio di legittimità riguarda, in termini essenziali, la qualificazione giuridica della posizione del partner non proprietario che, nel corso della convivenza e nell’ambito della destinazione dell’immobile a casa familiare, abbia eseguito opere migliorative sul bene altrui, rivendicando – all’esito della cessazione del rapporto – il riconoscimento dell’indennità prevista dagli artt. 1150 e 1152 c.c. ovvero, in via subordinata, il rimborso delle spese sostenute, anche a fronte della contestata abusività di parte degli interventi.
Premessa ricostruttiva
La decisione in esame trae origine da una complessa vicenda di rapporti interpersonali e patrimoniali intercorsi tra due soggetti legati da un rapporto di convivenza e, secondo quanto ricostruito nei gradi di merito, da un consolidato legame familiare.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
La controversia investe simultaneamente profili di diritto delle obbligazioni, tutela possessoria e disciplina delle migliorie su bene altrui, ed è connotata da una conflittualità derivante dall’utilizzo di un immobile di proprietà esclusiva della parte attrice, immobile adibito a casa familiare e oggetto di interventi materiali eseguiti dal partner non proprietario.
Le decisioni di merito
L’attrice, proprietaria esclusiva del bene, agisce per ottenere il rilascio dell’immobile e il pagamento di somme a titolo di canoni; il convenuto – poi ricorrente in Cassazione – resiste spiegando una articolata domanda riconvenzionale centrata su tre profili:
- rimborso di quota parte di un mutuo estinto con fondi propri;
- risarcimento del danno per la vendita sottocosto di altro bene di sua proprietà;
- riconoscimento di un’indennità per l’aumento di valore dell’immobile dell’attrice derivante da opere e migliorie eseguite.
Il giudizio si complica ulteriormente nella fase d’appello, nella quale il soccombente introduce, per la prima volta, una domanda di ritenzione ex art. 1152 c.c., a garanzia dell’indennità ex art. 1150 c.c. di cui sostiene di essere titolare. La Corte territoriale, tuttavia, respinge sia la domanda di indennità sia quella di ritenzione, ritenendo insussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicabilità della disciplina relativa al possessore miglioratore. Il ricorrente propone dunque tre motivi di ricorso: sulla ritenzione, sulla qualifica di possessore di buona fede, e sulla rilevanza di opere eventualmente abusive ai fini dell’indennizzabilità.
La questione
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, è dunque investita del nodo cruciale: quale sia la qualificazione giuridica del partner non proprietario che esegua opere migliorative sull’immobile utilizzato come casa familiare, e se tale soggetto possa, in ragione del titolo di fatto sul bene, pretendere le indennità ex artt. 1150 e 1152 c.c. ovvero il rimborso di spese sostenute, anche qualora sia contestata la regolarità urbanistica delle opere.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
La qualificazione giuridica della posizione del partner non proprietario: possesso, detenzione qualificata e diritto personale di godimento
Il cuore sistematico della decisione risiede nella qualificazione del rapporto materiale intercorrente tra il soggetto non proprietario e l’immobile destinato a casa familiare. La Suprema Corte si colloca nell’alveo dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, superando definitivamente i precedenti isolati che riconoscevano al partner non proprietario una posizione di “possessore” ai sensi dell’art. 1140 c.c. La ricostruzione proposta si fonda su un approccio rigorosamente sostanzialistico che distingue il mero potere di fatto sulla cosa dalla animus rem sibi habendi che connota la situazione possessoria.
Si afferma, in linea con Cass. SS. UU, n. 11096/2002, che nel contesto dell’unione familiare – sia matrimoniale che di fatto – il partner non proprietario fruisce dell’immobile in virtù di un diritto personale di godimento di matrice familiare, privo dei caratteri dell’autonomia e alterità rispetto al proprietario che connotano il possesso. Tale situazione, pur potendo assumere forme qualificate di detenzione, non si traduce in signoria sulla cosa, bensì in un godimento funzionale alla comunità domestica. L’abitazione viene vissuta non uti dominus ma uti familiaris, esclusivamente quale luogo di esplicazione della vita congiunta.
Detenzione qualificata e inapplicabilità della disciplina possessoria
La natura “qualificata” della detenzione non implica una promozione al rango di possesso. Al contrario, essa accentua la derivazione del potere di fatto da un titolo negoziale atipico – il patto di convivenza familiare – il quale radica il godimento ma non attribuisce autonomia dominicale. L’effetto sistemico è decisivo: la disciplina degli artt. 1150 e 1152 c.c. presuppone l’esistenza di una situazione possessoria, non essendo estensibile ai detentori, neppure qualificati, data la natura eccezionale e non analogica delle norme.
Questa impostazione costituisce un punto di approdo coerente con l’impianto codicistico: la tutela possessoria e l’indennità per le migliorie si basano su un bilanciamento tra vantaggio materiale del miglioramento e lesione del godimento del possessore; bilanciamento che non può operare ove il soggetto agisca nell’alveo della solidarietà familiare e non come terzo potenzialmente antagonista rispetto al titolare del diritto reale.
Il requisito soggettivo della buona fede e la sua incompatibilità con la detenzione qualificata
La seconda linea argomentativa affronta il tema del possesso di buona fede ex art. 1147 c.c., di cui il ricorrente invoca l’applicabilità per fondare la pretesa all’indennità. La Corte chiarisce che la buona fede rileva esclusivamente ove sia previamente accertato il possesso; ma, stante la negazione di tale qualifica, la verifica del requisito soggettivo si colloca in un piano recessivo. Nondimeno, la Cassazione richiama la motivazione della Corte territoriale che, ad abundantiam, aveva escluso la stessa buona fede materiale del ricorrente, avendo quest’ultimo ricevuto formale diffida alla restituzione fin dal 2011.
In un’ottica sistematica, il ragionamento si inserisce nel solco della giurisprudenza che ritiene la diffida elemento idoneo a interrompere qualsiasi affidamento sulla legittimità del godimento del bene. Dopo la diffida, infatti, l’eventuale prosecuzione delle opere migliorative non può considerarsi frutto di errore scusabile, trasformandosi in attività arbitraria.
Il dato è rilevante anche per un altro profilo: esso esclude qualsiasi possibile qualificazione della posizione del partner non proprietario come detentore “assistito da buona fede”, categoria non prevista dal sistema e non suscettibile di generare posizioni indennitarie analoghe a quelle del possessore.
Le migliorie e le spese sul bene altrui: disciplina delle opere abusive e limiti alla rimborsabilità
Il ricorrente invoca, quale extrema ratio, il rimborso delle spese sostenute per le opere migliorative, indipendentemente dalla qualifica possessoria, sostenendo la natura funzionale delle opere e la loro incidenza positiva sul valore del bene. La Corte respinge la prospettiva, fondandosi su due direttrici interpretative:
- In assenza del possesso, la disciplina dell’indennità per miglioramenti ex art. 1150 c.c. non è applicabile. Il detentore non ha titolo per ottenere la restituzione delle spese, poiché la norma ha natura eccezionale, non applicabile analogicamente ai rapporti di detenzione qualificata.
- La rimborsabilità delle opere incontra un limite invalicabile nella normativa urbanistica. La Corte conferma la valutazione del giudice d’appello secondo cui le opere erano in parte abusive, il che, secondo un consolidato orientamento, impedisce qualsiasi riconoscimento economico. La ratio è duplice: evitare una surrettizia legittimazione di interventi contra legem e scongiurare la creazione di un indebito vantaggio economico derivante da attività illecite.
L’abusività delle opere assume, dunque, una valenza preclusiva assoluta e rafforza ulteriormente la conclusione della Corte: il partner non proprietario non può invocare alcuna tutela economica per opere prive del necessario titolo edilizio.
La ritenzione del bene ex art. 1152 c.c.: struttura, natura e inammissibilità della domanda
Il primo motivo di ricorso attiene al preteso potere di ritenzione del bene sino al pagamento dell’indennità. La Corte di Cassazione fa discendere l’inammissibilità della censura da un duplice profilo, sistematico e processuale.
Sul piano sostanziale, la ritenzione è accessoria al diritto all’indennità: senza indennità, non vi è spazio per la ritenzione. L’art. 1152 c.c. presuppone infatti l’esistenza di un credito da migliorie spettante al possessore, sicché l’esclusione della qualità di possessore rende carente l’interesse ad impugnare, privando il motivo di utilità concreta.
Sul piano processuale, la Corte rileva la tardività della richiesta di ritenzione, formulata solo in appello e, pertanto, inammissibile ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c. Anche questo argomento, pur non decisivo, viene richiamato quale ulteriore conferma della corretta impostazione della Corte territoriale.
Sintesi sistematica degli approdi della sentenza
La pronuncia ribadisce un principio ormai stabilizzato dalla giurisprudenza di legittimità: il partner non proprietario che effettua migliorie sull’immobile utilizzato come casa familiare non è possessore, ma detentore qualificato o titolare di un diritto personale di godimento familiare. Da ciò deriva:
- esclusione dell’indennità ex art. 1150 c.c.;
- impossibilità di esercitare il potere di ritenzione ex art. 1152 c.c.;
- irrilevanza della buona o mala fede ai fini della rimborsabilità;
- preclusione assoluta in presenza di opere abusive.
La sentenza si colloca dunque come ulteriore tassello nel consolidamento di una linea interpretativa che mira a separare nettamente la disciplina possessoria dalle dinamiche interne alla famiglia e alla convivenza, evitando di trasferire nel diritto di famiglia istituti tipici del diritto dei beni che presuppongono un rapporto antagonista tra possessore e proprietario.
Conclusioni
La Cassazione, con ordinanza n. 28443/2025, ribadisce un orientamento solido, sistematicamente coerente e immune da oscillazioni: il partner non proprietario che esegua migliorie sull’immobile destinato a casa familiare non può essere qualificato come possessore e, pertanto, non ha diritto né all’indennità ex art. 1150 c.c., né al correlato potere di ritenzione ex art. 1152 c.c. La natura familiare del godimento, configurabile quale detenzione qualificata, esclude l’applicabilità del paradigma possessore-miglioratore, riservato ai soli casi in cui il soggetto eserciti una signoria autonoma sulla cosa.
La decisione sottolinea altresì il limite invalicabile rappresentato dalla normativa edilizia: l’abusività delle opere impedisce qualsiasi riconoscimento economico, in coerenza con la necessità di evitare che interventi illeciti si traducano in un vantaggio patrimoniale. L’ordinanza rappresenta, dunque, un punto di conferma rigoroso e tecnicamente raffinato di un orientamento volto a impedire che gli istituti del possesso vengano utilizzati per attribuire protezioni patrimoniali a situazioni fondate su vincoli personali e familiari, i quali obbediscono a logiche solidaristiche e non dominicali.