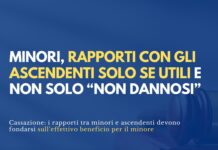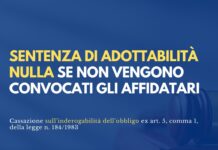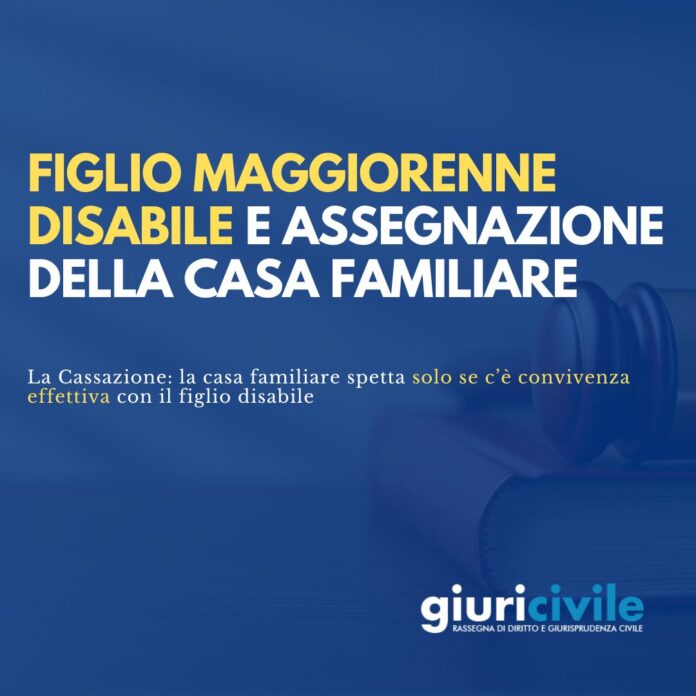
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 23443/2025 (clicca qui per scaricare il PDF della decisione), affronta una questione di notevole rilievo sistematico: la persistenza o meno del diritto all’assegnazione della casa familiare nel caso in cui il figlio maggiorenne, pur portatore di handicap grave, non conviva stabilmente con il genitore assegnatario, essendo ricoverato da tempo in una struttura assistenziale. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Inquadramento sistematico
La pronuncia, resa all’esito del ricorso proposto dal ricorrente (Va.Mi.) avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1639/2023, si colloca nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale concernente l’applicazione dell’art. 337-septies, comma 2, c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) e la correlata interpretazione dell’art. 337-sexies c.c., dettato in tema di assegnazione della casa familiare.
Il caso offre spunti per riflettere sull’estensione del criterio dell’interesse del figlio disabile e sulla nozione di convivenza “attuale” quale presupposto indefettibile per la permanenza dell’assegnazione.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
I fatti di causa e l’iter processuale
Il procedimento trae origine dal giudizio di divorzio tra Va.Mi. (padre) e Sc.An. (madre), da cui era nata la figlia Al., maggiorenne, affetta da oligofrenia moderato-grave con turbe comportamentali.
Il Tribunale di Ancona, pur dichiarando inammissibili le domande relative all’affidamento e al mantenimento della figlia – ormai maggiorenne – mantenne in favore della madre l’assegnazione della casa familiare, ravvisando un interesse della figlia, seppur ricoverata, a conservare un riferimento abitativo stabile.
La Corte d’appello di Ancona confermò tale statuizione: ritenne che la casa familiare rappresentasse ancora l’ambiente affettivo e relazionale di riferimento per la figlia, evidenziando che il ricovero non era stato qualificato dai servizi sanitari come permanente e che sussisteva un progetto di progressivo riavvicinamento della ragazza alla città natale.
Il padre ricorse per cassazione, denunciando violazione degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c., deducendo l’assenza di una convivenza stabile e l’illegittimità dell’assegnazione fondata su un’eventualità futura e incerta.
Il quadro normativo e i principi rilevanti
La decisione ruota attorno alla corretta applicazione degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c., norme cardine del diritto di famiglia riformato dal d.lgs. n. 154/2013.
- Art. 337-sexies c.c.: stabilisce che l’assegnazione della casa familiare è disposta tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli a conservare l’habitat domestico nel quale sono cresciuti, e si estingue quando viene meno tale interesse.
- Art. 337-septies, comma 2, c.c.: estende espressamente le disposizioni previste per i figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, assimilando la loro posizione sotto il profilo della tutela assistenziale e abitativa.
L’interpretazione sistematica di tali norme, consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2670/2023; Cass. n. 21819/2021; Cass. n. 32151/2023), conduce a ritenere che l’assegnazione della casa familiare può essere mantenuta solo in presenza di una effettiva e attuale convivenza tra il figlio (anche disabile) e il genitore assegnatario, la quale giustifichi l’esigenza di continuità dell’habitat domestico.
Ne consegue che l’eventuale cessazione della convivenza stabile – anche se determinata da cause oggettive, quali il ricovero prolungato – comporta il venir meno del presupposto di diritto sostanziale che fonda l’assegnazione.
Potrebbero interessarti anche:
- Assegnazione della casa familiare e comodatario: quando può essere disposta la restituzione?
- Il valore del godimento immobiliare nella revisione dell’assegno divorzile
- Pagare il mutuo non basta: quando serve ancora il mantenimento per i figli
- “Diritto a non nascere se non sani”: non è configurabile
- Amministratore di sostegno: designazione del beneficiario e ruolo del caregiver
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Prima Sezione civile accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, e cassa la sentenza d’appello con rinvio.
La Corte premette che la figlia, essendo portatrice di handicap grave, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 337-septies, comma 2, con conseguente possibilità, in astratto, di assegnazione della casa familiare al genitore convivente.
Tuttavia, l’accertamento del presupposto di convivenza deve essere effettuato “in concreto e nell’attualità”, ossia valutando la situazione esistente al momento della decisione, non potendo fondarsi su mere ipotesi o prospettive future di rientro.
Richiamando il principio espresso da una pronuncia del 2019 (Cass. n. 16134/2019), la Corte ribadisce che la “convivenza rilevante” ai fini dell’assegnazione postula una stabile dimora del figlio nella casa familiare, con esclusione di situazioni in cui il rapporto abitativo sia solo potenziale o eventuale.
Pertanto, la Corte censura la motivazione della Corte territoriale, che aveva dato rilievo a un futuro incerto rientro della figlia e non alla realtà attuale del ricovero in struttura residenziale.
La Cassazione formula il seguente principio di diritto:
“In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni”.
L’interesse del figlio disabile tra tutela potenziale e attualità del diritto
La pronuncia offre l’occasione per riflettere sulla tensione tra il principio di tutela dell’interesse del figlio disabile e la necessaria attualità del presupposto di convivenza.
La Corte evita di scivolare in un’interpretazione solidaristica svincolata da parametri giuridici, riaffermando che l’assegnazione della casa familiare non costituisce un diritto reale autonomo del genitore, ma una misura funzionale all’interesse concreto del figlio.
Il diritto di godimento della casa familiare si configura, pertanto, come strumentale e temporaneo, destinato a venir meno con l’estinzione della funzione abitativa riferibile al minore (o al maggiorenne disabile).
In assenza di una convivenza effettiva e continuativa, non può sopravvivere un’assegnazione basata su un mero “collegamento affettivo” o sull’auspicio di un futuro rientro, poiché ciò comporterebbe un’indebita compressione del diritto di proprietà dell’altro coniuge ex art. 42 Cost.
Sotto il profilo sistematico, la Cassazione ribadisce dunque la necessità di un bilanciamento concreto tra:
- l’interesse primario del figlio disabile alla stabilità affettiva e abitativa;
- e il diritto del genitore non assegnatario a non subire un vincolo sproporzionato e privo di attualità.
Considerazioni critiche e rilievi sistematici
L’ordinanza si muove nel solco di un orientamento che tende a razionalizzare la tutela della casa familiare, sottraendola a logiche di automatismo e riportandola entro i confini dell’effettività del legame abitativo.
In tal senso, la Corte si mostra coerente con la giurisprudenza che ha chiarito come l’assegnazione debba essere funzionale alla cura e alla convivenza, non potendo trasformarsi in una misura assistenziale indiretta a beneficio del genitore.
Tuttavia, non mancano profili problematici.
Il criterio dell’attualità rischia, infatti, di sacrificare l’interesse di soggetti particolarmente fragili, come i figli disabili ricoverati, per i quali la stabilità del “domicilio affettivo” può mantenere un valore psicologico e simbolico anche in assenza di coabitazione continuativa.
In tali ipotesi, una valutazione troppo formalistica del requisito di convivenza potrebbe tradursi in una riduzione della tutela sostanziale che l’art. 337-septies, comma 2, intende garantire.
Una possibile via intermedia, che il giudice del rinvio dovrà considerare, consiste nell’accertare se permanga un effettivo legame funzionale tra il figlio disabile e la casa familiare, anche sotto il profilo terapeutico o riabilitativo, purché tale legame non si traduca in una mera aspettativa di ritorno priva di basi concrete.
Conclusioni
La sentenza n. 23443/2025 si segnala per la chiarezza del principio di attualità nella verifica della convivenza, riaffermando che l’assegnazione della casa familiare, anche in favore del genitore convivente con figlio disabile, non può fondarsi su prospettive future o su interessi meramente potenziali.
La Corte di cassazione ribadisce, in tal modo, che la tutela del figlio maggiorenne disabile non si traduce in una perpetuazione automatica del diritto di godimento della casa familiare, ma richiede un accertamento concreto e attuale dell’effettiva funzione abitativa dell’immobile.
Si tratta di una pronuncia che contribuisce a delimitare l’ambito applicativo dell’art. 337-septies c.c., valorizzando il principio di proporzionalità e la tutela bilanciata dei diritti costituzionali coinvolti (artt. 2, 3, 29 e 42 Cost.).
Il rinvio alla Corte d’appello di Ancona impone dunque una nuova valutazione in fatto, volta a stabilire se sussista ancora un legame effettivo tra la figlia e la casa familiare, quale condizione imprescindibile per mantenere l’assegnazione in favore della madre.