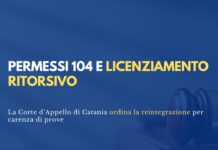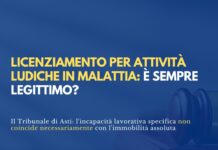La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025 (che puoi leggere cliccando qui), ha affrontato la questione della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e dell’inclusione delle voci retributive. La pronuncia ribadisce il principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 2120 c.c., stabilendo che l’esclusione di specifici emolumenti è ammessa solo tramite clausola contrattuale chiara e inequivoca.
Consiglio: per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”, a cura di Federico Torzo (clicca qui per iscriverti).
Premessa
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30331/2025, pubblicata il 17 novembre 2025, affronta un tema di grande rilevanza sistemica e pratica: la determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e la questione dell’inclusione o esclusione di specifiche voci retributive. La vicenda origina dal ricorso di un gruppo di lavoratori nei confronti della propria ex datrice di lavoro, con riferimento al CCNL Autostrade e Trafori, e si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 2120 c.c. e sul delicato equilibrio tra disciplina legale e autonomia collettiva.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
La pronuncia si colloca nel solco di un’articolata dialettica interpretativa, segnata dalle oscillazioni delle corti di merito e dalle prerogative della contrattazione collettiva nel regolare le voci remunerative utili alla formazione della retribuzione ai fini del TFR. La Corte, richiamando precedenti autorevoli riafferma con forza il principio di onnicomprensività della retribuzione, chiarendo che l’esclusione di determinate voci è ammissibile soltanto se espressamente prevista e delimitata dal CCNL in maniera univoca.
L’obiettivo di questa nota è mettere in luce come l’ordinanza non si limiti a risolvere il caso concreto, ma si configuri quale contributo interpretativo di rilievo sistematico, destinato a incidere sulla tutela dei lavoratori e sulla prassi aziendale e contrattuale, rafforzando al contempo la certezza del diritto e la funzione regolativa della contrattazione collettiva.
La quaestio iuris
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione si sviluppa lungo tre gradi di giudizio, evidenziando la tensione interpretativa tra il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 2120 c.c. e le clausole derogatorie della contrattazione collettiva. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la computabilità, ai fini del TFR, di numerose voci retributive corrisposte con continuità – tra cui lavoro supplementare, straordinario, indennità per turni sfalsati, richiamo in servizio e trattamenti economici di trasferta – aderendo a una lettura estensiva della norma codicistica, che include nella base di calcolo tutte le somme non occasionali, con esclusione dei rimborsi spese.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3397/2023, ha invece riformato integralmente la decisione, rigettando le domande dei lavoratori e sostenendo che il CCNL Autostrade e Trafori, avendo individuato espressamente gli elementi della retribuzione computabili, avesse implicitamente escluso tutte le altre voci. Tale impostazione, oltre a restringere la nozione di retribuzione utile, ha erroneamente posto a carico dei ricorrenti l’onere di dimostrare la computabilità degli emolumenti.
Avverso tale pronuncia, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 2120 c.c., l’errata interpretazione delle disposizioni contrattuali e l’omesso esame di fatti decisivi già oggetto di discussione in primo grado.
Potrebbero interessarti anche:
- Retribuzione ferie: quando includere indennità fisse nel calcolo
- TFR in Fondo Pensione e assegno divorzile: i limiti del diritto alla quota
I principi affermati dalla Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30331/2025, ha accolto il ricorso dei lavoratori, cassando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. La pronuncia si distingue per la chiarezza con cui riafferma alcuni principi fondamentali in materia di trattamento di fine rapporto, delineando un quadro interpretativo di sistema.
In primo luogo, la Corte ribadisce il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 2120 c.c., secondo cui la retribuzione annua deve includere tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo non occasionale e non di rimborso spese. Tale regola generale, già consolidata nella giurisprudenza di legittimità, viene riaffermata con forza, a presidio della tutela del lavoratore e della certezza del diritto.
In secondo luogo, la Cassazione chiarisce i limiti delle deroghe contrattuali: l’esclusione di determinate voci dal computo del TFR è ammissibile soltanto se la contrattazione collettiva lo dispone in modo espresso e univoco. Non è sufficiente, dunque, un’elencazione parziale delle voci computabili per dedurre, a contrario, l’esclusione delle altre. L’errore della Corte d’Appello è stato quello di trasformare una semplice elencazione descrittiva in una deroga implicita, in contrasto con il dettato codicistico.
Accertamento ex post e onere della prova
La Corte sottolinea inoltre la necessità di un accertamento ex post: il giudice di merito deve verificare se gli emolumenti contestati siano stati corrisposti con carattere di continuità e corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa, così da escluderne la natura occasionale. Tale indagine è particolarmente rilevante per voci come lo straordinario o le indennità di trasferta, che in astratto possono apparire variabili, ma che, se erogate con regolarità, assumono natura retributiva e devono concorrere alla formazione del TFR.
Infine, la Cassazione ridefinisce la ripartizione dell’onere della prova: non spetta ai lavoratori dimostrare la computabilità delle singole voci, bensì a chi invoca l’esclusione provare l’esistenza di una clausola contrattuale derogatoria chiara e inequivoca. In ossequio all’art. 2697 c.c., è il datore di lavoro a dover fornire la prova della deroga, mentre al lavoratore è sufficiente allegare la corresponsione continuativa e non occasionale degli emolumenti.
Ebbene, l’ordinanza in commento si configura come un importante contributo interpretativo, volto a rafforzare la tutela dei lavoratori e a garantire uniformità applicativa. Essa riafferma la preminenza del principio di onnicomprensività del TFR, subordinando ogni deroga alla contrattazione collettiva a una previsione espressa e all’onere probatorio a carico del datore di lavoro. La decisione avrà inevitabili ricadute sulla prassi aziendale e sul contenzioso, imponendo maggiore attenzione nella redazione delle clausole contrattuali e nella gestione delle indennità accessorie.
Commento critico
L’ordinanza della Cassazione n. 30331/2025 non si limita a ribadire principi già consolidati, ma segna un passaggio significativo nella dialettica tra legge e contrattazione collettiva. Il vero valore della pronuncia risiede nella sua capacità di ricondurre la disciplina del TFR a un quadro di certezza normativa, evitando che interpretazioni restrittive dei CCNL possano ridurre la tutela del lavoratore attraverso esclusioni implicite.
Il punto di forza della decisione è la riaffermazione della funzione garantista dell’art. 2120 c.c., che si pone come norma di chiusura del sistema: la retribuzione utile al TFR è “onnicomprensiva” e solo una deroga chiara e inequivoca può limitarne la portata. In questo modo, la Corte neutralizza il rischio di un uso strumentale della contrattazione collettiva volto a comprimere diritti patrimoniali maturati nel tempo.
Sul piano sistemico, l’ordinanza valorizza il ruolo della contrattazione collettiva, ma ne delimita la responsabilità: le parti sociali possono incidere sulla base di calcolo del TFR, ma devono farlo con formulazioni espresse e trasparenti, assumendo consapevolmente il peso di una scelta che incide sulla posizione economica dei lavoratori. Ciò rafforza la funzione regolativa del CCNL, ma al tempo stesso ne impone una maggiore precisione redazionale.
Non mancano, tuttavia, profili di criticità. La richiesta di un accertamento ex post sulla natura “non occasionale” degli emolumenti rischia di alimentare un contenzioso diffuso, affidando al giudice di merito valutazioni complesse e caso per caso. Questo elemento, se da un lato garantisce equità sostanziale, dall’altro può ridurre la prevedibilità delle decisioni e aumentare l’incertezza per le imprese.
In prospettiva, la pronuncia apre un dibattito dottrinale e giurisprudenziale destinato a incidere sulla contrattazione collettiva e sulla prassi aziendale. Essa rafforza la tutela dei lavoratori, ma sollecita al contempo una riflessione sulla necessità di clausole contrattuali più chiare e di una disciplina legislativa che riduca gli spazi di discrezionalità giudiziale.
Conclusioni
L’ordinanza in rassegna rappresenta un punto fermo nel dibattito sulla determinazione della base di calcolo del TFR. La Suprema Corte riafferma la centralità del principio di onnicomprensività sancito dall’art. 2120 c.c., chiarendo che solo una clausola contrattuale espressa e inequivoca può derogare a tale regola. Al tempo stesso, ridefinisce l’onere della prova, ponendolo a carico del datore di lavoro, e impone al giudice di merito un accertamento ex post sulla natura non occasionale degli emolumenti.
La decisione rafforza la tutela dei lavoratori e contribuisce a consolidare un orientamento giurisprudenziale volto a garantire uniformità e certezza applicativa. Essa impone alle imprese una maggiore attenzione nella gestione delle indennità accessorie e nella redazione delle clausole contrattuali, che dovranno essere formulate con chiarezza per evitare contenziosi.
In prospettiva, l’ordinanza non si limita a risolvere il caso concreto, ma si configura come un contributo interpretativo di sistema, destinato a incidere sulla prassi aziendale e sulla contrattazione collettiva. Il suo impatto sarà duplice: da un lato, rafforzare la posizione dei lavoratori nella maturazione del TFR; dall’altro, stimolare le parti sociali a una più consapevole e trasparente regolazione delle voci retributive.