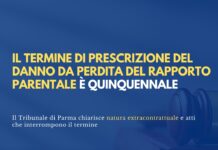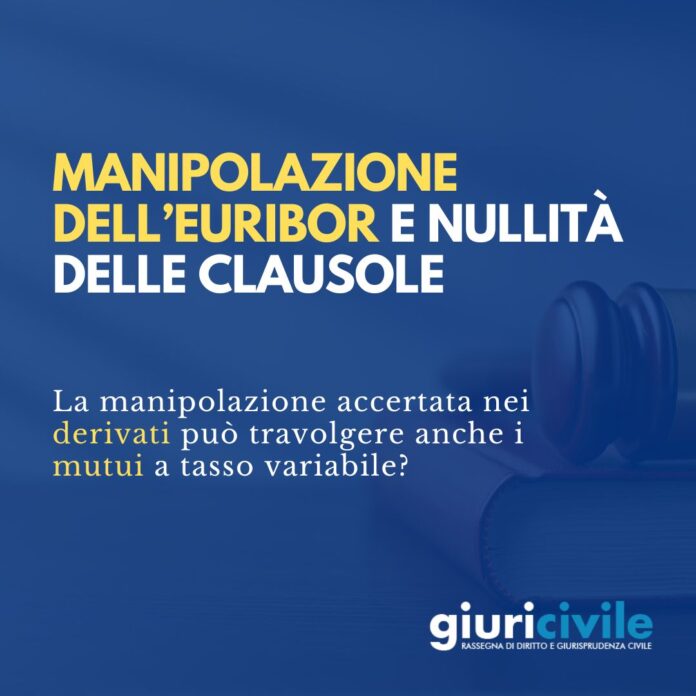
Nel presente documento si esamina la questione relativa all’efficacia della decisione con la quale la Commissione Europea abbia accertato l’illegittimità (nullità di pieno diritto) di un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”).
Ci si chiede, in particolare, se l’accertamento, eseguito in relazione ad un contratto avente per oggetto strumenti derivati, della nullità di una clausola, concordata tra alcune banche attraverso un’intesa e con la quale il tasso di interesse veniva parametrato ad un indice Euribor “manipolato”, possa comportare automaticamente anche la nullità della clausola, inserita in un contratto di mutuo a tasso variabile e quindi relativa ad una diversa fattispecie negoziale, con la quale il tasso era stato anch’esso determinato in base al medesimo criterio, pur se la banca titolare di questo secondo contratto non sia stata “parte” dell’intesa.
Orientamenti giurisprudenziali a confronto
La Cassazione Sezione Prima Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024, aveva affrontato la seguente questione relativa alla validità delle clausole di determinazione degli interessi a fronte dell’accertata illegittimità di intese restrittive della concorrenza dirette ad alterare l’Euribor poste in essere dalle banche, accertamento che era stato effettuato dalla Commissione Europea con due decisioni, una del 2013 ed una del 2016, entrambe riguardanti il mercato dei “derivati”:
se l’accertamento, da parte della Commissione, dell’illegittimità, posta in essere mediante un’intesa restrittiva della concorrenza, della clausola di un determinato contratto bancario (derivati), abbia efficacia limitata al caso di specie, oppure debba necessariamente estendersi anche a fattispecie contrattuali (mutui a tasso variabile) diverse da quella oggetto dell’accertamento, pur se tali fattispecie abbiano interessato una banca la quale non è stata “parte” dell’intesa.
Nella suddetta ordinanza, la Prima Sezione aveva sostenuto quanto segue: l’intesa restrittiva ha riguardato un mercato (quello dei derivati) diverso da quello oggetto del giudizio (ossia mutui a tasso variabile), e quindi i contratti di mutuo non possono considerarsi “a valle” rispetto all’intesa illecita, soprattutto nell’ipotesi in cui il mutuante sia stato estraneo a quest’ultima.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi”.

Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi
Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli?
A questi e ad altri interrogativi risponde Monica Mandico in questo pratico fascicolo che vuole offrire una guida accessibile per chiunque desideri comprendere e affrontare questa problematica, evitando i rischi di procedimenti legali mal gestiti e aumentando le possibilità di recupero dei danni subiti attraverso l’analisi delle normative, delle sentenze e delle strategie legali più efficaci.
Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.
Leggi descrizione
Monica Mandico, 2024, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €

Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi
Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli?
A questi e ad altri interrogativi risponde Monica Mandico in questo pratico fascicolo che vuole offrire una guida accessibile per chiunque desideri comprendere e affrontare questa problematica, evitando i rischi di procedimenti legali mal gestiti e aumentando le possibilità di recupero dei danni subiti attraverso l’analisi delle normative, delle sentenze e delle strategie legali più efficaci.
Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.
Tuttavia la stessa Sezione aveva sentito il bisogno di rinviare la questione al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle SSUU, in quanto, in merito, la Sezione Terza aveva affermato principi diversi, ossia: dal divieto di cui all’art. 2 della Legge 287/90, discende la nullità di “qualunque” contratto a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte, anche laddove il mutuante non abbia partecipato all’intesa (ordinanza n. 34889 del 13.12.2023); la dichiarazione di nullità di un contratto concluso “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza presuppone che lo stesso costituisca “applicazione” dell’illecita stessa (sentenza n. 12007/2024).
La Corte d’appello di Cagliari (ordinanza del 24.01.2025) ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione se l’accertamento dell’illiceità della clausola, inserita in un contratto di derivati, con la quale il tasso di interesse era stato determinato in relazione all’indice EURIBOR, abbia effetto solo per tale contratto, oppure si estenda anche ad altri contratti (mutui a tasso variabile).
A seguito di tale rinvio alla CGUE, le Sezioni Unite Civili, con ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15.03.2025, hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.
L’art. 101 TFUE stabilisce l’illegittimità comunitaria (nullità di pieno diritto) di tutti quegli accordi tra imprese e/o delle pratiche concordate che “possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”.
Potrebbero interessarti anche:
- Euribor: riflessioni e conseguenze per mutui e prodotti derivati
- Mutuo solutorio: la sentenza delle Sezioni Unite
- Mutuo “condizionato” con costituzione deposito irregolare: le Sezioni Unite
Tesi secondo cui la nullità di una intesa ha efficacia limitata al contratto al quale la clausola (oggetto dell’intesa stessa) si riferisce
In materia di diritto internazionale privato (Regolamento CE 593 del 17.06.2008), l’art. 28 delle Premesse prevede quanto segue: “è importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi”.
I c.d. “derivati” sono “strumenti finanziari” il cui valore dipende da un’attività sottostante. Essi, pertanto, rientrano appieno nella definizione di cui all’art. 28 sopra citato.
La rivendicata specificità dei suddetti contratti dovrebbe allora comportare, per coerenza, che la declaratoria di illegittimità di una clausola ad essi afferente rimanga applicabile solo ai medesimi, senza potersi estendere ad altri contratti bancari di diversa natura (mutui a tasso variabile). Prevedere tale specificità e poi pretendere che la riconosciuta illegittimità di una clausola relativa a tali “particolari e specifici” contratti investa anche fattispecie negoziali di tipo diverso (appunto, i suddetti mutui), significa adottare una soluzione contraddittoria: un contratto, se è specifico, lo deve essere sempre, soprattutto quando viene sancita l’invalidità di una clausola in esso contenuta.
Se guardiamo alla disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), a norma dell’art. 117 comma 8, “la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli.” In ambito bancario, la nullità di un contratto non deriva, necessariamente, dalla violazione di prescrizioni dettate, in maniera generalizzata, per “tutti” i contratti; essa può derivare anche dalla non conformità del medesimo ad una determinata tipologia di negozio stabilita dalla Banca d’Italia. Pertanto, è pienamente legittimo che la nullità di una clausola produca effetti solo in riferimento a “quel” contratto, senza estendersi a “tutte” le fattispecie negoziali alle quali la medesima clausola è applicabile.
Per quanto riguarda il diritto UE, e, segnatamente, l’efficacia delle decisioni della Commissione adottate in merito alla violazione del principio di concorrenza, va rilevato quanto segue.
La nullità della clausola con la quale, nei contratti aventi ad oggetti strumenti finanziari derivati, il tasso di interesse EURIBOR è stato manipolato, non è stata accertata dalla Commissione in maniera diretta, e cioè mediante un’indagine a vasto raggio su quelle che erano le clausole di determinazione del tasso di interesse applicate nei diversi contratti bancari (e quindi anche in quelli di mutuo a tasso variabile). La Commissione ha potuto procedere al suddetto accertamento solo perché ha rilevato la presenza di un accordo fraudolento tra “alcuni” operatori bancari, e non perché essa abbia effettuato una ricognizione “a tappeto” – o comunque basata su un “discreto campione” – della disciplina dei tassi di interesse applicati dalle banche in un determinato periodo. Ma del resto la Commissione – è questo il punto – non avrebbe potuto esercitare simile controllo, essendo quest’ultimo di competenza del c.d. “Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)”, istituito nel 2010 fra tutti gli Stati aderenti all’Unione europea e dall’Unione bancaria, della quale fa parte la BCE.
Ebbene, quest’ultima, ai sensi dell’art. 130 del TFUE, non può “… accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione”, e, d’altra parte, tali istituzioni ed organismi “si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti”.
Inoltre, a norma dell’art. 103 dello stesso TFUE, i poteri che la Commissione, in materia di tutela della concorrenza può esercitare in materia di tutela della concorrenza sono essenzialmente “propositivi”, in quanto poi l’adozione degli atti normativi con i quali il principio stesso deve essere attuato e tutelato è di competenza del Consiglio. Di conseguenza, attribuire alle decisioni della Commissione una “applicabilità generale”, ossia un’efficacia estesa anche a rapporti contrattuali (contratti di mutuo a tasso variabile) diversi da quelli che ne sono stati oggetto (contratto avente ad oggetto strumenti derivati), non appare molto coerente con la funzione “meramente propositiva”, e non decisionale, che la Commissione si trova a poter esercitare in materia di concorrenza.
Pertanto, la sfera di attribuzioni della Commissione Europea in materia di concorrenza è limitata all’individuazione delle clausole le quali siano state approvate mediante le intese ex art. 101 TFUE, e non può estendersi alla declaratoria di nullità di “tutte” le clausole, ossia anche di quelle contenute nei contratti sottoscritti da banche le quali non siano state “parti” dell’intesa stessa.
Tesi secondo cui la nullità di una intesa si estende anche a contratti diversi da quello al quale la clausola (oggetto dell’intesa stessa) si riferisce
L’art. 101 comma 1 TFUE, nel disciplinare i casi di intese lesive del principio di concorrenza, indica come tali, alla lettera D), quelle intese le quali consistano nell’ “applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.”
Stessa disposizione è prevista, per quanto riguarda il diritto interno, dall’art. 2 comma 2 lett. D) della Legge 287/1990.
L’equivalenza tra due prestazioni può essere data (anche) dal fatto che il criterio utilizzato per quantificare l’ammontare di quanto dovuto è, in entrambi i casi, il medesimo: due contratti possono anche avere ciascuno un diverso nomen juris (“derivati” e “mutuo a tasso variabile”), ma se poi il metodo di determinazione del valore delle due prestazioni (valore che, nel nostro caso, è rappresentato dal tasso di interesse EURIBOR) risulta essere lo stesso, nella sostanza si ha una “equivalenza” tra le medesime, indipendentemente dalla differente tipologia contrattuale.
Nel caso di specie, la clausola di determinazione del tasso Euribor è stata dichiarata illecita in relazione ad un contratto avente ad oggetto strumenti derivati, ma il medesimo tasso è stato utilizzato anche in un contratto di mutuo.
Il principio stabilito dalla norma è quello per cui due prestazioni “equivalenti”, l’una oggetto di un contratto e l’altra oggetto di un differente contratto, debbono essere disciplinate nello stesso modo, al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti tenuti ad eseguire l’una e l’altra prestazione.
Quindi, se, a beneficio di chi era tenuto ad eseguire la prestazione del primo contratto (derivato), è stata sancita l’illegittimità di una clausola con la quale tale prestazione era stata disciplinata, il medesimo beneficio dovrà essere riconosciuto, proprio in virtù dell’equivalenza sopra citata, anche a chi, pur titolare di un secondo contratto di tipo diverso (mutuo), è vincolato alla stessa prestazione.
Il comma 3 dell’art. 101 TFUE prevede che la nullità ivi prevista può essere dichiarata non applicabile alle intese le quali, “pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva”, “contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico”.
Tale principio, applicato all’ambito delle clausole contrattuali, comporta che l’intesa restrittiva della concorrenza cessa di essere illegittima soltanto se produce, quale risultato, quello di un “miglioramento generale” del settore, sotto il profilo di un maggior soddisfacimento degli interessi di “tutti” gli utenti di un determinato servizio, e cioè di “tutti” i contraenti della medesima impresa (banca), a prescindere quindi dalle differenti tipologie di contratti con questa stipulati. Di conseguenza, come una clausola, stabilita a seguito della sottoscrizione di un’intesa lesiva della concorrenza, può non essere dichiarata nulla quando essa arrechi beneficio a “tutti” i contraenti di uno stesso operatore economico, così la declaratoria di nullità della medesima, pur se abbia riguardato soltanto una determinata tipologia contrattuale (derivati), non potrà che estendersi anche a beneficio di coloro che siano parte di un diverso contratto (mutuo a tasso variabile) concluso con lo stesso operatore e nei confronti dei quali la stessa clausola dovrebbe essere applicata.
La “protezione del consumatore”, ex art. 4 TFUE, è oggetto di competenza legislativa concorrente con gli Stati membri, ed inoltre costituisce, ai sensi dell’art. 11 del medesimo, criterio primario al quale l’UE deve attenersi “nella definizione e nell’attuazione di altre politiche o attività”. Quindi, il consumatore, se rappresenta per l’UE un soggetto “da proteggere”, dovrebbe poter beneficiare della declaratoria di nullità di una clausola la quale abbia disciplinato, in modo appunto illegittimo, lo stesso oggetto (tasso di interesse) della prestazione alla quale egli è tenuto, anche se questa prestazione è stata inserita in un contratto (mutuo) di tipo diverso da quello interessato dalla suddetta declaratoria.
Sempre restando in tema di tutela europea dei consumatori, la Direttiva 93/13/CEE – la quale disciplina le clausole abusive nei contratti stipulati con questi ultimi – prevede (nelle Premesse) la necessità di fissare “in generale” i criteri per valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali: da ciò si ricava che l’abusività, e quindi l’illiceità di una clausola, seppur accertata in relazione ad una determinata fattispecie negoziale, deve estendersi (“generalità”) anche a tutti i contratti che su di essa si sono basati per determinare l’ammontare della prestazione dovuta dal consumatore.
Sempre nelle Premesse, si stabilisce che le persone o le organizzazioni che in base alla legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro “inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori” e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un’autorità giudiziaria od un organo amministrativo. Se gli organismi operanti a tutela dei consumatori sono legittimati ad intraprendere, a tutela di questi ultimi, azioni giudiziarie od amministrative volte ad evitare che clausole considerate abusive vengano inserite in “tutti” i contratti sottoscritti dai medesimi, ciò vuol dire che la decisione con la quale la Commissione Europea abbia accertato l’abusività della clausola deve, necessariamente, estendersi a “tutti” i contratti, e quindi anche a quelli che non sono stati oggetto di tale accertamento. Sarebbe contraddittorio attribuire, alle associazioni di difesa dei diritti dei consumatori, la legittimazione ad agire per far eliminare, da “tutti” i contratti, la clausola abusiva, e poi limitare al solo caso di specie l’efficacia del provvedimento comunitario con il quale l’abusività è stata acclarata.
Passando all’esame della questione sotto il profilo del diritto interno, l’art. 4 della Legge 287 del 1990 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – stabilisce che l’Autorità può autorizzare intese vietate quando queste diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i “consumatori”.
La Legge sopra citata non fornisce una definizione di “consumatore”, e quindi può venire in soccorso il criterio di cui all’art. 3 del Codice del Consumo, il quale qualifica il “consumatore” come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Si tratta, quindi, di una qualificazione “generica”: “consumatore” è colui che beneficia dei servizi offerti dal professionista, indipendentemente dalla tipologia di contratto da egli sottoscritta. Quindi, l’art. 4, quando prevede che le intese vietate possano essere autorizzate solo allorquando producano benefici per i “consumatori”, fa riferimento a “tutti” i consumatori, e pertanto, le medesime, se producono effetti vantaggiosi solo per una ristretta cerchia di questi ultimi (vedi i titolari di contratti di mutuo a tasso variabile), non possono essere autorizzate. Pertanto, se l’autorizzazione di un’intesa vietata può essere concessa solo ove quest’ultima, nonostante la sua illegittimità, vada a beneficio di “tutti” gli utenti (i “consumatori”, appunto) di un determinato servizio (in tal caso, bancario), dovrebbe valere anche il principio inverso: la declaratoria di nullità di una clausola, che sia stata stabilita a seguito della medesima intesa, comporta la decisione di “non autorizzare” quest’ultima, e tale decisione, a sua volta, non può che andare a beneficio di “tutti” coloro che fruiscono di quel servizio, anche se con una tipologia negoziale differente (mutui a tasso variabile).
L’art. 117 comma 4 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) stabilisce la nullità delle “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse”.
La ratio della norma si rinviene nel principio di gerarchia delle fonti normative contenuto nell’art. 8 delle Preleggi: questo, infatti, dispone che “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”.
La nullità viene sancita dall’art. 117 comma 4 non già in relazione a particolari, determinate, fattispecie negoziali, bensì in riferimento alla “generalità” dei contratti: qualsiasi clausola quantifichi il tasso di interesse mediante rinvio agli “usi”, è destinata ad essere qualificata come illegittima, e ciò vale per “tutti” i contratti bancari.
Ebbene, l’illegittimità della clausola di determinazione del tasso, se si estende a “tutti” i contratti quando essa deriva dal rinvio agli “usi”, dovrà, coerentemente, avere tale effetto estensivo anche – anzi, a maggior ragione – quando essa derivi dalla contrarietà della clausola stessa alla “legge”, la quale è gerarchicamente sovraordinata rispetto agli “usi” (“legge” che in tal caso è costituita dall’art. 101 TFUE).
Sempre restando nell’ambito del Testo Unico Bancario, l’art. 118 prevede che la banca ha facoltà di modificare unilateralmente il tasso solo nei contratti a tempo indeterminato e non anche in quelli a tempo determinato. Esso, infatti, in merito a questi ultimi, così dispone: “la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse”.
L’ammissibilità di una differente disciplina dei tassi di interesse a seconda delle fattispecie contrattuali, è prevista solo laddove i due contratti divergano non per quanto attiene alla tipologia (di derivati l’uno e di mutuo l’altro), ma per quel che riguarda la loro durata.
Da ciò si desume che l’accertamento dell’illegittimità di una clausola relativa alla quantificazione del tasso di interesse, sebbene abbia riguardato solo un determinato contratto (derivati), si estende anche ad altre tipologie contrattuali (mutuo) interessate dalla medesima clausola.