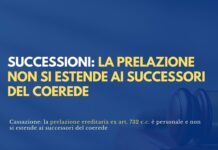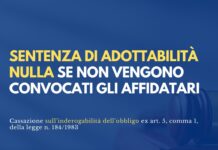Il portato normativo dell’art. 476 c.c. è orientato nel senso di qualificare come accettazione tacita dell’eredità qualsiasi atto che l’erede non potrebbe compiere se non assumente, anche implicitamente, la qualità di erede e che sia, pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciarvi. Par ovvio che il compimento di un atto, da parte del chiamato all’eredità, di natura dispositiva del bene oggetto del relitto successorio, importa un’accettazione dell’eredità, poiché si presume, da parte del legislatore, che colui che non voglia accettarla non compirebbe alcun atto dispositivo al riguardo.
Consiglio: il “Manuale pratico per la successione testamentaria e le donazioni”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria.

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Leggi descrizione
Riccardo Mazzon, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
La valutazione di fatto compiuta dal giudice
Per qualificare un atto compiuto dal chiamato all’eredità come accettazione tacita della medesima, è necessario svolgere un’indagine caso per caso. Nel senso, cioè, che la produzione giurisprudenziale che si è gemmata circa il novero degli atti ovvero dei comportamenti che sono stati, poi, sussunti nell’alveo dell’art. 476, c.c., è frutto di una valutazione effettuata, caso per caso, dal giudicante.
Trattasi di un’indagine di fatto che il giudicante, in funzione di elementi fattuali, documentali e presuntivi, compie al fine di acclarare se l’atto compiuti dal chiamato all’eredità possa qualificarsi come una forma d’accettazione della stessa.
In tal direzione, giova rammentare che la giurisprudenza ha precisato che l’indagine in esame debba esser compiuta sulla base di due elementi: il primo di natura soggettiva ed il secondo di natura oggettiva.
- Quanto al primo, occorre indagare l’animus, ossia l’intenzione che presiede al compimento dell’atto, nel senso, cioè, di accertare la finalità di quest’ultimo, se, perciò, sia finalizzato a mutare lo status da chiamato all’eredità a erede.
- Quanto al secondo, invece, è la natura dell’atto in sé a deporre sul suo inquadramento nell’alveo di quegli atti che possono ben definirsi come forme di accettazione tacita dell’eredità.
Cosa ha chiarito la Cassazione a riguardo?
La Suprema Corte, in effetti, ha precisato che:
“…chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere…” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 24378 del 2 settembre 2025).
Cosicché, alla luce degli indici sintomatici, rilevatori, unitamente alle circostanze fattuali, sia dell’animus sia della finalità oggettiva dell’atto compiuto dal chiamato all’eredità, ben si potrà qualificarlo o meno come un’accettazione dell’eredità ai sensi dell’art. 476, c.c.
La stipulazione di un preliminare di vendita immobiliare da parte dei promittenti eredi del loro dante causa può essere qualificato come un’accettazione tacita dell’eredità (ne abbiamo parlato qui). Parimenti, la costituzione in giudizio del chiamato all’eredità, al fine di contestare la pretesa esperita dal creditore dell’originario debitore, atto che non sarebbe legittimato a compiere se non chi assuma la qualità di erede, può esser qualificata come accettazione tacita dell’eredità (ne abbiamo parlato qui).
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
Il pagamento degli oneri condominiali
Ed è proprio facendo applicazione di queste regole ermeneutiche che la giurisprudenza di merito ha implementato in novero degli atti che se compiuti dal chiamato all’eredità vengono sussunti nell’alveo della fattispecie d’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476, c.c. Questo perché, nella casistica degli atti che possono esser qualificati come accettazione tacita dell’eredità ben si può annoverare, tra l’altro, anche il pagamento degli oneri condominiali.
Il Giudicante sulla base di una valutazione complessiva del compendio documentale, quale la denuncia di successione, la voltura castale ed il pagamento degli oneri condominiali, pertinenti ad un immobile oggetto di successione ereditaria, sono atti che ben possono essere apprezzati quali indici sintomatici della volontà d’accettare l’eredità.
In tal direzione, il Tribunale di Roma, anche di recente, ha affermato, tra l’atro, che:
“…la denuncia di successione, seguita dalla voltura catastale effettuata nello stesso anno di apertura della successione, la collocazione della residenza presso l’immobile ereditato, la stipula di un contratto di locazione registrato e il pagamento di oneri condominiali, sono condotte che evidenziano una chiara volontà di disporre del bene caduto in successione, così da integrare accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c….” (Trib. di Roma, Sez. VIII, Sent. 3 novembre 2025 – Rg.5339/2025).
Riconoscimento del debito per il pagamento delle spese condominiali
Nel novero delle condotte che ben possono essere qualificate, caso per caso, sulla base di una valutazione fattuale, come forme di accettazione tacita dell’eredità, si può annoverare anche il riconoscimento del debito verso il condominio per il pagamento di oneri condominiali, di modo che:
“…con dichiarazione (…) l’odierno convenuto, nel riconoscere il proprio debito per il pagamento degli oneri condominiali relativi all’immobile per cui è causa, si qualificava come “…condomino dello stabile(…) ”, in tal modo espressamente riconoscendo la sua titolarità dell’immobile de quo…” (TRIB. DI ROMA, SEZ. VIII, SENT. 5 FEBBRAIO 2021 – RG.269369/2019).
E se il pagamento degli oneri condominiali, il riconoscimento del debito degli stessi verso i condomini, la voltura catastale, la dichiarazione di residenza presso l’immobile oggetto di successione, sono già condotte che la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, ha annoverato nella platea di quegli atti che possono essere qualificati come un’accettazione tacita dell’eredità, cionondimeno, la classificazione è ancora ampia da compiersi caso per caso sulla base delle suddette coordinate ermeneutiche indicate dalla Suprema Corte.
L’iscrizione nell’anagrafe condominiale
Anche la dichiarazione con la quale il chiamato all’eredità si dichiara proprietario dell’immobile caduto in successione ai fini dell’iscrizione presso l’anagrafe condominiale, unitamente alla rilevazione di altri indici sintomatici fattuali, ben può essere classificata come una condotta rivelatrice dell’intenzione (animus) del chiamato all’eredità di accettarla.
Ne viene che:
“…è dichiarato espressamente proprietario dell’immobile in questione in sede di dichiarazione sottoscritta, in data (…), ai fini della compilazione del registro di anagrafe condominiale; inoltre, l’odierno resistente non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento degli oneri condominiali, prestando in tal modo acquiescenza all’avversa pretesa creditoria per i titoli di cui al ricorso…” (Trib. di Roma, Sez. VIII, Ord. dell’1 ottobre 2022 – Rg.13919/2022).
La transazione ex art. 1965 c.c. avente ad oggetto il debito condominiale
E continuando la rassegna giurisprudenziale in materia, se il certificato di residenza non è di per sé, in assenza di altri indici fattuali, atto volto a provare il possesso dell’immobile da parte del chiamato all’eredità, il contratto di transazione, stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1965, c.c., avente a oggetto la tacitazione dei debiti del de cuius verso l’ente condominiale, è un atto che implica, necessariamente, la volontà d’accettare l’eredità relitta.
La valutazione, nella fattispecie in esame, è operata dal Giudicante sulla base del principio di diritto, scaturente dalla giurisprudenza consolidata, secondo la quale, ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, ex art. 476, c.c., giammai è sufficiente che il chiamato all’eredità compia un atto implicante la volontà d’accettarla, quanto, semmai, che compia un atto dispositivo del debito del defunto che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.
Ne consegue, pertanto, che:
“…La transazione di un debito ereditario da parte del chiamato all’eredità rappresenta quindi un atto di accettazione tacita dell’eredità relitta ex art. 476 c.c…” (Trib. di Milano, Sez. IV, Sent. del 18 settembre 2025 – Rg. 38387/2024).
La transazione quale indice rivelatore dell’accettazione tacita dell’eredità
A corroborare la decisione del giudicante da ultimo menzionato, milita la considerazione che per fare validamente una transazione, che abbia a oggetto un debito ereditario, è necessario poter avere il diritto in contesa, nel senso, cioè, che soltanto chi assuma la qualità di erede, mutando, indi, il suo status da chiamato all’eredità a erede, è legittimato a transigere il debito del suo dante causa, giacché, opinando diversamente, non avrebbe ragione di transigere un debito altrui.
Pertanto:
“…la scrittura privata (…), prodotta dal ricorrente, avendo natura e funzione transattiva -come dalla stessa emergente-, costituisce (…) un atto che il chiamato all’eredità non avrebbe avuto diritto di compiere se non nella qualità di erede, atteso che trattasi di atto dispositivo di un debito ereditario..” (Trib. di Milano, Sez. IV, Sent. del 18 settembre 2025, cit.).
Nella giurisprudenza di merito quivi esaminata, le pronunce hanno condotto l’accertamento e alla dichiarazione di accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476, c.c.
Conclusioni
Alla luce delle superiori argomentazioni giuridiche, possiamo giungere alle seguenti conclusioni.
La valutazione della condotta del chiamato all’eredità, al fine di acclarare se essa possa o meno essere sussunta nell’alveo delle forme di accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 476, c.c., deve essere compiuta dal Giudicante, caso per caso, indagando l’animus e la finalità oggettiva dell’atto compiuto.
Dalla rassegna della giurisprudenza di merito, oltre che di quella di legittimità, emerge una casistica di condotte poste in essere dal chiamato all’eredità che, unitamente ad altri indici fattuali del caso specifico, vengono classificati come forme di accettazione tacita dell’eredità.