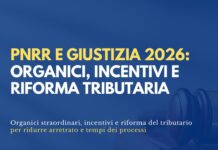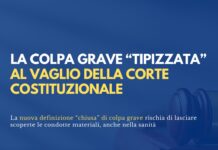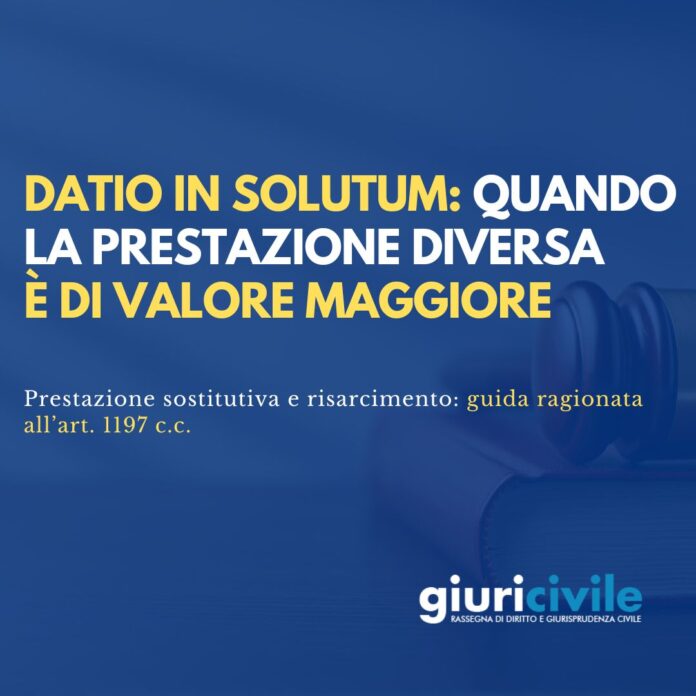
L’art. 1197 del codice civile rappresenta una delle norme più interessanti nel panorama delle obbligazioni, per la sua capacità di modulare i confini tra adempimento, novazione e rinegoziazione contrattuale. La possibilità, prevista dalla norma, di estinguere un’obbligazione originaria attraverso una prestazione diversa – purché accettata dal creditore – solleva rilevanti questioni sistematiche: dal rapporto con l’istituto della novazione, alle ricadute sulla tutela risarcitoria, fino all’interazione con altre figure, come il recesso ex art. 1373 c.c. o le garanzie per i vizi nel trasferimento di diritti. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
La prestazione di valore maggiore ex art. 1197 c.c.: “novazione atipica”
La prestazione di valore maggiore ex art. 1197 c.c.
L’art. 1197 del codice civile stabilisce che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, neppure se di valore uguale o superiore, salvo consenso del creditore. La norma specifica che l’obbligazione si estingue solo nel momento in cui la nuova prestazione viene effettivamente eseguita.
Questo meccanismo contrattuale si distingue dalla novazione propriamente detta, disciplinata all’art. 1230 c.c., che si verifica quando le parti sostituiscono l’obbligazione originaria con una nuova, diversa per oggetto o per titolo, con conseguente estinzione definitiva della prima. Affinché vi sia novazione, è necessario che la volontà di novare emerga in modo non equivoco.
Nel caso della prestazione diversa di cui all’art. 1197 c.c., il creditore consente a una modificazione della modalità di adempimento, ma l’obbligazione originaria si estingue solo a esecuzione avvenuta. Fino a quel momento, resta in vita e azionabile.
Una “novazione atipica”: effetti e tutela del creditore
Sebbene l’accordo tra debitore e creditore sull’esecuzione di una prestazione diversa sembri produrre un effetto novativo, la dottrina lo qualifica correttamente come una “novazione atipica”. La differenza essenziale rispetto alla novazione tipica è che, nell’ipotesi prevista dall’art. 1197 c.c., il creditore conserva il diritto di pretendere la prestazione originaria qualora il debitore non adempia la nuova.
In altri termini, mentre nella novazione ai sensi dell’art. 1230 c.c. l’obbligazione iniziale si estingue subito, anche in caso di inadempimento della nuova, nel meccanismo previsto dall’art. 1197 c.c. l’obbligazione originaria resta sospesa ma non annullata. Solo il corretto adempimento della nuova prestazione la estingue definitivamente. In caso contrario, il creditore potrà “resuscitare” la prestazione iniziale e agire per il suo adempimento.
È in questa peculiarità che risiede l’atipicità della “novazione” di cui all’art. 1197 c.c.: essa non determina un’immediata estinzione dell’obbligazione originaria, ma una sua temporanea sospensione condizionata all’esecuzione della prestazione alternativa.
Art. 1197 c.c. e art. 1373 c.c.: analogie e differenze
Prestazione diversa e recesso: due ipotesi a confronto
La disciplina dettata dall’art. 1197 c.c. si presta ad essere accostata, per struttura e logica, a quella contenuta nell’art. 1373 c.c., comma 3 c.c. In quest’ultima norma, il legislatore prevede che, “qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita”. Allo stesso modo, l’art. 1197 c.c. stabilisce che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella originaria se non con il consenso del creditore, e che l’obbligazione si estingue solo al momento dell’esecuzione effettiva della diversa prestazione.
Entrambe le ipotesi condividono quindi una struttura simile: la prestazione sostitutiva non produce effetto liberatorio né consente l’esercizio del diritto (il recesso o la liberazione) finché non sia stata effettivamente adempiuta. Ciò significa che, fino a quel momento, il soggetto obbligato resta vincolato alla prestazione originaria.
Valore della prestazione e funzione risarcitoria: due prospettive
Vi è, tuttavia, una significativa differenza: nell’art. 1197 c.c. la prestazione sostitutiva può essere anche di valore maggiore rispetto a quella originaria. In questo caso, tale maggiorazione è spesso interpretata in chiave “risarcitoria”, poiché rappresenta una forma di compensazione per il danno derivante dall’inadempimento iniziale. Il debitore, offrendo una prestazione più onerosa, riconosce implicitamente il proprio inadempimento e cerca di ripararlo, accrescendo il contenuto dell’obbligazione sostitutiva.
Diversamente, l’art. 1373 c.c. non prevede espressamente che il corrispettivo pattuito per il recesso possa eccedere il valore delle prestazioni rimaste inadempiute. Infatti, la funzione del corrispettivo per il recesso non è propriamente risarcitoria, ma preventiva e compensativa. La parte che accetta una clausola di recesso oneroso, infatti, si tutela fin dall’inizio contro l’eventualità dello scioglimento anticipato del vincolo, predisponendo una misura di salvaguardia del proprio equilibrio contrattuale. In tale ottica, l’importo pattuito dovrebbe rappresentare un ristoro equivalente al mancato godimento delle prestazioni future, ma non eccedente tale limite.
Effetti sull’obbligazione originaria: estinzione o sospensione
L’altra distinzione cruciale riguarda gli effetti sull’obbligazione originaria. Nell’ipotesi di recesso ex art. 1373 c.c., se il corrispettivo non viene versato, il recesso non produce effetti, e il rapporto resta in essere. Nel caso invece dell’art. 1197 c.c., se il debitore non adempie alla prestazione diversa, l’obbligazione originaria permane e torna ad essere esigibile. Questo significa che, nell’art. 1197 c.c., l’obbligazione iniziale non si estingue se non con l’esecuzione effettiva della nuova prestazione, e non sussiste alcuna rinuncia del creditore alla prestazione originaria fino a quel momento.
Limiti al corrispettivo e divieto di surrettizia funzione risarcitoria
Un ulteriore aspetto critico emerge in relazione al valore economico del corrispettivo per il recesso. Se è vero che il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e che le clausole possono prevedere prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente dedotte (art. 1374 c.c.), occorre comunque rispettare i limiti di proporzionalità e funzione della clausola.
Qualora il corrispettivo pattuito ecceda l’ammontare delle prestazioni inadempiute e assuma una connotazione risarcitoria, si potrebbe ritenere che la parte abbia già rinunciato implicitamente a pretendere tale risarcimento, proprio accettando l’eventualità del recesso e predisponendo uno specifico corrispettivo. Ne consegue che la funzione dell’obbligo previsto dall’art. 1373 c.c. non può essere surrettiziamente trasformata in una clausola penale o risarcitoria, salvo esplicita volontà delle parti formalizzata nel contratto.
Due meccanismi autonomi ma confrontabili
In definitiva, le fattispecie previste dagli artt. 1197 e 1373 c.c. sono accomunate da un medesimo schema operativo: l’estinzione o l’efficacia giuridica della vicenda dipendono dall’esecuzione di una prestazione alternativa. Tuttavia, diverge la loro funzione: nel primo caso si tratta di una forma di adempimento modificato, talvolta di valore superiore, che lascia integra la garanzia del creditore; nel secondo si configura un meccanismo di scioglimento contrattuale anticipato, regolato da pattuizioni preventive e di portata generalmente compensativa.
Entrambe le norme offrono strumenti utili per la modulazione dei rapporti obbligatori, ma richiedono una chiara consapevolezza delle implicazioni giuridiche e delle conseguenze economiche che ne derivano. La loro corretta applicazione si gioca tutta sul delicato equilibrio tra libertà negoziale, tutela del contraente e funzione dell’obbligazione.
Reviviscenza dell’obbligazione originaria
Reviviscenza dell’obbligazione e inadempimento della prestazione sostitutiva
L’art. 1197, comma 1, c.c. disciplina l’ipotesi in cui il debitore, con il consenso del creditore, si obbliga ad eseguire una prestazione diversa da quella originaria, di valore uguale o superiore. In tale schema, la prestazione iniziale non si estingue sino all’effettivo adempimento di quella sostitutiva: se questa viene meno, l’obbligazione originaria “rivive” e torna ad essere esigibile. A differenza della novazione, qui l’obbligazione sostituita non viene immediatamente estinta, ma sospesa condizionatamente all’adempimento della nuova.
Tuttavia, il fatto che la norma non preveda espressamente un’alternativa tra richiesta di adempimento e risarcimento del danno non implica una preclusione assoluta alla tutela risarcitoria. In base all’art. 1453, comma 2, c.c., il creditore può sempre rinunciare all’adempimento, anche se richiesto inizialmente in giudizio, e optare per la risoluzione o per il risarcimento. Tale disposizione agisce come norma di chiusura del sistema obbligatorio, rendendo compatibile con il modello dell’art. 1197 c.c. la possibilità per il creditore di abbandonare la via dell’esecuzione per quella risarcitoria.
Rilevanza del valore della nuova prestazione ai fini del quantum risarcitorio
Quando la prestazione sostitutiva sia di valore maggiore rispetto a quella originaria, l’inadempimento può causare al creditore un pregiudizio patrimoniale più grave. In questo caso, se il creditore decide di rinunciare all’esecuzione e di agire per il risarcimento, egli dovrebbe poter parametrarne l’ammontare non al valore della prestazione iniziale, ma a quello – superiore – della nuova obbligazione.
Una simile conclusione è coerente con il principio generale di cui all’art. 1218 c.c., che impone al debitore inadempiente l’obbligo di risarcire il danno “cagionato” dalla mancata prestazione. Nel caso di specie, il danno non è più correlato alla prestazione originaria, ormai superata nella dinamica obbligatoria, ma alla prestazione che il debitore si era volontariamente impegnato a rendere in alternativa e che aveva ottenuto l’assenso del creditore.
Il “maggior danno” ex art. 1224 c.c. come parametro del risarcimento
Ai fini del calcolo del danno risarcibile, viene in rilievo anche l’art. 1224 c.c., che legittima la richiesta di un risarcimento ulteriore rispetto agli interessi di mora, purché esso non sia già compreso in una clausola di determinazione convenzionale. Se le parti non hanno predeterminato il danno da ritardo né hanno fissato un tetto convenzionale alla nuova obbligazione, il creditore potrà ragionevolmente richiedere il risarcimento del danno effettivo, parametrato al valore della prestazione sostitutiva.
In tal senso, l’entità della nuova prestazione pattuita diventa la base di riferimento per quantificare il “maggior danno” subito dal creditore per effetto dell’inadempimento. Il debitore, avendo assunto spontaneamente un obbligo più oneroso, risponde per il valore di quella nuova obbligazione e non per la semplice “reviviscenza” dell’originaria.
Simmetria risarcitoria e obblighi delle parti: il rilievo dell’art. 1207 c.c.
Infine, a conferma dell’equilibrio sistematico della tesi esposta, giova richiamare l’art. 1207, comma 3, c.c., secondo cui il creditore in mora nell’esigere la prestazione può essere tenuto a risarcire i danni al debitore. Se la norma vale in senso orizzontale per tutte le parti obbligate, non v’è ragione di negare che, in ipotesi simmetrica, anche il debitore inadempiente a una prestazione sostitutiva più gravosa debba rispondere del danno parametrato al valore di quella prestazione, e non a quella originaria.
La ratio è chiara: chi si obbliga a prestazioni economicamente più rilevanti, assumendo in tal modo un rischio contrattuale maggiore, deve rispondere delle conseguenze proporzionali del proprio inadempimento. Diversamente, si vanificherebbe la funzione stessa della prestazione “diversa” e di valore superiore pattuita ex art. 1197 c.c., riducendola a mera apparenza.
Prestazione sostitutiva e garanzia per vizi: il diritto di rifiuto del creditore
Articolo 1197, comma 2, c.c.
L’art. 1197, comma 2, c.c. contempla il caso in cui la prestazione offerta in sostituzione di quella originaria consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto, prevedendo l’obbligo del debitore di garantire per evizione e per vizi secondo le regole della vendita. Tuttavia, la norma attribuisce al creditore la facoltà di rifiutare tale prestazione e di preferire l’adempimento dell’obbligazione originaria, eventualmente accompagnato da una richiesta di risarcimento.
Questa scelta è pienamente legittima se fondata sulla consapevolezza che la cosa offerta sia affetta da vizi noti al creditore, e quindi sicuramente inidonea a soddisfare il suo interesse contrattuale. In tal caso, il debitore non solo non ha adempiuto l’obbligazione originaria, ma ha aggravato la sua posizione proponendo una sostituzione inefficace e sostanzialmente strumentale, dalla quale deriva un ulteriore pregiudizio per il creditore.
Il limite della “facile riconoscibilità” dei vizi e l’obbligo di verifica
Diversa è la situazione in cui i vizi della cosa offerta siano “facilmente riconoscibili” ma il creditore scelga di non verificarli, rifiutando la prestazione senza un concreto accertamento. In questo caso, il rifiuto si fonda non su una valutazione dell’inidoneità della cosa, ma su una mancata diligenza conoscitiva. L’art. 1491 c.c. esclude la garanzia per i vizi noti o agevolmente percepibili, e dunque la posizione del creditore che si rifiuti di esaminare la cosa diviene giuridicamente più debole.
Il rifiuto “a priori” della prestazione offerta, senza averne prima verificato la conformità all’interesse dedotto in contratto, rischia di trasformarsi in un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede. Ne deriva che, in presenza di vizi agevolmente accertabili, la legittimità del rifiuto è quantomeno discutibile.
Rifiuto ingiustificato e risarcimento: il ruolo degli artt. 1220 e 1218 c.c.
Ai sensi dell’art. 1220 c.c., affinché il creditore possa rifiutare validamente una prestazione e determinare la mora del debitore, è necessario che il rifiuto sia fondato su motivi legittimi. Un rifiuto meramente strumentale o basato su una volontaria ignoranza circa l’idoneità della prestazione offerta rischia di non integrare tale presupposto.
In parallelo, l’art. 1218 c.c. subordina il diritto al risarcimento del danno alla prova dell’inadempimento del debitore, inteso come mancata esecuzione “esatta” della prestazione dovuta. Se il creditore non dimostra di aver verificato l’inidoneità della prestazione sostitutiva, manca la prova della sua “inesattezza”, e quindi del fondamento della pretesa risarcitoria. L’onere probatorio grava sul creditore, che deve dimostrare l’inutilità dell’alternativa offerta per legittimare il proprio rifiuto e l’eventuale domanda di danno.
Una lettura sistematica: condizione di risarcibilità e legittimità parziale dell’art. 1197, comma 2
Alla luce di quanto sopra, l’art. 1197, comma 2, c.c. dovrebbe essere letto in coerenza con il sistema delle obbligazioni e con i principi generali della responsabilità contrattuale. In particolare, appare problematico ammettere l’azione risarcitoria in favore del creditore che abbia rifiutato la prestazione sostitutiva offerta dal debitore senza prima accertarne l’eventuale inidoneità, specie quando i vizi siano agevolmente percepibili.
In tale prospettiva, l’attuale formulazione della norma contrasterebbe, nella parte in cui non distingue le ipotesi di rifiuto legittimo da quelle prive di fondamento oggettivo, con le previsioni degli artt. 1220 e 1218 c.c. Ne deriverebbe l’esigenza di una lettura sistematica – se non addirittura una parziale revisione ermeneutica – che subordini la legittimità della richiesta risarcitoria a un minimo obbligo di diligenza del creditore nell’accertare l’idoneità della prestazione offerta in sostituzione.
Conclusioni
L’analisi dell’art. 1197 c.c. dimostra come il legislatore abbia previsto un meccanismo flessibile, capace di coniugare l’interesse del debitore alla liberazione con quello del creditore alla tutela effettiva. La “novazione atipica” che ne scaturisce non comporta l’immediata estinzione dell’obbligazione originaria, ma ne sospende gli effetti subordinandoli all’esecuzione della prestazione sostitutiva. Questa impostazione consente di mantenere aperta la garanzia del creditore, ma impone altresì a quest’ultimo un comportamento diligente, specie nei casi in cui la prestazione offerta implichi trasferimenti patrimoniali soggetti a obblighi di verifica.
L’equilibrio tra libertà contrattuale, funzione dell’obbligazione e responsabilità per inadempimento si gioca qui su un terreno delicato, che esige da interpreti e operatori un’attenzione non solo normativa ma anche sostanziale. È in questa prospettiva che l’art. 1197 c.c. continua a rivelarsi, oltre che una norma di dettaglio, un presidio di razionalità giuridica nell’economia delle obbligazioni.