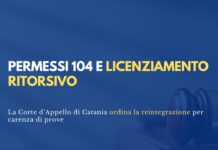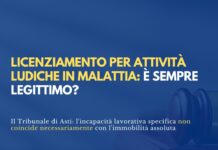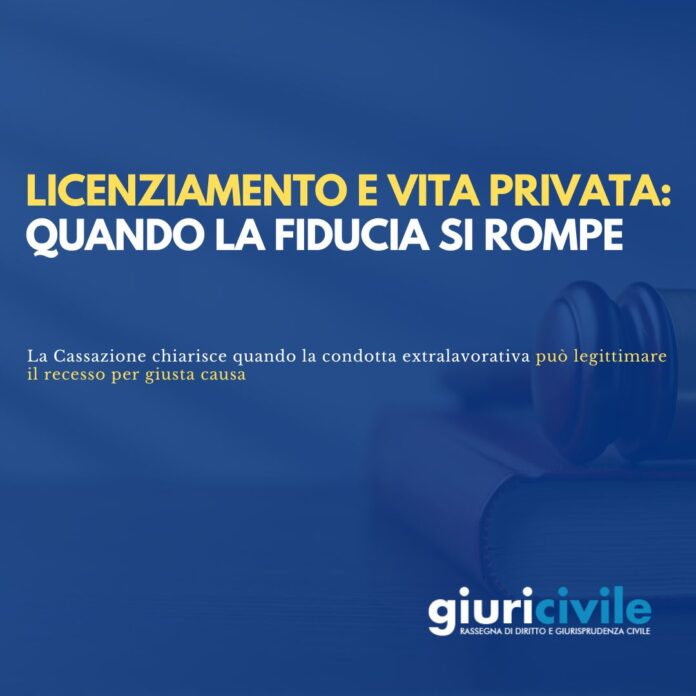
La Cassazione ha recentemente confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa anche in presenza di un reato commesso al di fuori dell’orario di lavoro. Il presente contributo analizza i profili civilistici del vincolo fiduciario nel contratto di lavoro, interrogandosi sui limiti dell’autonomia privata e sul ruolo della funzione sociale del contratto. Attraverso una riflessione sistemica, si evidenzia come la fiducia sia il cuore pulsante dell’obbligazione lavorativa.
Consiglio: per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”, a cura di Federico Torzo (clicca qui per iscriverti).
Il tempo invisibile del contratto
C’è un tempo del contratto che non coincide con quello dell’orologio. Un tempo più sottile, intessuto di gesti, di coerenze, di silenzi. Il contratto di lavoro, forse più di ogni altro, abita questo spazio invisibile: non si esaurisce nel perimetro della prestazione, né si consuma nel computo delle ore. Vive nella fiducia. È lì, in quella trama delicata che unisce datore e lavoratore, che prende forma il suo significato più profondo. Un significato che sfugge alle formule e alle definizioni, perché appartiene alla vita concreta delle relazioni, dove ogni condotta, ogni parola, ogni scelta può consolidare o incrinare il legame.
La vicenda: quando la fiducia vacilla
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 24100 del 28 agosto 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata a parlarci di questa fiducia. Lo ha fatto partendo da una vicenda apparentemente semplice: un lavoratore, al di fuori dell’orario di lavoro, viene coinvolto in un procedimento penale. Nulla che riguardi la sua mansione, nulla che accada sul luogo di lavoro. Eppure, qualcosa cambia. L’impresa, venuta a conoscenza del fatto, percepisce un’ombra che si stende sul rapporto. Non è più questione di capacità tecnica, ma di affidabilità morale e relazionale. La fiducia vacilla. E quando la fiducia vacilla, il contratto non regge. Così arriva il licenziamento per giusta causa. La Corte conferma: quel provvedimento è legittimo. E lo fa con parole che sanno di equilibrio e di misura, ma anche di una verità antica.
La giusta causa come crisi del patto fiduciario
La giusta causa, dice la Corte, non si esaurisce nell’inadempimento, non è una questione di mero fatto, ma riguarda la rottura del legame fiduciario. È la crisi del patto invisibile che tiene insieme le parti, quel patto che non si firma una volta sola ma si rinnova ogni giorno, nel modo di agire, nel rispetto, nella coerenza. In questo senso, la sentenza non punisce un comportamento privato: riconosce che il contratto di lavoro è una relazione ad alta intensità fiduciaria, dove la condotta del lavoratore, anche fuori dall’azienda, può riflettersi sulla vita dell’impresa, sulla serenità dell’ambiente di lavoro, sull’immagine collettiva di cui tutti fanno parte.
Potrebbero interessarti anche:
- Chat private e licenziamento: la tutela della corrispondenza prevale sul potere disciplinare
- Dalla lite al recesso: quando l’insulto integra insubordinazione grave
- Licenziamento disciplinare per offese al datore di lavoro su Facebook
- Il controllo investigativo del datore di lavoro: i limiti statutari e la giusta causa di licenziamento
- Uso improprio del congedo parentale: giustifica il licenziamento per abuso del diritto
-
Diffamazione online e risarcimento del danno: la responsabilità per commenti sui social network
L’impresa come comunità e la buona fede come fondamento
L’impresa non è un’entità astratta, è una comunità organizzata. E la comunità si regge su un filo comune: la fiducia reciproca. Così, il diritto torna a dialogare con la vita concreta dei rapporti. Non per giudicare le persone, ma per ricordare che ogni contratto vive di buona fede e che questa buona fede – quella degli artt. 1175 e 1375 c.c. – non è un ornamento morale, ma il cuore pulsante dell’obbligazione. Essa chiede lealtà, trasparenza, rispetto. Non si tratta di ridurre la libertà individuale, ma di riconoscere che ogni libertà, quando si traduce in legame, porta con sé una responsabilità relazionale.
In fondo, ciò che la sentenza riafferma è una verità tanto giuridica quanto umana: non esiste rapporto che possa sopravvivere alla frattura della fiducia. La fiducia non è un bene accessorio, è la sostanza stessa del vincolo. Quando viene meno, il contratto si svuota di senso. Ecco perché anche la condotta extralavorativa, se riflette in modo diretto sull’affidabilità del lavoratore, diventa rilevante: perché non è più solo “privata”, ma si intreccia alla trama collettiva del rapporto.
Il contratto come organismo vivente
C’è, in questa prospettiva, una visione del contratto come organismo vivente, un’entità che cresce, respira, si modella. Il contratto non è la somma dei suoi articoli, ma la somma dei suoi gesti. La funzione sociale del lavoro e dell’impresa si alimenta di questa dimensione fiduciaria, che non conosce confini rigidi. L’autonomia privata, pur ampia, incontra i limiti naturali della convivenza: il rispetto, la lealtà, la coerenza.
Giurisprudenza e dottrina da tempo camminano su questo sentiero. Lo si legge nelle decisioni che hanno preceduto questa, lo si avverte nelle riflessioni dei civilisti più attenti: il contratto non è un meccanismo, ma un linguaggio. Un linguaggio fatto di fiducia, di comportamenti, di reciprocità. E se la giusta causa non è che il modo giuridico per dire che quel linguaggio è stato tradito, allora comprendiamo che ogni rottura è, prima ancora che un fatto, un segno di disarmonia relazionale.
Per il giurista, questa sentenza non è solo una conferma, ma un invito. Un invito a leggere il contratto non come struttura chiusa, ma come spazio di vita. A ricordare che il diritto, quando parla di fiducia, non si muove nella retorica, ma nella realtà: perché fidarsi è condizione necessaria di ogni cooperazione. E per l’avvocato, per chi ogni giorno difende, consiglia, accompagna, è un monito sottile: il diritto del lavoro non vive solo nei tribunali, ma nel quotidiano, nella cultura della responsabilità, nella costruzione di rapporti fondati sulla trasparenza e sulla buona fede.
Il contratto come promessa
Il contratto di lavoro, allora, non è solo scambio, ma promessa. Promessa di lealtà, di affidamento, di continuità. E come ogni promessa, si misura non solo nelle ore di lavoro, ma nel modo di stare al mondo. L’ordinanza del 28 agosto 2025 ci ricorda che il diritto non può essere indifferente alla fiducia, perché la fiducia è la forma giuridica dell’umano. E che il contratto – come ogni legame autentico – vive, cresce e si consuma nel tempo delle relazioni, nel tempo delle persone. Non basta eseguirlo: bisogna custodirlo.