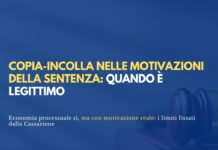L’avvento dei social network ha rivoluzionato le modalità di comunicazione interpersonale, creando nuovi spazi virtuali di confronto e dibattito che, tuttavia, non sono esenti da fenomeni di abuso e lesione dei diritti della personalità. La diffamazione online rappresenta oggi una delle questioni più complesse del diritto contemporaneo, richiedendo un delicato bilanciamento tra la tutela della libertà di espressione e la protezione dell’onore e della reputazione individuale.
Consiglio: per approfondimenti sui rischi legati all’utilizzo dei social, consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Educazione ai Social Media - Dai Boomer alla generazione Alfa
Ricordate quando i nostri genitori ci dicevano di non parlare con gli sconosciuti? Il concetto non è cambiato, si è “trasferito” anche in rete. Gli “sconosciuti” possono avere le facce più amichevoli del mondo, nascondendosi dietro uno schermo. Ecco perché dobbiamo imparare a navigare queste acque digitali con la stessa attenzione che usiamo per attraversare la strada. Ho avuto l’idea di scrivere questo libro molto tempo fa, per offrire una guida pratica a genitori che si trovano, come me, tutti i giorni ad affrontare il problema di dare ai figli alternative valide al magico potere esercitato su di loro – e su tutti noi – dallo smartphone. Essere genitori, oggi, e per gli anni a venire sempre di più, vuol dire anche questo: scontrarsi con le tematiche proprie dei nativi digitali, diventare un po’ esperti di informatica e di sicurezza, di internet e di tecnologia e provare a trasformarci da quei boomer che saremmo per diritto di nascita, a hacker in erba. Si tratta di una nuova competenza educativa da acquisire: quanto è sicuro il web, quali sono i rischi legati alla navigazione, le tematiche della privacy, che cosa si può postare e che cosa no, e poi ancora il cyberbullismo, il revenge porn, e così via in un universo parallelo in cui la nostra prole galleggia tra like, condivisioni e hashtag.
Luisa Di Giacomo
Avvocato, Data Protection Officer e consulente Data Protection e AI in numerose società nel nord Italia. Portavoce nazionale del Centro Nazionale Anti Cyberbullismo. È nel pool di consulenti esperti di Cyber Law istituito presso l’European Data Protection Board e ha conseguito il Master “Artificial Intelligence, implications for business strategy” presso il MIT. Autrice e docente di corsi di formazione, è presidente e co-founder di CyberAcademy.
Leggi descrizione
Luisa Di Giacomo, 2024, Maggioli Editore
25.00 €
23.75 €

Educazione ai Social Media - Dai Boomer alla generazione Alfa
Ricordate quando i nostri genitori ci dicevano di non parlare con gli sconosciuti? Il concetto non è cambiato, si è “trasferito” anche in rete. Gli “sconosciuti” possono avere le facce più amichevoli del mondo, nascondendosi dietro uno schermo. Ecco perché dobbiamo imparare a navigare queste acque digitali con la stessa attenzione che usiamo per attraversare la strada. Ho avuto l’idea di scrivere questo libro molto tempo fa, per offrire una guida pratica a genitori che si trovano, come me, tutti i giorni ad affrontare il problema di dare ai figli alternative valide al magico potere esercitato su di loro – e su tutti noi – dallo smartphone. Essere genitori, oggi, e per gli anni a venire sempre di più, vuol dire anche questo: scontrarsi con le tematiche proprie dei nativi digitali, diventare un po’ esperti di informatica e di sicurezza, di internet e di tecnologia e provare a trasformarci da quei boomer che saremmo per diritto di nascita, a hacker in erba. Si tratta di una nuova competenza educativa da acquisire: quanto è sicuro il web, quali sono i rischi legati alla navigazione, le tematiche della privacy, che cosa si può postare e che cosa no, e poi ancora il cyberbullismo, il revenge porn, e così via in un universo parallelo in cui la nostra prole galleggia tra like, condivisioni e hashtag.
Luisa Di Giacomo
Avvocato, Data Protection Officer e consulente Data Protection e AI in numerose società nel nord Italia. Portavoce nazionale del Centro Nazionale Anti Cyberbullismo. È nel pool di consulenti esperti di Cyber Law istituito presso l’European Data Protection Board e ha conseguito il Master “Artificial Intelligence, implications for business strategy” presso il MIT. Autrice e docente di corsi di formazione, è presidente e co-founder di CyberAcademy.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina della diffamazione online trova il suo fondamento nell’art. 595 del codice penale, che punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione. Particolare rilevanza assume il terzo comma della disposizione, che prevede un’aggravante quando l’offesa è recata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, categoria nella quale la giurisprudenza ha da tempo incluso internet e i social network.
Sul versante civilistico, la responsabilità per diffamazione online si inquadra nel sistema generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 del codice civile, che obbliga al risarcimento del danno chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto per dolo o colpa. L’art. 186 del codice penale stabilisce inoltre che ogni reato obbliga al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
L’evoluzione giurisprudenziale sulla diffamazione nei social network
La giurisprudenza italiana ha progressivamente delineato i contorni della responsabilità per diffamazione online, affrontando le peculiarità tecniche e comunicative dei social media. La Cassazione penale (Sez. V, sentenza n. 26406 del 4 luglio 2024) ha chiarito che integra il reato di diffamazione la pubblicazione di commenti che, pur presentandosi formalmente come critica politica, contengano allusioni alla sfera intima della persona offesa tali da lederne la reputazione secondo la percezione del lettore medio.
Un aspetto particolarmente significativo riguarda l’identificazione dell’autore dei contenuti diffamatori. Come evidenziato dal Tribunale civile di Avellino (sentenza n. 138 del 29 gennaio 2025), l’individuazione dell’autore di un post o commento può essere effettuata anche in assenza di specifici accertamenti sull’intestazione dell’indirizzo IP, sulla base di elementi di natura indiziaria, tra cui l’assenza di denuncia di furto di identità digitale da parte dell’intestatario della bacheca.
Potrebbero interessarti:
- Diffamazione: confronto tra qualifica di imputato e indagato nella giurisprudenza
- Responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa: Sezioni Unite sull’errore nella qualifica giudiziaria
- Diritto all’oblio e deindicizzazione: criteri per il bilanciamento dei diritti fondamentali
- Pubblicazione foto dei figli minori sui Social Network: norma e giurisprudenza
- Nuovo Codice di Condotta Agcom per Influencer: regole, obblighi e sanzioni
I limiti del diritto di critica nei social media
La valutazione della natura diffamatoria dei contenuti pubblicati sui social network richiede un’attenta analisi dei confini del legittimo esercizio del diritto di critica. La Cassazione civile ha precisato (Sez. III, ordinanza n. 29170 del 12 novembre 2024) che l’espressione offensiva utilizzata all’interno di una discussione su una pagina Facebook di un quotidiano nazionale non integra necessariamente diffamazione quando si configuri come mero giudizio negativo, ancorché sarcastico, sull’opinione espressa e non come gratuito attacco personale.
Il diritto di critica trova tuttavia un limite invalicabile nel principio di continenza, intesa come correttezza formale e rispetto di quanto strettamente necessario all’espressione del proprio dissenso. Il Tribunale civile di Livorno (sentenza n. 532 del 9 aprile 2024) ha stabilito che il diritto di critica, pur consentendo l’utilizzo di un linguaggio aspro e pungente, deve rispettare il limite della continenza, senza trascendere in affermazioni gratuitamente offensive o denigratorie della persona.
La prova del danno da diffamazione online
Una questione centrale nella disciplina del risarcimento per diffamazione online riguarda l’onere probatorio del danno. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui il danno all’onore e alla reputazione non è “in re ipsa“, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato.
La Cassazione civile ha ribadito (Sez. III, ordinanza n. 29170 del 12 novembre 2024) che la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo rilevanza quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima nel suo contesto di riferimento.
Il Tribunale civile di Chieti ha precisato (sentenza n. 37 del 21 novembre 2024) che la mera indicazione del numero di followers sulla piattaforma social non è sufficiente a dimostrare l’effettiva diffusione e risonanza delle pubblicazioni contestate, dovendo essere provati gli effetti concreti e il pregiudizio subito nel contesto sociale e professionale di riferimento.
I criteri di quantificazione del danno
La liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione online (leggi anche: “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale: hanno ancora valore paranormativo?”) presenta profili di particolare complessità, dovendo il giudice operare una valutazione necessariamente equitativa ai sensi dell’art. 2056 del codice civile e dell’art. 1226.
Il Tribunale civile di Livorno ha individuato (sentenza n. 532 del 9 aprile 2024) i parametri rilevanti per la quantificazione, che devono tenere conto:
- della notorietà del diffamante,
- della gravità dell’offesa nel contesto fattuale,
- dell’ampiezza della diffusione e dell’eventuale reiterazione della condotta.
La liquidazione deve considerare sia il mezzo utilizzato e la diffusione dello scritto, sia l’intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni utilizzate, tali da esporre la vittima a un pubblico scherno idoneo a ingenerare un senso di disagio e mortificazione.
Il Tribunale di Avellino ha evidenziato (Tribunale Civile, sentenza n. 138 del 29 gennaio 2025) come il danno non patrimoniale derivante dall’offesa alla reputazione debba ritenersi provato su base presuntiva, considerando le intuibili ripercussioni in termini di sofferenza e disagio, con particolare rilevanza quando la vittima svolge un’attività professionale rivolta al pubblico per la quale la reputazione presso la collettività costituisce elemento fondamentale.
La responsabilità solidale e i limiti della responsabilità delle piattaforme
Un aspetto di crescente rilevanza riguarda la responsabilità delle piattaforme social per i contenuti diffamatori pubblicati dagli utenti. L’art. 2055 del codice civile disciplina la responsabilità solidale quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, stabilendo che tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
La giurisprudenza milanese ha chiarito (Tribunale Civile di Milano, sentenza n. 5269 del 27 giugno 2023) che il gestore del blog risponde del delitto nella forma aggravata anche per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione.
Le peculiarità processuali e la tutela cautelare
La diffamazione online presenta specifiche problematiche processuali, legate alla rapidità di diffusione dei contenuti e alla loro persistenza nel tempo. L’art. 597 del codice penale stabilisce che il delitto di diffamazione è punibile a querela della persona offesa, mentre l’art. 186 del codice penale prevede la possibilità di riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
Il Tribunale civile di Bologna ha precisato (sentenza n. 145 del 24 gennaio 2023) che nel giudizio civile il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche raccolte in altri procedimenti, purché su di esse si sia instaurato il contraddittorio tra le parti.
L’impatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2021
Un elemento di particolare rilievo nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dalla sentenza n. 150/2021 della Corte Costituzionale, che ha inciso significativamente sulla punibilità della diffamazione aggravata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26406 del 4 luglio 2024) che l’applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è subordinata alla verifica della “eccezionale gravità” della condotta, che si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d’odio e incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima.
Le prospettive future e le questioni aperte
La disciplina della diffamazione online continua a evolversi per adeguarsi alle trasformazioni tecnologiche e sociali. La Cassazione civile ha evidenziato (Sez. III, ordinanza n. 126 del 3 gennaio 2024) come i commenti inseriti sulla pagina Facebook di un quotidiano online sollevano questioni giuridiche nuove e di particolare rilevanza nomofilattica, che richiedono un’attenta valutazione circa i confini del legittimo esercizio del diritto di critica in relazione alle peculiarità di tali mezzi di comunicazione sociale.
La determinazione della potenziale natura diffamatoria dei commenti su Facebook e la definizione dei limiti entro cui può essere esercitato il diritto di critica su queste piattaforme costituiscono questioni che, per la loro novità e rilevanza sistematica nell’attuale contesto tecnologico-sociale, necessitano di criteri interpretativi uniformi che tengano conto sia della particolare natura dei social network come mezzi di comunicazione di massa, sia delle garanzie costituzionali della libertà di espressione, sia della tutela della reputazione individuale.
Conclusioni
La diffamazione online rappresenta una sfida complessa per il diritto contemporaneo, richiedendo un equilibrio delicato tra la tutela della libertà di espressione e la protezione dei diritti della personalità. La giurisprudenza italiana ha progressivamente elaborato criteri interpretativi che tengono conto delle peculiarità tecniche e comunicative dei social media, stabilendo che la responsabilità per diffamazione online non può prescindere dalla prova del danno effettivamente subito e dalla valutazione del contesto comunicativo specifico.
I limiti della responsabilità per commenti sui social network si delineano attraverso l’applicazione dei principi tradizionali della diffamazione alle nuove modalità di comunicazione digitale, con particolare attenzione alla distinzione tra legittima critica e gratuita offesa, alla prova del danno e alla sua quantificazione equitativa. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dovrà continuare ad adeguarsi alle trasformazioni tecnologiche, garantendo una tutela effettiva dei diritti fondamentali nell’era digitale.
La complessità della materia richiede un approccio multidisciplinare che tenga conto non solo degli aspetti giuridici, ma anche delle dinamiche sociali e tecnologiche che caratterizzano la comunicazione online, al fine di assicurare una disciplina equilibrata e proporzionata che sappia coniugare innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali della persona.
Unisciti alla nostra comunità legale
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime notizie, analisi giuridiche e risorse esclusive direttamente nella tua casella di posta. Non perdere nessun aggiornamento importante nel campo del diritto civile. Iscriviti ora e resta informato!