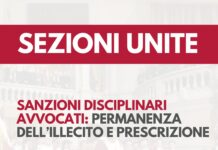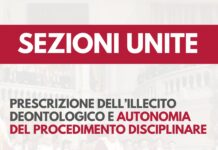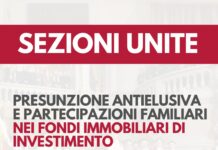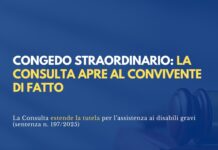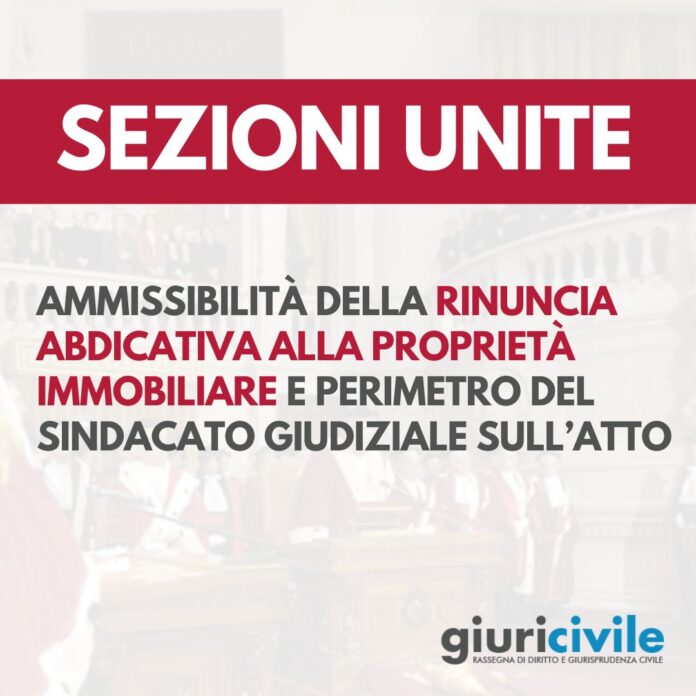
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si sono pronunciate su una questione di diritto particolarmente rilevante: l’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili e il perimetro del sindacato giudiziale sull’atto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Il caso: una rinuncia formale alla proprietà di fondi
Il procedimento trae origine dalla rinuncia formale, ricevuta da un notaio e successivamente trascritta, alla proprietà di alcuni fondi gravati da vincoli di pericolosità idrogeologica e classificati come inedificabili. L’iniziativa, posta in essere dalle originarie proprietarie, era motivata dalla volontà di liberarsi di beni che comportavano oneri senza offrire utilità economica.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio hanno agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità di tale rinuncia per illiceità, immeritevolezza della causa o abuso del diritto, ponendone in discussione la validità e gli effetti e sollevando dubbi sulla possibilità che l’ordinamento consenta una simile dismissione unilaterale della titolarità dominicale.
Il Tribunale di L’Aquila ha così ravvisato la sussistenza delle condizioni per disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della questione di diritto «attinente all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, nonché all’eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull’atto».
La Prima Presidente, con decreto del 29 febbraio 2024, ha dichiarato ammissibile la questione ed ha assegnato la stessa alle Sezioni Unite per l’enunciazione del principio di diritto.
Il rinvio pregiudiziale e gli orientamenti contrapposti
Il Tribunale di L’Aquila, nell’ordinanza di rinvio (alla quale avevamo già dedicato un approfondito commento), ha evidenziato come la Suprema Corte non avesse mai affrontato espressamente la questione dell’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, ma soltanto incidentalmente, in tema di “occupazione appropriativa”.
La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite presentava gravi difficoltà interpretative, confrontandosi nella giurisprudenza di merito ed in dottrina due orientamenti contrapposti.
La tesi favorevole
Una prima interpretazione reputava ammissibile la rinuncia abdicativa alla proprietà, argomentando dagli artt. 827, 1118 comma 2, 1350 n. 5) e 2643 n. 5 del codice civile. La rinuncia abdicativa alla proprietà darebbe luogo, per questa tesi, ad un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, né traslativo (a differenza delle ipotesi di c.d. abbandono liberatorio, di cui agli artt. 550, 882, 1070 e 1104 del codice civile), con effetti soltanto indiretti sui terzi.
La tesi contraria
L’opinione avversa ravvisava, invece, nelle norme citate ipotesi, comunque, di rinunce traslative o liberatorie, oppure deroghe giustificate dal diverso regime delle cose comuni, richiama le ulteriori disposizioni contenute negli artt. 963 e 2814 del codice civile e spiega
l’art. 827 c.c. come disposizione “di chiusura”, desumendone che i beni immobili, a differenza delle cose mobili, non possono essere di “proprietà di alcuno”.
Secondo questa impostazione, tutte le fattispecie in cui il codice civile ha espressamente ammesso la rinuncia ad un diritto reale risultano accomunate dal dato che, a fronte di essa, la proprietà immobiliare non rimane “acefala”, perché in tali casi la rinunzia provoca l’estinzione del diritto reale minore e la correlativa riespansione della piena proprietà, ovvero, trattandosi di diritti reali minori in comunione, provoca l’accrescimento delle quote
altrui sul diritto reale minore.
Ulteriori dubbi interpretativi: meritevolezza degli interessi e doveri di custodia
Il Tribunale ha prospettato gli ulteriori dubbi che sorgono ove pure si ammetta la rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, dubbi legati al perimetro della verifica
giudiziale della meritevolezza degli interessi che l’atto sia diretto a realizzare, o anche di eventuale illiceità della causa o del motivo che lo determina. Sul proprietario di un immobile, infatti, incombono doveri di custodia la cui osservanza è ragione di responsabilità civile e penale, nonché gli oneri tributari che discendono dal dominio.
Il sindacato di meritevolezza e di liceità dell’atto di rinuncia abdicativa opererebbe anche nella cornice degli artt. 2, 41, secondo comma, e 42 della Costituzione.
L’ordinanza di rinvio riportava, inoltre, un diverso approccio ermeneutico, che nega il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti con la rinuncia abdicativa alla proprietà, come anche l’analisi della causa da essa esplicitata, in quanto espressione del più generale diritto di disporre della cosa accordato al proprietario dall’art. 832 c.c.
Contenuto del diritto di proprietà e funzionale sociale
Le Sezioni Unite, nel risolvere la questione, muovono dal contenuto del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. (diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo), chiarendo che la facoltà dispositiva è tratto fisiologico dei diritti patrimoniali e include, accanto allo scambio e alla donazione, anche la rinuncia.
Nel valutare la meritevolezza della scelta di destinazione e di utilizzazione del singolo bene operata dal proprietario viene, in primo piano, il principio dettato dall’art. 42, secondo comma, Cost., che chiede alla legge di riconoscere e garantire la proprietà privata determinandone i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la “funzione sociale”.
Se tale funzione, tuttavia, esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprietà come viene modernamente intesa e come è stata recepita dalla nostra Costituzione (Corte cost. 23 aprile 1986, n. 108; Corte cost. 30 aprile 2015, n. 71), non vi è, comunque, un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale» legati alla affermazione della responsabilità per l’uso dannoso del bene.
La “funzione sociale” (art. 42, co. 2, Cost.), dunque, non si traduce in un dovere di restare proprietario, né legittima il giudice a introdurre limiti non previsti dalla legge. Non esiste una “proprietà imposta” a carico del singolo per ragioni generali: il minimo costituzionale del diritto sta nel legame di appartenenza e nell’utilità patrimoniale del bene, non in un obbligo di permanenza nella titolarità.
Natura giuridica della rinuncia: atto unilaterale, non recettizio, non traslativo
La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale (non contrattuale), non recettizio e non traslativo, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto. Richiede forma scritta ad substantiam e trascrizione “contro il rinunciante” (artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, c.c.), ma la trascrizione non ha efficacia costitutiva: serve a garantire l’operatività del principio di continuità e a soddisfare esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi.
L’effetto riflesso ex art. 827 c.c.: l’acquisto a titolo originario dello Stato
Una volta che l’immobile resti vacante, opera ex lege l’acquisto a titolo originario da parte dello Stato (art. 827 c.c.), senza necessità di accettazione né spazio per un “potere di rifiuto eliminativo”. È un effetto riflesso dell’atto abdicativo, non il suo oggetto immediato: la rinuncia non è proposta a uno Stato-destinatario secondo lo schema dell’art. 1333 c.c. Inoltre, l’acquisto non travolge automaticamente diritti reali preesistenti, né rende applicabili le nullità formali degli atti traslativi (urbanistica, catastale, APE).
“Fine egoistico”, meritevolezza e limiti del sindacato
La Corte esclude che il solo “fine egoistico” (disfarsi di beni gravosi) legittimi un giudizio di nullità per illiceità della causa o del motivo, immeritevolezza (art. 1322 c.c.) o abuso del diritto (art. 833 c.c.). La meritevolezza è intrinseca alla rinuncia in quanto modalità tipica di esercizio della facoltà dominicale di disposizione: l’atto “trova causa in sé stesso”, non nella controparte pubblica.
La funzione sociale è limite da attuare per legge, non clausola di nullità azionabile dal giudice caso per caso. Resta ferma l’azione revocatoria dei creditori, data la diminuzione patrimoniale del debitore.
Potrebbe interessarti anche:
Responsabilità pregresse e successione negli oneri
La rinuncia non estingue responsabilità pregresse (es. art. 2051 o 2053 c.c. se il fatto generatore è anteriore), che permangono in capo al rinunciante: la responsabilità per i danni che siano causalmente collegati alla proprietà di un immobile, e il cui fatto illecito generatore si rinvenga nella negligente costruzione/manutenzione o custodia dello stesso, persiste anche in caso di rinuncia abdicativa (e non liberatoria) al bene.
In forza dell’acquisto al patrimonio dello Stato, stabilito dall’art. 827 c.c., quest’ultimo diviene vincolato propter rem per i soli obblighi gestori sorti dopo la rinuncia, mentre le
responsabilità risarcitorie sorte anteriormente restano a carico del rinunciante.
La Corte coordina questi esiti con i principi sanciti in materia di inquinamento, richiamando, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite del 1° febbraio 2023, n. 3077, in tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati: l’obbligo di adottare le misure di messa in sicurezza idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio “chi inquina paga”, e non del proprietario incolpevole per il solo fatto che gli appartiene la titolarità del fondo.
L’incidenza della responsabilità per i danni recati a terzi dalla cosa, viceversa, non può individuarsi come limite della facoltà di disporne rinunziandovi, addossando al proprietario il dovere di rimanere tale, in maniera da agevolare la ricerca del soggetto obbligato a risarcire i medesimi danni connessi a detta qualità.
Equilibrio di bilancio e profili pubblicistici
Delineata la spettanza al patrimonio dello Stato ex art. 827 c.c. quale effetto riflesso, e non “interno”, della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, nemmeno può ergersi a ragione di non meritevolezza, ovvero a causa di nullità dell’atto privato di disposizione del bene la violazione del principio di cui all’art. 81, primo comma, Cost., che chiama lo Stato ad assicurare «l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico».
L’«equilibrio di bilancio» e la «copertura economica delle spese» (di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.) operano, secondo la giurisprudenza costituzionale, come «due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (Corte
cost., sentenze n. 165 del 2023, n. 44 del 2021, n. 274 del 2017 e n. 184 del 2016).
Si tratta, dunque, di clausole generali poste a presidio delle esigenze di finanza pubblica, implicate altresì dai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea ed operanti nel
sindacato di costituzionalità attinente a qualsiasi previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese.
L’art. 81 Cost. non funge, quindi, da regola di validità degli atti di autonomia privata: è parametro per la legislazione, non per invalidare la rinuncia abdicativa. La Corte ricorda, però, che spetta al legislatore rimodulare, se del caso, il regime dei beni immobili vacanti e dell’acquisizione al patrimonio pubblico, alla luce di esigenze di finanza pubblica e governo del territorio.
Distinzione dagli “abbandoni liberatori” tipici
Le Suprema Corte, poi, sottolinea l’estraneità rispetto al nucleo fondamentale del dubbio interpretativo posto, del dibattito sulle fattispecie di abbandono liberatorio (indicativamente, artt. 882, 963, 1104, 1070 c.c.). Queste ultime si caratterizzano per il tratto distintivo del perseguimento di una funzione che va oltre l’abdicazione e consiste nella liberazione da un’obbligazione connessa alla cosa, la quale deve essere adempiuta dal titolare del medesimo diritto reale che si dismette e nasce a carico di quest’ultimo nel momento in cui si verifica la circostanza prevista dalla legge per il suo sorgere, sicché, venuto meno lo ius ad rem che consente l’identificazione del soggetto debitore, vien meno anche la causa obligandi.
Pur convenendo con l’impostazione che la liberazione dall’obbligo di contribuire alle spese costituisce pur sempre un effetto e non la causa di queste fattispecie abdicative, quel che connota le stesse è l’interesse rilevante di altri soggetti (il comproprietario, il concedente, il proprietario del fondo dominante), i quali sono investiti a loro volta di un autonomo diritto reale ad utilizzare il medesimo bene.
Le fattispecie di abbandono liberatorio, quindi, perseguono una funzione liberatoria correlata a obbligazioni propter rem e sono qualitativamente diverse dalla rinuncia alla piena proprietà esclusiva, che è puramente abdicativa.
I principi di diritto enunciati
Le Sezioni Unite, alla luce delle suddette argomentazioni, cristallizzano i seguenti principi di diritto.
Sull’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare
1- La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un «altro contraente».
Sul perimetro del sindacato giudiziale sull’atto
2. – Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale».
Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
Conclusioni
La decisione delle Sezioni Unite rappresenta un intervento chiarificatore di portata sistemica: i principi di diritto enunciati forniscono un orientamento stabile per la prassi. Il titolare di un immobile, quindi, può rinunciare al diritto di proprietà anche per finalità esclusivamente personali, come sottrarsi, ad esempio, agli oneri di manutenzione, in quanto tale facoltà rientra nel contenuto del diritto dominicale ex art. 832 c.c.
La rinuncia abdicativa, quale atto di esercizio del potere di disposizione, non è suscettibile di essere dichiarata nulla, da parte del giudice, per illiceità della causa o del motivo, o per contrasto con l’art. 42, secondo comma, Cost., neppure quando mossa da un “fine egoistico”: le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, possono essere stabilite solo dal legislatore.