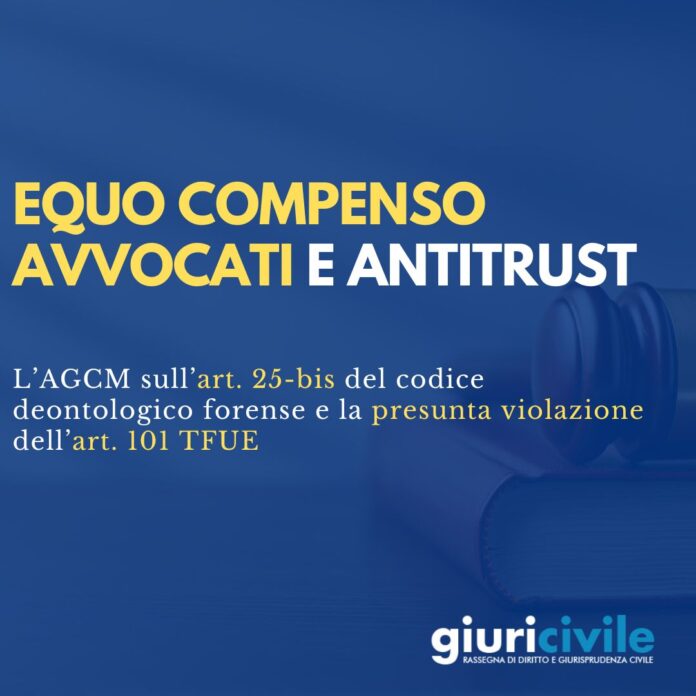
Per l’AGCM le condotte del CNF in tema di equo compenso ostacolano la concorrenza tra avvocati e configurano un’intesa in violazione dell’articolo 101 del TFUE. Pertanto, nella seduta del 24 marzo, la stessa AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria (articolo 14, legge n. 287/1990) verso il CNF, per accertare l’esistenza di un’intesa in violazione dell’articolo 101 del TFUE. Al contempo, ha fissato il termine di giorni 60, dalla notificazione del provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentite. Il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2026. Fulminea la reazione dell’Unione Camere Civili.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.
Il focus normativo
L’autorità Garante Della Concorrenza e del Mercato ha posto sotto la lente l’articolo 13, comma 3, L. n. 247/2012, secondo cui la pattuizione dei compensi tra avvocato e cliente è libera. In deroga a questo principio generale, quando la prestazione professionale è resa verso talune categorie di soggetti, la legge n. 49/2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, prevede che il compenso richiesto deve essere conforme ai parametri stabiliti, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della L. n. 247/2012, con decreto emanato dal Ministro della Giustizia (D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022).
La disciplina sull’equo compenso
L’articolo 5, comma 5, della Legge n. 49/2023 stabilisce che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e determinato secondo i parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali. La stessa norma prevede inoltre una sanzione deontologica per la violazione dell’obbligo di informare il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o qualunque accordo siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione deve in ogni caso rispettare, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla presente legge.
L’articolo 2 della medesima legge, definendo l’ambito soggettivo di applicazione, dispone che tale normativa si applica ai rapporti professionali resi a favore di banche, assicurazioni e loro controllate o mandatarie, medie e grandi imprese, pubblica amministrazione e sue partecipate (commi 1 e 3).
La modifica del Codice deontologico Forense
In base all’articolo 5, comma 5, della Legge n. 49/2023, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 23 febbraio 2024, ha approvato il testo del nuovo articolo 25-bis del Codice Deontologico Forense, dedicato alla disciplina dell’equo compenso.
L’articolo 25, comma 1, del Codice, intitolato “Accordi sulla definizione del compenso”, stabilisce in via generale il principio della libertà nella pattuizione: «La pattuizione dei compensi […] è libera». Il nuovo articolo 25-bis introduce un limite a tale libertà, disponendo che:
«L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti» (comma 1).
La violazione di tale divieto comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura (comma 3).
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 25-bis stabilisce che:
«Nei casi in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia».
Anche in questo caso, la violazione dell’obbligo informativo costituisce illecito disciplinare e comporta l’applicazione della sanzione dell’avvertimento (comma 3).
In sintesi, secondo la nuova disposizione del Codice Deontologico, l’avvocato:
-
non può pattuire compensi non conformi ai criteri di giustizia, equità e proporzionalità, né calcolati al di fuori dei parametri forensi;
-
ha l’obbligo, nei contratti predisposti unilateralmente, di informare per iscritto il cliente del rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione.
Le violazioni di tali obblighi comportano, rispettivamente, le sanzioni della censura e dell’avvertimento.
La definizione dei compensi
Circa la definizione dei compensi, la legge professionale ha introdotto i principi per cui “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale” e “la pattuizione dei compensi è libera” (articolo 13, commi 2 e 3, della L. n. 247/2012).
Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a informare il cliente sul livello della complessità dell’incarico e sui possibili costi e a “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale” (comma 5). I parametri cui rimanda la L. n. 49/2023 sono rappresentati, per la professione forense, dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
La legge in materia di equo compenso
Secondo quanto previsto dall’art. 1 della L. n. 49/2023 (rubricato “Definizione”), il compenso professionale è considerato equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme ai parametri previsti per ciascuna categoria professionale. In particolare, per quanto riguarda gli avvocati, si fa riferimento al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012, da applicarsi in assenza di accordo scritto tra le parti.
L’articolo 2 (rubricato “Ambito di applicazione”) definisce il perimetro soggettivo e oggettivo della disciplina.
Dal punto di vista soggettivo, la legge si applica ai rapporti professionali intercorrenti con:
-
banche,
-
imprese di assicurazione,
-
loro controllate o mandatarie,
-
medie e grandi imprese (secondo le definizioni del medesimo articolo),
-
pubbliche amministrazioni e loro partecipate (commi 1 e 3).
Sotto il profilo oggettivo, la disciplina dell’equo compenso si estende a tutti i rapporti regolati da convenzioni, così come a qualsiasi accordo preparatorio o definitivo che risulti vincolante per il professionista, purché contenga clausole predisposte unilateralmente dai cosiddetti “grandi clienti”.
L’art. 3 della legge (rubricato “Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo”) introduce una nullità di protezione per le pattuizioni che stabiliscono un compenso inferiore ai valori fissati dai parametri normativi, tra cui, per gli avvocati, quelli previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
L’articolo 5, comma 1, stabilisce inoltre che qualsiasi accordo, vincolante per il professionista, concluso con uno dei soggetti sopra indicati, si presume unilateralmente predisposto dal cliente, salvo prova contraria. Ne consegue che, in assenza di negoziazione effettiva, l’accordo si considera imposto al professionista.
Infine, l’art. 3, comma 5, riconosce al professionista la possibilità di far valere giudizialmente la nullità della clausola che prevede un compenso non equo. La competenza è attribuita al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del professionista.
La qualifica degli avvocati come “imprese”
Gli avvocati, in quanto prestano i propri servizi professionali a titolo oneroso, in forma indipendente e assumono, quindi, i rischi finanziari relativi allo svolgimento di tali servizi, svolgono attività economica e possono, per l’AGCM, essere qualificati come imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, senza che la circostanza che l’esercizio della professione sia regolamentato possa far pervenire a conclusioni diverse. Secondo la medesima Autorità è ormai acquisito che anche le professioni regolamentate sono soggette al diritto antitrust.
Il CNF come “associazione di imprese”
La natura vincolante del codice deontologico rispetto agli avvocati, nonché la possibilità di infliggere loro sanzioni in caso di inosservanza del predetto codice, per l’AGCM permettono di qualificare l’adozione e la diffusione del Codice aggiornato, nonché della sua Relazione sul sito internet, delle descritte comunicazioni (email), unitamente allo schema sanzionatorio relativo all’articolo 25-bis, comma 1, del Codice, adottati e diffusi dallo stesso CNF che agisce come ente rappresentativo di imprese, quali condotte costitutive di una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.
La qualificazione anticoncorrenziale dell’articolo 25-bis del Codice
La disciplina dell’equo compenso, introdotta dal legislatore per offrire tutela ai professionisti nei rapporti con i grandi clienti, come definiti dall’articolo 2 della L. n. 49/2023, nella presunzione che il professionista subisca – limitatamente a questa specifica categoria di clienti – il potere contrattuale della controparte e sia, quindi, costretto ad accettare compensi “al ribasso”, inferiori a quelli che normalmente applicherebbe.
Nel recepire il contenuto dell’articolo 5, comma 5, della L. n. 49/2023, il CNF avrebbe dovuto offrire con chiarezza l’interpretazione più aderente possibile al dettato normativo, in modo da circoscriverne in concreto l’applicazione soltanto alle prestazioni rese in favore dei grandi clienti, in quanto presuntivamente in grado di esercitare il proprio potere contrattuale nei confronti degli avvocati.
Le contestazioni
Secondo l’AGCM, il comma 1 dell’articolo 25-bis del Codice deontologico forense, così come le sanzioni disciplinari previste dal CNF per entrambe le ipotesi di violazione individuate dal legislatore, attribuirebbero alla disciplina dell’equo compenso una portata più estesa rispetto a quanto previsto dalla legge.
In particolare, l’Autorità contesta l’utilizzo, da parte del CNF, di una formulazione ampia e generica – “l’avvocato non può concordare o preventivare un compenso […]” – la quale si riferisce a qualsiasi pattuizione scritta, senza limitazioni. Tuttavia, secondo l’art. 13, comma 2, della legge professionale, la forma scritta del compenso rappresenta la regola “di norma”, lasciando spazio a eccezioni.
Per l’AGCM, il CNF non avrebbe adeguatamente circoscritto l’ambito applicativo della disposizione, omettendo di specificare che la sanzionabilità è riferibile unicamente ai rapporti professionali intercorsi con i cosiddetti grandi clienti, come previsto invece dal comma 1 dell’art. 5 della L. n. 49/2023. Quest’ultima norma, infatti, richiama espressamente “gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all’articolo 2 […]”, limitando così il campo di applicazione della disciplina in materia.
Il pregiudizio al commercio intraeuropeo
L’AGCM ha rilevato che le condotte contestate interessano l’intero territorio italiano e che la Commissione UE ha indicato che “gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato”26. Pertanto, la fattispecie individuata dalla medesima Autorità è apparsa idonea, laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri ed è suscettibile di integrare una violazione dell’articolo 101 del TFUE.
La reazione dell’Unione Nazionale Camere Civili
Con una nota datata 16 aprile e intitolata “La tutela della professione forense non può essere subordinata alle logiche del mercato”, l’Unione Nazionale Camere Civili ha espresso preoccupazione in merito all’istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, accusato di violazione dell’art. 101 TFUE per aver introdotto l’art. 25-bis nel Codice deontologico.
Secondo l’Unione, la delibera dell’Autorità non solleva solo dubbi nel merito, ma ha anche implicazioni sistemiche rilevanti, in quanto incide sulla funzione costituzionale della professione forense e sulla qualità del servizio giustizia. In particolare, si contesta l’assunto dell’AGCM secondo cui l’avvocato sarebbe un’impresa e il CNF un’“associazione di imprese”, soggetti integralmente assoggettabili alla disciplina antitrust. Tale impostazione – osserva l’Unione – contrasta con l’art. 2 della Legge n. 247/2012, che definisce l’avvocatura come libera e indipendente e indispensabile per l’attuazione della giurisdizione.
Equiparare l’attività forense a una comune prestazione commerciale, prosegue la nota, significa disconoscerne la funzione pubblicistica e ridurla a un’attività puramente economica, con conseguente rischio di svilimento della funzione difensiva e del diritto all’assistenza legale di qualità.
L’Unione prende quindi posizione a favore del CNF, evidenziando come quest’ultimo abbia semplicemente dato attuazione all’obbligo normativo previsto dall’art. 5, comma 5, della L. n. 49/2023, introducendo nel Codice deontologico una disposizione esecutiva. L’art. 25-bis, dunque, non deriverebbe da una scelta regolatoria autonoma, ma costituirebbe attuazione vincolata della legge, funzionale a garantire l’effettività del principio dell’equo compenso.
L’AGCM contesta inoltre al CNF di aver esteso l’ambito soggettivo della disciplina anche ai rapporti con i c.d. “piccoli clienti”. Su questo punto, l’Unione sottolinea come il principio dell’equo compenso debba intendersi di portata generale, in quanto espressivo della dignità della prestazione professionale. Tale interpretazione trova riscontro tanto nell’art. 3 della L. n. 247/2012 – che impone all’avvocato di esercitare la professione nel rispetto del decoro, della dignità e della lealtà – quanto nell’art. 13, che richiama i parametri ministeriali non solo in sede contenziosa, ma anche quale criterio di trasparenza nei confronti del cliente.
Viene inoltre evidenziato come le sanzioni disciplinari previste – la censura e l’avvertimento – non costituiscano strumenti di limitazione della concorrenza, bensì strumenti di regolazione etica interna, espressamente previsti dalla L. n. 247/2012 (art. 53), con la finalità di impedire che l’avvocato svaluti la propria opera fino a comprometterne la qualità.
Secondo l’Unione, l’interpretazione dell’AGCM – che ravvisa nell’art. 25-bis l’introduzione di tariffe minime – è infondata. Nessuna tariffa è stata imposta, ma è stato semplicemente ribadito l’obbligo di rispettare un criterio di equità, con riferimento ai parametri forensi, che costituiscono una soglia orientativa, non un prezzo vincolante.
L’AGCM – conclude l’Unione – confonde una previsione normativa con una presunta iniziativa anticoncorrenziale. L’Autorità attribuirebbe al CNF intenzioni e conseguenze che non sussistono, fraintendendo la funzione di tutela sottesa all’intervento deontologico.
In chiusura, l’Unione Camere Civili afferma che la delibera AGCM rischia paradossalmente di rafforzare i poteri economici forti, ostacolando la funzione pubblicistica dell’avvocatura e alterando l’equilibrio tra libertà economica e tutela effettiva dei diritti fondamentali.













