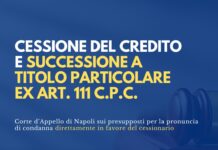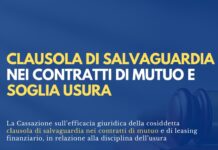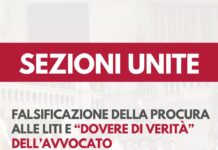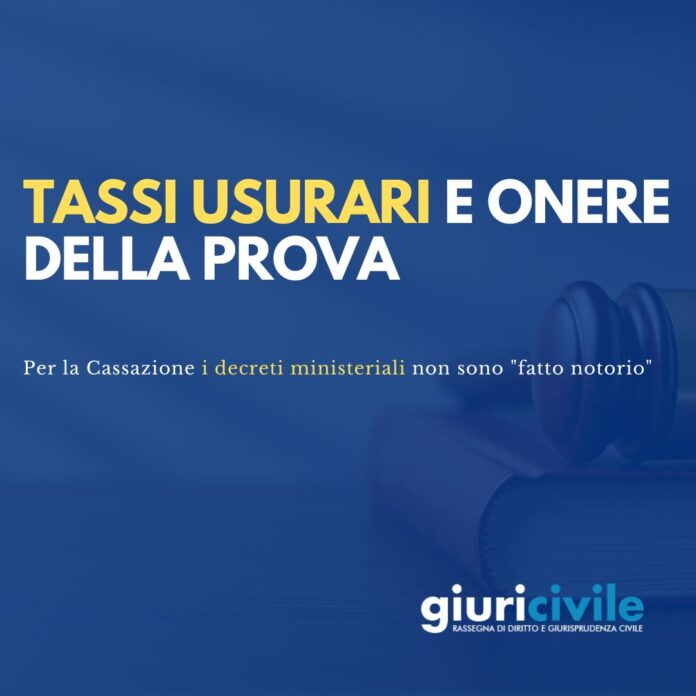
La corretta qualificazione giuridica dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 108/1996, e la conseguente ripartizione dell’onere probatorio in materia di usura bancaria, rappresentano una questione di centrale importanza nel contenzioso tra intermediari e clienti. Con la recente ordinanza n. 24197 del 29 agosto 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema, ribadendo un orientamento rigoroso che pone a carico della parte che lamenta l’usurarietà dei tassi l’onere di produrre in giudizio i suddetti decreti. La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale non pacifico, alimentando un contrasto che genera incertezza e che merita un’attenta analisi.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, segnaliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
Leggi descrizione
Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi, 2025, Maggioli Editore
47.00 €
44.65 €

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
Il caso e la decisione della Suprema Corte
La società utilizzatrice conveniva in giudizio la banca per accertare la natura usuraria del tasso degli interessi moratori e di altre componenti del costo del finanziamento. Le domande venivano rigettate sia in primo grado dal Tribunale di Milano che in secondo grado dalla Corte d’appello, la quale, applicando i criteri indicati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020), aveva calcolato un tasso soglia per gli interessi di mora pari al 18,825%, ritenendolo non superato da quello pattuito contrattualmente.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, tra i vari motivi, un’errata applicazione della normativa antiusura. È nell’esaminare questa censura che la Terza Sezione, nel dichiarare il motivo inammissibile, enuncia un principio processuale di notevole impatto. La Corte, infatti, sottolinea come la ricorrente non avesse né indicato lo snodo processuale in cui i decreti ministeriali sarebbero stati prodotti in giudizio, né riprodotto il loro contenuto nel ricorso, impedendo di fatto alla Corte stessa ogni verifica.
Su questa base, richiamando un suo precedente (Cass. n. 26525/2024), la Corte ribadisce che l’ammontare del tasso soglia non è un fatto notorio, poiché non rientra nel bagaglio di conoscenze comuni, ma richiede una consultazione specialistica. Né, tantomeno, può considerarsi soggetto al principio iura novit curia. La ragione risiede nella natura giuridica dei decreti: essi non sono atti normativi, ma vengono qualificati come atti amministrativi a contenuto tecnico.
La fonte dell’obbligo legale è la Legge 108/1996; il decreto ministeriale si limita a rilevare un dato economico (il Tasso Effettivo Globale Medio) che funge da parametro per rendere operativa la norma primaria. In quanto tale, non rientra tra le fonti del diritto che il giudice è tenuto a conoscere d’ufficio.
Il contrasto giurisprudenziale sulla natura dei decreti
L’approccio rigoroso adottato dalla Terza Sezione non è, tuttavia, unanimemente condiviso all’interno della stessa Corte di Cassazione. Si registra, infatti, un significativo contrasto giurisprudenziale con un diverso orientamento, prevalentemente seguito dalla Prima e dalla Seconda Sezione Civile. Secondo questa seconda e opposta impostazione, i decreti ministeriali avrebbero un “carattere integrativo della normativa dettata in via generale”.
La norma primaria (art. 2, L. 108/1996) viene letta come una “norma in bianco”, volutamente generica, che per poter essere applicata necessita del dato tecnico fornito periodicamente dai decreti. Legge e decreto, dunque, formerebbero una fattispecie a formazione progressiva, un complesso normativo unitario e inscindibile. Di conseguenza, se la legge è soggetta al principio iura novit curia, lo stesso trattamento deve essere riservato ai decreti che la completano e le danno concretezza. Per questo filone giurisprudenziale, il giudice non solo può, ma deve acquisire d’ufficio la conoscenza di tali decreti per poter decidere la controversia (in termini: Cass. Sez. 2, n. 5593/2025; Cass. Sez. 1, n. 16602/2024; Cass. Sez. 1, n. 35102/2022).
A rendere il quadro ancora più complesso, si segnala come la stessa Terza Sezione, in passato, avesse aderito a quest’ultimo orientamento (Cass. Sez. 3 n. 8883/2020), mostrando un’evidente oscillazione interpretativa che solo le più recenti pronunce sembrano ora voler superare, consolidandosi sulla tesi della natura amministrativa e non normativa dei decreti.
Leggi anche:
- Mutuo e usura: cosa entra davvero nel TEG e quando si configura la nullità
- La clausola di salvaguardia nei contratti di mutuo: funzione, limiti e nullità originaria degli interessi usurari
Conseguenze sull’onere della prova e l’incertezza del diritto
Le implicazioni pratiche dei due orientamenti sono profonde. Accogliere la tesi dell’ordinanza n. 24197/2025 significa porre l’onere della prova in modo netto e gravoso a carico del cliente-attore. Egli deve attivarsi per una produzione documentale specifica: ricercare, individuare e depositare in atti tutti i decreti ministeriali rilevanti per la durata del rapporto contestato. Un’omissione o un errore in questa fase può risultare fatale, portando al rigetto della domanda per carenza probatoria, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa. Ciò comporta un notevole dispendio di energie processuali e richiede una diligenza particolare da parte del difensore.
Al contrario, la tesi del carattere integrativo alleggerisce il carico probatorio della parte. Al cliente basterebbe produrre il contratto e allegare i fatti (i tassi applicati), mentre spetterebbe al giudice, in virtù dei suoi poteri d’ufficio, reperire i decreti necessari per verificare il superamento del tasso soglia. Questa seconda via appare più in linea con il principio di prossimità della prova e con una maggiore tutela della parte considerata contrattualmente più debole.
Questa divergenza interpretativa all’interno della Suprema Corte crea una significativa incertezza del diritto, con il rischio che l’esito di un processo dipenda non solo dalla fondatezza della domanda, ma anche dalla Sezione della Corte chiamata a decidere in ultima istanza. Appare pertanto sempre più urgente e auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, al fine di comporre il contrasto e fornire agli operatori del diritto un principio univoco e stabile, garantendo così la parità di trattamento e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in una materia così delicata e diffusa.