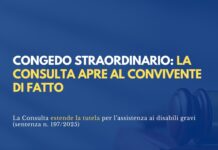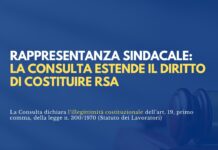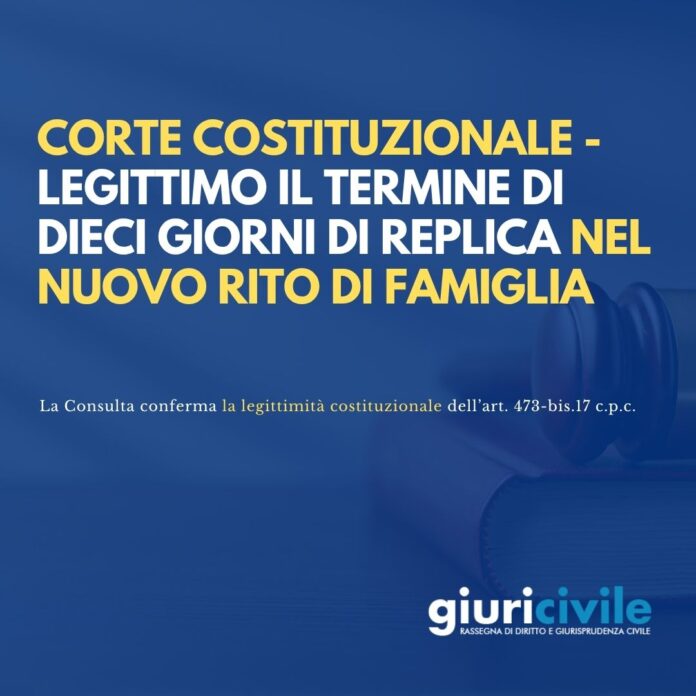
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 13 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 473-bis.17 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La decisione conferma la legittimità del termine di dieci giorni previsto per le repliche dell’attore alla domanda riconvenzionale del convenuto nel nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla Riforma Cartabia.
Consiglio: il “Formulario commentato della famiglia e delle persone”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, si configura come uno strumento completo e operativo per impostare un’efficace strategia difensiva.
La tensione tra efficienza processuale e garanzie costituzionali
L’entrata in vigore del rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha rappresentato una svolta strutturale nel processo civile italiano.
L’obiettivo dichiarato del legislatore – in attuazione della legge delega n. 206 del 2021 – è quello di semplificare, accelerare e rendere omogenee le forme del contenzioso familiare, tradizionalmente afflitto da lentezze, frammentazioni e incertezze applicative. Tuttavia, la tensione tra esigenze di celerità e garanzie del contraddittorio non poteva non sollevare questioni di compatibilità costituzionale, specie nei punti in cui il nuovo rito incide in modo significativo sull’architettura delle decadenze e sui termini di difesa.
La sentenza n. 146 del 2025 della Corte costituzionale, si colloca in questo crocevia, affrontando una delle questioni più delicate sorte all’indomani della riforma Cartabia: la legittimità dell’art. 473-bis.17 c.p.c., nella parte in cui impone all’attore, a pena di decadenza, di proporre domande ed eccezioni conseguenti alle difese del convenuto entro il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione, con la conseguente riduzione – nei fatti – del tempo di replica a soli dieci giorni.
La pronuncia offre un terreno privilegiato per interrogarsi sull’attuale perimetro della discrezionalità legislativa in materia processuale, sui limiti del sindacato costituzionale in tale ambito e, più in generale, sull’idea di giusto processo delineata dall’art. 111 Cost. nella sua dimensione dinamica, ossia come equilibrio costante tra effettività delle garanzie e ragionevole durata del giudizio.
Il caso: l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Genova
Il Tribunale ordinario di Genova, con ordinanza del 4 settembre 2024, si è trovato a giudicare una controversia in materia familiare originata dalla domanda di modifica delle condizioni di separazione proposta da una coniuge nei confronti dell’ex marito, cui si era contrapposta una domanda riconvenzionale di divorzio.
A fronte della riconvenzionale, l’attrice aveva lamentato di disporre di un termine irrisorio – dieci giorni – per predisporre una difesa adeguata, comprensiva di eventuali istanze istruttorie e domande accessorie (in particolare, quella di assegno divorzile, fondata su presupposti differenti rispetto all’assegno di mantenimento).
Il giudice rimettente ha ritenuto che tale disciplina processuale potesse determinare una compressione eccessiva del diritto di difesa, ponendosi in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., e al contempo introdurre una disparità di trattamento rispetto agli altri riti civili (ordinario, semplificato e del lavoro), ove all’attore è riconosciuto un tempo più ampio per reagire alle difese della controparte.
La questione, dunque, tocca il nodo sistemico della ragionevolezza dei termini processuali in rapporto al principio di parità delle armi e al canone di proporzionalità delle limitazioni difensive, che nella giurisprudenza costituzionale rappresenta il discrimine tra legittimo esercizio della discrezionalità legislativa e violazione del diritto di azione e difesa.
Potrebbero interessarti anche:
- Reclamabilità dei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.
- Correttivo del Processo Civile in vigore: guida alle novità (+ testo integrale in pdf)
- Decreto Giustizia 2025: rinvii per Tribunale Famiglia e riforma del giudice di pace – guida completa
- Allegazione di fatti di violenza domestica nel processo civile e rischio di vittimizzazione secondaria
Le eccezioni preliminari e il perimetro del giudizio di legittimità costituzionale
Il giudizio incidentale si è aperto con tre eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
La questione di rilevanza
In primo luogo, si è contestata la rilevanza della questione, sostenendo l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di divorzio all’interno di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
La Corte ha tuttavia ritenuto l’argomentazione del rimettente non implausibile, valorizzando il precedente della Cass., sez. I, n. 28727/2023, che ammette la connessione tra separazione e divorzio anche nell’ambito del rito unificato ex art. 473-bis.51 c.p.c. Tale soluzione, coerente con l’impostazione teleologica della riforma, evita una frammentazione processuale contraria al principio di concentrazione.
Il termine concretamente disponibile
La seconda eccezione, relativa al fatto che nel caso concreto l’attrice avrebbe avuto sedici giorni (e non dieci), è stata disattesa poiché la Corte ha ribadito che la rilevanza della questione non dipende dalla durata effettiva del termine nel caso singolo, bensì dalla necessità di applicare la norma censurata da parte del giudice a quo.
L’indeterminatezza del petitum
Infine, la Corte ha respinto l’eccezione di indeterminatezza, riaffermando la propria consolidata giurisprudenza secondo cui essa non è vincolata al modello correttivo proposto dal giudice rimettente, potendo essa stessa individuare la soluzione più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata (v. sentt. n. 53/2025 e n. 46/2024).
La decisione nel merito: discrezionalità legislativa e ragionevolezza dei termini processuali
Nel merito, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
La motivazione si articola lungo due direttrici complementari: da un lato, la riaffermazione della ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale; dall’altro, la verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina censurata alla luce dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
L’ambito della discrezionalità legislativa
La Corte richiama la propria giurisprudenza costante (sentt. n. 36, 39 e 76/2025; n. 96/2024), secondo cui la legge può differenziare la tutela giurisdizionale in base alla natura dei rapporti da regolare, purché non renda impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa.
In tal senso, il rito unificato della famiglia, improntato a speditezza e concentrazione, risponde a un obiettivo costituzionalmente legittimo: quello di garantire la ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), in un ambito in cui l’interesse dei minori e la stabilità degli assetti familiari impongono tempi certi e soluzioni rapide.
La prevedibilità delle difese e la funzione del termine decennale
Secondo la Corte, la previsione di un termine minimo di dieci giorni non è irragionevole, poiché l’attore può prevedere le reazioni difensive del convenuto, che devono essere oggettivamente connesse alla domanda introduttiva. In altre parole, nel rito familiare l’oggetto del processo e i diritti azionati sono tipizzati, e ciò consente una maggiore anticipazione difensiva rispetto ad altri riti.
La Corte sottolinea, inoltre, che la riforma del 2022 ha previsto significative valvole di flessibilità, come l’art. 473-bis.19 c.p.c., che limita le decadenze ai soli diritti disponibili e consente la libera introduzione di nuove domande in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori.
Il principio di parità delle armi
Quanto al parametro dell’art. 111 Cost., la Corte ribadisce che il principio del contraddittorio non implica una perfetta simmetria temporale tra le parti, ma soltanto la pariteticità degli strumenti di tutela.
La differenza tra i termini concessi ad attore e convenuto si giustifica in ragione della diversa posizione processuale: mentre il convenuto è colto di sorpresa dall’iniziativa di parte attrice, quest’ultima conosce ex ante la materia del contendere e può anticipare strategie difensive coerenti con l’oggetto del giudizio.
Il raffronto con altri riti e il principio di eguaglianza
La Corte respinge infine la censura di violazione dell’art. 3 Cost., rilevando che i tertia comparationis (riti ordinario, semplificato e del lavoro) sono eterogenei rispetto al rito della famiglia.
Solo in apparenza, infatti, i termini appaiono più ampi: la peculiarità del rito unificato – che prevede una sequenza preliminare funzionale alla definizione del thema decidendum prima dell’udienza – giustifica la maggiore compressione temporale, controbilanciata da successivi margini di integrazione istruttoria e dalla possibilità di rimessione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c.
Conclusioni: la misura della ragionevolezza tra diritto di difesa e durata del processo
La sentenza n. 146/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza costituzionale sempre più attenta al bilanciamento funzionale tra garanzie e efficienza, riaffermando la centralità della discrezionalità legislativa processuale entro il limite della non manifesta irragionevolezza.
Pur riconoscendo che il termine di dieci giorni impone un notevole sforzo organizzativo alla difesa attorea, la Corte individua nell’assetto complessivo del rito – con i suoi meccanismi di prevedibilità, elasticità e rimessione in termini – un equilibrio idoneo a soddisfare i canoni costituzionali del giusto processo.
Tuttavia, la decisione non è priva di margini critici. Essa conferma un orientamento di autolimitazione del sindacato costituzionale, che tende a privilegiare la stabilità dell’impianto riformatore rispetto alla verifica puntuale dell’effettività delle garanzie difensive. In questa prospettiva, il diritto di difesa appare declinato non tanto come diritto alla piena esplicazione della dialettica processuale, quanto come diritto a un margine ragionevole di esercizio, suscettibile di compressione ove l’interesse pubblico alla celerità lo imponga.
La pronuncia segna dunque una tappa significativa nel percorso di assestamento del nuovo processo della famiglia, destinato a ridefinire i confini tra fair trial e fast trial.
Resta affidato alla prassi applicativa – e, in prospettiva, alla dottrina – il compito di verificare se l’“efficienza temperata” disegnata dal legislatore e avallata dalla Corte costituzionale sia realmente compatibile con l’idea di difesa effettiva che la Costituzione, nella sua dimensione personalistica, continua a presidiare come valore fondante dell’ordinamento.