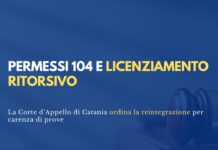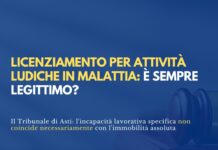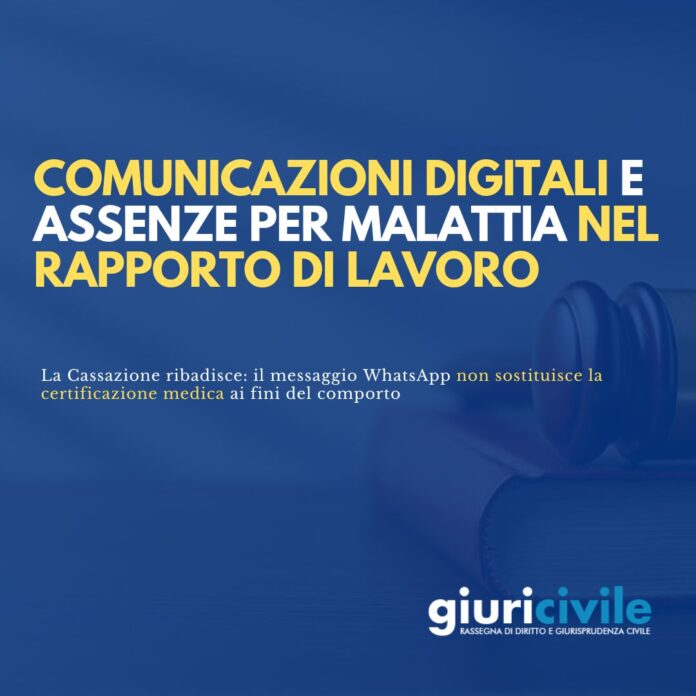
La risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto rappresenta una delle aree più complesse e delicate del diritto del lavoro, situandosi al crocevia tra la tutela del diritto alla salute del lavoratore (art. 32 Cost.) e la salvaguardia dell’interesse organizzativo ed economico del datore di lavoro.
La rilevanza di tale questione si acuisce qualora ci troviamo dinanzi a patologie gravi, ovvero quelle che richiedono terapie salvavita, come la chemioterapia, radioterapia ed emodialisi.
Nell’attuale contesto della comunicazione digitale, l’utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea, infatti, ha progressivamente acquisito una rilevanza significativa nelle relazioni professionali, ponendo questioni di particolare complessità in ordine alla validità e all’efficacia delle comunicazioni trasmesse, soprattutto con riferimento alla comunicazione e alla giustificazione delle assenze per malattia.
Ciò premesso, l’attuale orientamento giurisprudenziale propende per il riconoscimento di dignità probatoria a strumenti quali e-mail, SMS e messaggi di chat (come WhatsApp), seppur con specifici limiti e condizioni.
Per cui, il presente contributo si focalizzerà sull’analisi della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26956 del 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), che affronta con rigore tali questioni, offrendo un importante chiarimento in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto e precisando che non ogni malattia di lunga durata o di particolare gravità clinica consente di beneficiare dell’esclusione dal comporto, ma soltanto quelle che, per la loro natura e per la terapia necessaria, rientrano nel novero delle cosiddette “terapie salvavita”, e che tale condizione deve risultare da idonea certificazione medica.
Analisi della sentenza
Il caso in oggetto riguardava un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto dopo aver superato i giorni di malattia consentiti dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Il dipendente sosteneva che la propria patologia, trattata con dialisi, dovesse rientrare tra quelle escluse dal conteggio del periodo di comporto. La Corte d’Appello di Ancona aveva ritenuto legittimo il recesso, rilevando che nei certificati medici mancava l’indicazione di una “patologia grave che richiede terapia salvavita” e che le comunicazioni informali non potevano sostituire la certificazione sanitaria.
Consiglio: per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”, a cura di Federico Torzo (clicca qui per iscriverti).
Confermando tale impostazione, la Corte di Cassazione ha precisato che la nozione di “malattia particolarmente grave” si riferisce solo a patologie che comportano terapie salvavita, indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento essenziale della qualità della vita, e che la relativa condizione deve risultare da documentazione medica ufficiale.
La Corte ha inoltre sottolineato che grava sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza della patologia e della necessità della terapia salvavita, non potendo rilevare semplici comunicazioni o conoscenze informali del datore di lavoro, come ad esempio dei messaggi inviati tramite Whatsapp.
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento e ribadendo che l’esclusione delle assenze dal computo del comporto richiede una prova rigorosa e formalmente conforme agli obblighi di certificazione previsti dalla legge e dal contratto collettivo.
L’analisi di tale sentenza consente di approfondire due aspetti cruciali.
1. L’interpretazione della nozione di “malattia particolarmente grave”
La pronuncia in commento fornisce un’importante chiave interpretativa della locuzione “malattia particolarmente grave”, spesso utilizzata in maniera generica dalla contrattazione collettiva. Secondo la Cassazione, tale espressione deve essere intesa come riferita esclusivamente alle patologie che richiedono terapie salvavita, ancorando così il concetto di gravità a un dato oggettivo e verificabile.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
L’approccio adottato si allinea a quanto già previsto da alcuni contratti collettivi: basti pensare all’art. 57 del CCNL Sanità, che esclude dal comporto le assenze dovute a patologie che necessitano di trattamenti salvavita, comprendendo espressamente la chemioterapia, la radioterapia e l’emodialisi. Analogamente, altri contratti del settore sociosanitario e assistenziale richiamano le medesime condizioni per attivare specifiche tutele. La Corte eleva dunque tale prassi a criterio interpretativo generale, garantendo uniformità applicativa e riducendo il rischio di soluzioni difformi.
Trattasi dunque di una scelta coerente con l’impostazione già tracciata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 87 del 2013, che aveva riconosciuto al legislatore un ampio margine di discrezionalità nel bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità organizzativa. In assenza di una disciplina legislativa generale, la Cassazione interviene quindi a colmare un vuoto, fornendo un parametro chiaro e ragionevole per l’interpretazione delle clausole contrattuali in materia di comporto.
2. L’onere della prova a carico del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a seguire scrupolosamente le procedure previste dal CCNL o dalle policy aziendali per comunicare l’assenza; l’omissione di tali adempimenti può rendere l’assenza “ingiustificata”, anche se lo stato di malattia è effettivo, legittimando quindi una sanzione disciplinare che, in caso di assenza prolungata, può culminare nel licenziamento per giusta causa.
Pertanto, la disciplina delle assenze per malattia impone al lavoratore specifici obblighi informativi, che devono essere distinti: la comunicazione dell’assenza e la trasmissione della certificazione medica.
La comunicazione dell’assenza
In virtù dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), il lavoratore ha il dovere di informare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza.
Tale comunicazione, le cui modalità sono generalmente disciplinate all’interno della contrattazione collettiva, ha una finalità prettamente organizzativa, ovvero quella di consentire al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per sopperire alla mancanza del dipendente.
Ad esempio, il CCNL Turismo, come anche quello per gli addetti all’Industria Metalmeccanica e alla installazione impianti, prevedono che:
“Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore; […]”.
Sebbene molti CCNL indichino canali tradizionali, l’invio di un messaggio WhatsApp può essere considerato idoneo a soddisfare l’obbligo di comunicazione tempestiva, purché il datore di lavoro sia messo in condizione di riceverlo e leggerlo.
Potrebbero interessarti anche:
- Convalida delle dimissioni nel periodo di prova: tutela della genitorialità e interpretazione ministeriale
- Licenziamento durante la gravidanza: legittimo se la condotta è dolosa e gravemente sleale
- Uso improprio del congedo parentale: giustifica il licenziamento per abuso del diritto
- Il controllo investigativo del datore di lavoro: i limiti statutari e la giusta causa di licenziamento
- Condotta extralavorativa e licenziamento per giusta causa: il contratto tra fiducia e funzione sociale
- Messaggi WhatsApp come prova del credito
La trasmissione della certificazione medica
La comunicazione dell’assenza non sostituisce l’obbligo di giustificarla mediante certificazione medica. La procedura standard prevede che il medico curante trasmetta telematicamente il certificato all’INPS, che a sua volta lo rende disponibile al datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato.
A titolo meramente esemplificativo il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, tra i tanti, prevede che:
“Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante;[…]”.
Ne deriva dunque che, nel contesto della malattia, un messaggio WhatsApp ha solo valore di “notizia”, ma non sostituisce la certificazione medica formale né sana il mancato rispetto delle procedure prescritte.
A tal ultimo riguardo, un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Cremona n. 373/2024, che ha confermato il licenziamento di un dipendente assente per malattia all’estero che aveva comunicato la propria condizione via WhatsApp e fax, senza fornire certificazione medica validamente legalizzata. Il giudice ha ritenuto l’assenza ingiustificata, configurando un inadempimento grave e tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
Rischi legati alla comunicazione “informale”
L’utilizzo di canali di comunicazione informali, se non correttamente gestito, espone entrambe le parti del rapporto di lavoro a significativi rischi di natura legale e organizzativa.
Per il lavoratore, il primo pericolo è quello di non adempiere correttamente agli obblighi contrattuali, poiché molti CCNL prevedono modalità specifiche (telefonata, e-mail, fax) per la comunicazione dell’assenza: l’uso di canali non ufficiali può configurare inadempimento. Ne consegue anche il rischio di sanzioni disciplinari qualora l’assenza venga ritenuta “ingiustificata”, salvo che il lavoratore dimostri l’esistenza di cause di forza maggiore.
Per il datore di lavoro, l’accettazione reiterata di comunicazioni informali può generare prassi aziendali ambigue, rendendo difficile contestare in futuro comportamenti simili. Inoltre, l’utilizzo di chat private come prove disciplinari potrebbe integrare una violazione della segretezza delle comunicazioni e, astrattamente, rendere illegittimo il licenziamento fondato su tali elementi.
Suggerimenti operativi
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene opportuno formulare i seguenti suggerimenti di carattere operativo:
- Definire policy aziendali chiare: è essenziale predisporre regolamenti interni che indichino in modo preciso e inequivocabile i canali ufficiali e le tempistiche da seguire per la comunicazione delle assenze per malattia, evitando ambiguità e riducendo il rischio di utilizzo improprio di canali informali.
- Gestire con cautela le comunicazioni via WhatsApp: qualora un lavoratore comunichi informalmente la propria assenza, è opportuno che il datore ne prenda atto e lo inviti a completare la procedura formale, assicurando in tal modo la piena tracciabilità delle comunicazioni e la conformità alla normativa contrattuale.
In conclusione, la recente interpretazione giurisprudenziale fornita dalla sentenza n. 26956/2025, che lega l’esenzione per “malattie particolarmente gravi” alla necessità di “terapie salvavita”, introduce un utile criterio di oggettività, ma al contempo rafforza il principio di auto-responsabilità del lavoratore. Emerge con chiarezza che la tutela, anche in situazioni di grave difficoltà personale e sanitaria, non è mai automatica, ma è subordinata al rigoroso rispetto di oneri formali di comunicazione e prova. Nell’era digitale, la facilità di comunicazione non attenua la necessità di rispettare le procedure: anzi, ne amplifica l’importanza, poiché solo la corretta formalizzazione degli atti può garantire trasparenza e tutela effettiva.