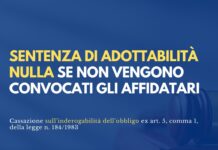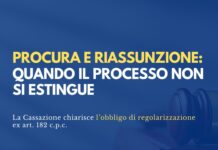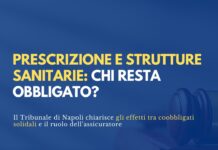L’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 13 novembre 2025 (RG 454/2025), n. cron. 2061/2025 (puoi leggerla cliccando qui), relativa alla vicenda della cosiddetta “Famiglia nel bosco”, ha assunto rilievo non solo giudiziario, ma anche sociologico, mediatico e istituzionale. La decisione, infatti, costituisce quasi un “caso-scuola” in cui convergono temi centrali del diritto minorile contemporaneo: dalla gestione dell’isolamento socio-familiare, all’applicazione graduata degli strumenti previsti dagli artt. 330 e 333 c.c. Ecco, di seguito, un’analisi approfondita della pronuncia, con focus sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il quadro fattuale e istruttorio nella prospettiva sistemica della nozione di “pregiudizio”
La ricostruzione fattuale operata dal Tribunale costituisce il punto di partenza necessario per comprendere la successiva qualificazione giuridica del caso. Essa mostra una progressiva emersione di elementi di criticità, inizialmente confinati alla sfera materiale (condizioni abitative, mancanza di istruzione e assistenza sanitaria), ma successivamente estesi alla sfera comportamentale (rifiuto di cooperazione, ostacolo all’accesso dei servizi) e infine alla sfera relazionale e identitaria (isolamento, esposizione mediatica indebita dei minori).
Le prime segnalazioni e la situazione abitativa
La vicenda prende avvio da una segnalazione dei servizi sociali territoriali, preoccupati per le condizioni di vita di tre minori residenti con i genitori in un’area montana isolata. L’abitazione risulta essere un rudere privo di agibilità, senza energia elettrica, acqua corrente, riscaldamento e senza alcuna certificazione sulla sicurezza statica. Parte della vita familiare si svolge in una piccola roulotte posta all’esterno, utilizzata non come soluzione di emergenza, ma come spazio abitativo ordinario.
I successivi sopralluoghi dei Carabinieri confermano il quadro di precarietà: ambienti interni con arredi minimi, assenza di dispositivi per la conservazione e preparazione dei cibi, condizioni igieniche compromesse, mancanza di illuminazione esterna e difficoltà di accesso alla zona, specie in condizioni meteo avverse. La carenza di requisiti edilizi essenziali, tra cui il collaudo statico, integra, per il Tribunale, una presunzione legale di pericolosità, non una semplice irregolarità amministrativa.
Assenza di cure sanitarie e rifiuto degli accertamenti
Contestualmente emerge la totale assenza di assistenza sanitaria. Nessuno dei minori risulta iscritto presso un pediatra di libera scelta; non sono stati eseguiti controlli di routine né vaccinazioni; i genitori dichiarano esplicitamente di non volere sottoporre i figli a visite mediche. In un episodio documentato, la madre avrebbe subordinato l’accompagnamento a una visita pediatrica al versamento di 50.000 euro per ciascun minore: un comportamento che il giudice interpreta come espressione di un rifiuto radicale e ingiustificato dei doveri di cura.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
Isolamento relazionale ed educativo
Le relazioni dei servizi sociali attestano una pressoché totale assenza di vita di relazione. I minori non frequentano la scuola, non sono iscritti presso istituti del territorio né risultano attivate procedure di istruzione parentale conformi alla normativa. Le difficoltà nella lingua italiana e la limitata capacità di interazione con l’esterno sono interpretate come segni di deprivazione culturale e relazionale.
Anche i tentativi di creare un canale educativo o sanitario, attraverso visite domiciliari o convocazioni istituzionali, risultano frustrati dall’atteggiamento oppositivo dei genitori, che spesso impediscono l’accesso agli operatori.
L’aggravamento del conflitto con le istituzioni
Il rapporto tra famiglia e istituzioni si deteriora progressivamente. Dopo un iniziale atteggiamento di apparente apertura, i genitori rifiutano sistematicamente gli incontri, negano l’ingresso ai servizi sociali e ostacolano ogni verifica sullo stato di salute o sulle condizioni di vita dei minori. Questo atteggiamento, la cui rilevanza giuridica verrà approfondita nelle sezioni successive, rappresenta un indice autonomo di inidoneità genitoriale, in quanto rende impossibile qualunque intervento di protezione.
A ciò si aggiunge un episodio particolarmente significativo: la partecipazione dei minori a una trasmissione televisiva nazionale (“Le Iene”), in cui vengono resi pubblici dettagli della vicenda familiare e giudiziaria. Il Tribunale considera questa scelta come un grave vulnus al diritto alla riservatezza dei minori, compiuto proprio nel momento in cui sarebbe stato richiesto il massimo livello di tutela.
Persistenza delle condizioni pregiudizievoli
Nonostante l’apertura del procedimento, le condizioni abitative restano immutate: l’immobile continua a essere privo di agibilità e servizi essenziali, il riscaldamento è assente, la roulotte rimane uno spazio di vita ordinario. L’opposizione dei genitori impedisce ogni intervento volto a migliorare la situazione.
Il Tribunale ricostruisce così un pregiudizio non episodico, ma strutturale: la salute compromessa dall’assenza di cure, lo sviluppo cognitivo ostacolato dalla mancata scolarizzazione, la socializzazione negata, la sicurezza abitativa inesistente, l’identità dei minori esposta pubblicamente e la vigilanza istituzionale resa impossibile.
Potrebbero interessarti anche:
- Dichiarazione dello stato di adottabilità e recupero genitoriale: il dovere di una valutazione dinamica
- Adozione per stato di abbandono: no all’illusoria riabilitazione genitoriale in assenza di prove concrete
- Illecito endofamiliare: risarcimento per abbandono genitoriale e diritto alla bigenitorialità
L’istruttoria amministrativa e giudiziaria: un quadro documentale coerente
L’istruttoria si fonda principalmente sulle relazioni dei servizi sociali e sui rapporti dei Carabinieri del 23 settembre e del 4 ottobre 2024. Le fonti convergono nel delineare una trascuratezza non occasionale, ma stabile e strutturale. L’abitazione è priva di utenze essenziali, gli ambienti risultano igienicamente inadeguati, mancano arredi e letti appropriati, la roulotte è utilizzata come spazio abitativo stabile e i minori sono privi di un pediatra di riferimento.
I servizi sociali descrivono la famiglia come “isolata e difficilmente raggiungibile”, con scarsi legami nel territorio e uno stile di vita incompatibile con gli standard minimi di cura richiesti per l’età evolutiva. Il Tribunale valorizza questo dato, sottolineando che la ricostruzione dell’ambiente di vita del minore non ha funzione meramente descrittiva, ma assume rilevanza giuridica in quanto integra uno degli indicatori di pregiudizio previsti dall’art. 333 c.c.
Un elemento particolarmente significativo riguarda la mancanza dei certificati edilizi essenziali, tra cui il collaudo statico. Il giudice interpreta tale carenza come una presunzione di pericolosità ex art. 24 T.U. Edilizia, evidenziando come l’inidoneità dell’ambiente non sia valutata solo in termini empirici, ma sulla base di parametri legali oggettivi.
Il rifiuto di collaborazione come indice di inidoneità genitoriale
Uno degli snodi decisivi dell’ordinanza riguarda la condotta dei genitori durante il procedimento e nei rapporti con i servizi sociali. Dopo un’iniziale disponibilità apparente, essi adottano un atteggiamento via via più oppositivo: impediscono l’accesso dei servizi sociali, non rispettano gli appuntamenti fissati, ostacolano gli accertamenti sanitari, contestano le indicazioni degli operatori e rendono di fatto impossibile qualunque verifica istituzionale.
Il Tribunale interpreta questo comportamento non come semplice diffidenza verso l’autorità, ma come rifiuto attivo degli obblighi genitoriali. Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza della Cassazione (vedi, ex multis, Cass. 9691/2022), che considera il rifiuto immotivato di collaborare un indice autonomo di incapacità genitoriale, soprattutto quando impedisce l’adempimento dei doveri di protezione, istruzione e cura previsti dall’art. 316 c.c.
La richiesta di 50.000 euro per consentire una visita pediatrica assume in questo contesto un valore simbolico: segnala un’incomprensione radicale del ruolo genitoriale, trasformando un obbligo di tutela in un pretesto per eludere i doveri di cura.
L’ordinanza ribadisce quindi un principio fondamentale: la genitorialità non è uno spazio di autodeterminazione assoluta, ma una funzione giuridica che impone doveri inderogabili. La mancata collaborazione non è qualificabile come scelta educativa, ma come omissione lesiva dell’interesse del minore.
La deprivazione relazionale come forma autonoma di pregiudizio
Un altro contributo rilevante dell’ordinanza è il riconoscimento della deprivazione relazionale come pregiudizio giuridicamente rilevante. I minori, infatti, risultano completamente isolati dal contesto sociale: non frequentano la scuola, non intrattengono rapporti con coetanei, non partecipano ad attività educative o ricreative e mostrano difficoltà nel linguaggio e nell’espressione.
Il Tribunale interpreta tali elementi alla luce delle teorie psicologiche più accreditate (Vygotskij, Piaget, Bandura, Erikson), sottolineando che la relazione con i pari è fondamentale per lo sviluppo sociale, emotivo e identitario del bambino. Da ciò deriva che il pregiudizio non deve essere inteso solo come danno materiale, ma come compromissione del percorso evolutivo del minore.
La mancanza di interazioni rappresenta dunque non un elemento accessorio, ma un indice primario di rischio evolutivo, poiché impedisce al minore di costruire una rete sociale, sviluppare competenze comunicative e acquisire gli strumenti necessari per l’inserimento nella comunità.
La mancata scolarizzazione come espressione di pregiudizio multidimensionale
La mancata scolarizzazione costituisce un ulteriore profilo di rilievo nella valutazione del pregiudizio. Il Tribunale osserva che i genitori non hanno mai iscritto i minori a scuola né predisposto un percorso di istruzione parentale conforme ai requisiti di legge. Non vi è traccia di comunicazioni ai dirigenti scolastici, di un progetto didattico, di verifiche annuali o di esami di idoneità.
Sotto il profilo normativo, l’obbligo scolastico trova fondamento nell’art. 30 Cost. e negli artt. 147 e 316 c.c., oltre alla normativa speciale sulla scuola. Il Tribunale sottolinea che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un presidio di integrazione sociale e un contesto primario di socializzazione. La sottrazione dei minori a tale ambiente determina un pregiudizio che si intreccia con quello relazionale e cognitivo.
Anche il tentativo dei genitori di esibire un certificato di idoneità alla classe terza non regge al vaglio del giudice: esso risulta irrituale e non trasmesso all’autorità scolastica competente, vanificando la funzione di controllo che la legge attribuisce al dirigente scolastico. La mancanza di istruzione produce così un effetto cumulativo: limita lo sviluppo cognitivo, ostacola la socializzazione e rafforza l’isolamento familiare.
Il Tribunale afferma che il pregiudizio non riguarda solo il diritto allo studio, ma il più ampio diritto alla vita di relazione ex art. 2 Cost., riconoscendo alla scuola una funzione sociale essenziale.
La valutazione integrata del pregiudizio: un approccio sistemico
Dal punto di vista metodologico, l’ordinanza adotta una lettura unitaria del pregiudizio. Il Tribunale non valuta isolatamente la condizione abitativa, sanitaria, educativa o relazionale, ma le considera come elementi interdipendenti che definiscono un modello familiare complessivamente inidoneo.
Questo approccio rispecchia il concetto di “danno evolutivo integrato”, secondo cui una pluralità di condotte inadeguate, anche non gravissime singolarmente, può determinare un pregiudizio globale più intenso della somma delle sue parti. Il giudice valorizza dunque la concomitanza di:
-
una condizione abitativa insicura e priva di requisiti di legge;
-
l’assenza di assistenza sanitaria;
-
la mancata scolarizzazione;
-
l’isolamento relazionale;
-
l’esposizione mediatica indebita;
-
il rifiuto sistematico dei servizi sociali.
L’ordinanza si pone in continuità con la giurisprudenza della Cassazione (ad es. Cass. 9691/2022) e con le pronunce della Corte EDU (vedi, ex multis, Strand Lobben c. Norvegia,2019), secondo cui l’idoneità genitoriale deve essere valutata sulla base della situazione reale del minore, e non di modelli astratti.
Il Tribunale giunge così alla conclusione che la situazione dei minori sia caratterizzata da un pregiudizio grave, attuale e non rimovibile con misure di sostegno leggero, giustificando il ricorso alla sospensione della responsabilità genitoriale.
Il quadro normativo: artt. 330 e 333 c.c. e criteri di applicazione
Per comprendere la scelta del Tribunale è necessario richiamare la struttura delle misure limitative e ablative della responsabilità genitoriale previste dal codice civile. Gli artt. 330 e 333 c.c. delineano due livelli di intervento, fondati su presupposti differenti e con effetti distinti.
L’art. 333 c.c. disciplina i casi in cui la condotta dei genitori arreca “pregiudizio al figlio”, autorizzando l’intervento del giudice minorile per imporre i provvedimenti opportuni, tra cui l’allontanamento temporaneo del minore dall’ambiente familiare. Si tratta di misure di carattere conservativo e proporzionale, finalizzate a rimuovere situazioni pregiudizievoli non necessariamente irreversibili.
L’art. 330 c.c., invece, consente la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi più gravi, ossia quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti oppure abusa dei relativi poteri, con pregiudizio grave e non solo potenziale per il figlio. La misura ha carattere definitivo, salvo recupero, ed è riservata alle situazioni di radicale incapacità educativa o di pericolosità attuale.
Il Tribunale dell’Aquila colloca la vicenda nel perimetro dell’art. 333 c.c., ritenendo sussistente un pregiudizio grave, attuale e strutturale, ma non tale da integrare un abuso o un’inidoneità irreversibile ai sensi dell’art. 330 c.c. La distinzione, come vedremo, è centrale per comprendere il significato della sospensione temporanea.
Perché la sospensione e non la decadenza: il ragionamento del Tribunale
La decisione di applicare la sospensione, e non la decadenza, della responsabilità genitoriale si articola su più livelli.
Proporzionalità e gradualità
Il Tribunale si rifà al principio di proporzionalità, oggi cardine del diritto minorile anche grazie al recepimento delle indicazioni CEDU. Il giudice ritiene che il pregiudizio derivi da un insieme di condotte e omissioni molto gravi, ma teoricamente reversibili se affrontate con un percorso di recupero. La struttura familiare appare altamente disfunzionale, ma non irrimediabilmente compromessa in modo tale da giustificare la definitiva sottrazione della responsabilità.
Gravità del pregiudizio ma non irreversibilità
Il quadro emerso, precarietà abitativa, isolamento, mancata scolarizzazione, assenza di cure, rifiuto dei servizi, esposizione mediatica, configura un pregiudizio intenso e multidimensionale. Tuttavia, il Tribunale non accerta comportamenti che evidenzino un abuso in senso tecnico, come violenze, maltrattamenti fisici, sfruttamento o altre forme di lesione irreparabile del rapporto genitore–figlio.
Siamo, dunque, nell’area dell’inidoneità evolutiva, non dell’abuso irreversibile.
Necessità di proteggere i minori senza recidere il legame familiare
Il giudice valorizza anche il principio di mantenimento del legame familiare, richiamato costantemente dalla giurisprudenza CEDU (Strand Lobben c. Norvegia, Kutzner c. Germania) e dalla Cassazione.
L’allontanamento è ritenuto indispensabile, ma non definitivo: è misura necessaria per proteggere i minori nella fase attuale, ma aperta alla possibilità di recupero della capacità genitoriale se i genitori saranno in grado di modificare il loro comportamento.
Idoneità dello strumento ex art. 333 c.c. rispetto al caso concreto
La sospensione consente interventi flessibili, modulati sulle esigenze evolutive dei minori e monitorati dai servizi sociali. La decadenza, invece, avrebbe comportato la definitiva privazione della responsabilità genitoriale, misura sproporzionata rispetto a un quadro sì gravissimo, ma ritenuto potenzialmente recuperabile attraverso un percorso educativo e terapeutico.
Gli effetti della decisione: misure adottate e ruolo dei servizi sociali
L’ordinanza dispone:
-
la sospensione della responsabilità genitoriale;
-
la nomina di un tutore provvisorio dei minori;
-
l’allontanamento dei minori dalla dimora familiare e il loro
collocamento in casa-famiglia; -
l’incarico al Servizio Sociale affidatario di dirigere l’esecuzione dell’ordine
di allontanamento dei minori, di assicurare loro adeguato sostegno psicologico e
di disciplinare la frequentazione tra genitori e figli, tenuto conto di quanto indicato
in motivazione; -
la definizione delle modalità esecutive dell’ordine di allontanamento con l’assistenza della forza pubblica.
Il Tribunale sottolinea che tali misure non hanno finalità punitive, ma protettive: mirano a garantire ai minori un ambiente di vita sicuro, stimolante ed evolutivamente adeguato. Contestualmente, la temporaneità della sospensione apre alla possibilità di un graduale recupero del ruolo genitoriale, qualora la famiglia intraprenda un percorso di cambiamento.
Conclusioni
La vicenda della “Famiglia nel bosco” rappresenta un caso emblematico di come il concetto di pregiudizio nel diritto minorile si sia ampliato e articolato oltre la dimensione materiale o sanitaria, includendo profili educativi, relazionali e identitari che incidono in modo determinante sullo sviluppo del minore.
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila applica in maniera rigorosa e coerente i principi di proporzionalità, gradualità e tutela evolutiva, affrontando una situazione complessa attraverso una lettura integrata dei diversi fattori di rischio. La scelta della sospensione, e non della decadenza, rispecchia una valutazione equilibrata tra la necessità di protezione immediata dei minori e l’obiettivo di preservare, ove possibile, il legame genitoriale.
L’ordinanza conferma l’importanza di considerare il pregiudizio come concetto sistemico, capace di includere deprivazioni materiali, relazionali, educative e affettive, e mostra come il giudice minorile, nella cornice del nuovo rito familiare, sia chiamato a un accertamento puntuale e multidisciplinare, orientato alla tutela effettiva dei diritti fondamentali dei minori.