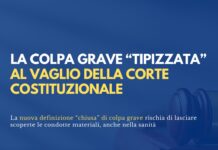L’esposizione all’amianto rappresenta da decenni uno dei temi più controversi e delicati del contenzioso lavoristico. In particolare, le patologie asbesto-correlate pongono problemi complessi di causalità giuridica, accertamento tecnico e riparto delle responsabilità. Una recente ordinanza della Cassazione offre l’occasione per un approfondimento sistematico sul tema. Per un approfondimento sull’argomento, ti segnaliamo il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.
Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Leggi descrizione
Giuseppe Cassano, 2024, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €

Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.
Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Il dictum della Suprema Corte
Con l’ordinanza n. 27572 del 24 ottobre 2024 (Sez. Lav., Pres. Manna, Rel. Michelini), la Suprema Corte torna ad affrontare il tema delle morti da amianto, fissando, in punto di diritto, l’importante principio per cui l’accertato ingente abuso tabagico da parte del lavoratore (nella specie, poi deceduto) incide sul quantum del risarcimento trovando immediata e diretta applicazione la norma dell’art. 1227, comma 1, c.c..
La Corte muove dall’affermazione per cui nelle ipotesi di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, l’espressione “fatto colposo” – cui ricorre il Legislatore nella menzionata norma codicistica – non è riferita all’elemento psicologico della colpa, dovendo essere intesa, propriamente, come sinonimo di un “comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza”.
E, in questa accezione di “fatto colposo”, deve farsi rientrare a pieno titolo il “fumo attivo” che, secondo la Corte, costituisce “un atto di volizione libero, consapevole e autonomo” di un soggetto dotato di capacità di agire; di conseguenza il risarcimento del danno va proporzionalmente ridotto in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del comportamento della vittima.
Per addivenire alla cennata conclusione la Corte sottolinea come la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sia regolata – quanto al rapporto causale tra evento e danno – dall’art. 41 c.p., per cui trova applicazione il principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico venga interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente, da solo, a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Resta inteso, poi, che nelle ipotesi di malattie ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie.
Ferma restando la necessità di acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio – sottolinea ancora la Corte – i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
La responsabilità datoriale
Il provvedimento in commento, come anticipato, si innesta sul tema dell’inalazione delle fibre di amianto sul luogo di lavoro e delle conseguenti morti, dopo lunghi periodi di malattia e sofferenza, dei lavoratori con conseguente sconvolgimento della quotidianità dei familiari.
Tema, questo, che registra diversi interventi, per lo più riconducibili alla giurisprudenza di merito, in cui – passando attraverso un’inaccettabile oggettivizzazione della responsabilità ex art. 2087 c.c. – si è ricondotta alla responsabilità del datore, di fatto, ogni morte per “amianto”, a volte anche se intervenuta decine di anni dopo il pensionamento del lavoratore.
La questione della relazione tra amianto e malattia dei lavoratori, a ben vedere, non può prescindere dall’accertamento del dato storico e fattuale – cioè del contatto del lavoratore con fibre di amianto aerodisperse – contatto che deve essere qualificato, all’esito del giudizio, in termini di efficienza causale, altrimenti si avrebbe l’inaccettabile conseguenza che anche una presenza insignificante di nanoparticelle in un ambiente farebbe scattare la presunzione per quanto riguarda il nesso causale (App. Firenze, Sez. Lav., 31 ottobre 2023, n. 567).
Nei giudizi di questo tipo il Giudice di merito si affida, doverosamente, al sapere scientifico dei consulti di ufficio (cui sono chieste indagini in ordine alla nocività dell’ambiente lavorativo e di tipo medico-legale) per cui il sapere scientifico gioca un ruolo fondamentale nel giudizio.
In via di estrema sintesi i quesiti posti dal Giudice al CTU sono sovente formulati nei termini di accertare se, a livello probabilistico o di certezza, una determinata patologia possa essere ricondotta all’inalazione di fibre di amianto.
E spesso i consulenti, all’esito del loro lavoro, esprimono un giudizio dubitativo nel senso della non emersione di alcun dato clinico utile per risolvere in termini di “probabilità”, o “certezza”, il dilemma se la patologia sia riferibile all’esposizione all’amianto o, piuttosto, ad altro fattore (tra cui – per tornare all’argomentare della Cassazione nell’ordinanza qui in esame – il tabagismo).
Orbene, per escludere la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. è sufficiente dimostrare, nel caso concreto, che l’esposizione all’amianto non ha avuto efficienza causale rispetto alla malattia. Tale esclusione non richiede l’individuazione degli altri fattori che ne siano stati origine. Va tuttavia rilevato che, sul piano scientifico, è spesso difficile attribuire con certezza esclusiva l’insorgenza del tumore – in particolare del carcinoma polmonare – a una singola causa, sebbene sia noto che il fumo e la familiarità incidano significativamente, pur non essendo fattori esclusivi.
Da tanto consegue che, in presenza di una accertata esposizione all’amianto (sempre che la stessa abbia avuto rilievo di concausa) e in presenza di altre concause parimenti dannose, opera l’art. 1227 c.c. afferente il concorso di colpa del danneggiato che viene ad incidere, in termini di percentuale di responsabilità, sul concreto ammontare del quantum risarcitorio concretamente dovuto dal (co)responsabile.
A questo punto del nostro argomentare si rende opportuno, quanto doveroso, soffermarsi su tre temi di indagine che attengono, in via di estrema sintesi, al rapporto tra Giudice e sapere scientifico, all’onere della prova e, infine, alla individuazione, in termini di certezza, del soggetto responsabile.
Iudex peritus peritorum. E l’onere della prova?
È ampiamente condivisa l’affermazione per cui è consentito al Giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio sia quando le motivazioni siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche: in entrambi i casi, l’unico onere per il Giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio non vincolano il Giudice, che può disattenderle solo con una motivazione critica, coerente con le risultanze processuali. Deve però indicare chiaramente gli elementi probatori, i criteri logico-giuridici o le conoscenze tecniche che giustificano la decisione difforme, dimostrando di aver risolto autonomamente le questioni tecniche rilevanti.
Nei rapporti tra la decisione del Giudice e le determinazioni derivanti dalla perizia d’ufficio, valga quindi il principio di diritto per cui il Giudice ha piena libertà dì apprezzamento delle risultanze della perizia ma, al contempo, tale libertà è temperata dall’obbligo di motivazione.
Quando si è in presenza, poi, di tesi scientifiche contrapposte, l’adesione alle conclusioni del perito d’ufficio può ritenersi adeguatamente motivata ove il Giudice ne indichi l’attendibilità, mostrando di non aver ignorato le conclusioni dei consulenti tecnici di parte.
La Cassazione, da parte sua, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del Giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile, verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto, di modo che il Giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Ed allora, avuto riguardo alle vicende di danno da amianto in cui, come anticipato, il sapere scientifico gioca un ruolo principale (anche in considerazione delle diverse tesi che si contrappongono) occorre chiedersi quale decisione potrà correttamente assumere il Giudice quando all’esito della disposta CTU rimanga incerta l’origine di una malattia professionale.
La risposta al quesito va ricercata all’interno del sistema che regola l’onere della prova nel processo civile (anche innanzi al Giudice del Lavoro) e cioè a dire alla luce dell’art. 2697 c.c. per cui la domanda deve essere rigettata quando il ricorrente non abbia assolto all’onere della prova su esso incombente.
La decisione di condanna, nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, passa necessariamente attraverso l’accertamento che la condotta serbata dal datore di lavoro sia stata quella che, più probabilmente di altre, si pone alla base del danno avendolo cagionato.
D’altronde non vi è spazio nel sistema della responsabilità civile per una condanna in assenza di una causalità provata in giudizio.
Ma, sul punto, diverse sono le pronunce con cui i Giudici disattendendo il cennato principio, che si pone quale cardine di sistema, addivengono a condanne al risarcimento danni alla luce della violazione delle disposizioni cautelari e generali del D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 303/1956 senza domandarsi se l’adozione delle stesse – in riferimento al tema della salubrità dell’ambiente di lavoro e al contrasto alla dispersione in aria delle fibre di amianto – avrebbe o meno evitato le conseguenze di danno per il lavoratore.
A tal proposito si segnala la pronuncia resa dal Tribunale di Napoli, Sez. Lav., 22 novembre 2023, n. 7031 che fa riferimento all’art. 21 del citato D.P.R. n. 303 (che si limita a dettare “Norme generali per l’igiene del lavoro”) per fondare la sua condanna risarcitoria per morte da amianto.
In tale ultima disposizione si è (era) stabilito che, nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualsiasi specie, il datore di lavoro deve adottare quei provvedimenti atti a impedirne o ridurne, “per quanto è possibile”, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente.
Da tale norma, unitamente ad altre di cui al medesimo testo normativo, ha fatto discendere la conclusione per cui, nel caso concreto, sussisteva una ipotesi di inadempimento del disposto di cui all’art. 2087 c.c. in forza del quale – si legge nella sentenza del Giudice partenopeo – “all’imprenditore si impone di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il ragionamento operato dal Giudice non è condivisibile laddove si consideri che l’art. 21 cit. non è stato dettato in riferimento alle polveri di amianto, bensì per tutte le polveri moleste diffuse nell’ambiente in quantitativi considerevoli.
Né la stessa norma si appalesa immediatamente riferibile alla polluzione di piccolissime fibre come quelle dell’asbesto, non percepibili con l’inalazione.
Il tutto fermo restando che il comportamento cautelare allora richiesto dal Legislatore non era quello di eliminare l’aerodispersione, bensì quello di contenerla entro definiti limiti quantitativi.
In definitiva, l’art. 21 non conteneva una regola cautelare da far valere quale statuto degli obblighi datoriali in materia di aerodispersione di particelle di amianto, rappresentando piuttosto un mero principio generale che imponeva al datore di lavoro la ricerca e l’adeguamento tecnico nel contenimento delle polveri nei luoghi di lavoro.
Emerge così, con evidenza, la genericità della fonte dell’obbligo (art. 21 cit.), “pensata”, ormai quasi 70 anni fa, in relazione al problema di ridurre la presenza di polveri fisicamente avvertibili e oggettivamente moleste sia quantitativamente che qualitativamente; sicchè – lo si ripete – essa non può essere applicata all’aerodispersione di fibre di amianto.
La disposizione dell’art. 21 ha poi un contenuto precettivo modale non puntualmente individuato: essa necessita della etero-integrazione operata attraverso le conoscenze scientifiche disponibili al tempo in cui deve (doveva) farsene applicazione.
Questo è il senso del richiamo ai provvedimenti atti a impedire, o ridurre, “per quanto possibile” lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro.
Che una disposizione come l’art. 21 cit. non si possa validamente invocare per una “polvere” tanto micidiale e mortale quale l’amianto, la cui inalazione anche di poche fibre è idonea a innescare un processo cancerogenico, si evince anche dal fatto che, progressivamente, lo stesso Legislatore è giunto ad imporre la soglia della “tolleranza zero”.
Non è quindi possibile invocare quale fonte precauzionale l’osservanza di una disposizione che, pure nella sua più ampia interpretazione e applicazione, si riferisce ad una situazione di tutt’altra natura rispetto a quella oggetto della aerodispersione di fibre di amianto, e la cui scrupolosa applicazione non avrebbe in alcun modo sortito l’effetto desiderato (al di là della inattuabilità nel caso concreto).
Basti a tal proposito osservare che tutte le operazioni di bonifica dei siti inquinati dall’amianto vengono oggi eseguite da soggetti isolati dall’esterno con dotazioni -tute e maschere respiratorie- degne di quelle viste indosso ai medici a contatto con pazienti “covid-19”, o in situazioni ancora peggiori.
La questione della responsabilità solidale
Ma non è tutto. Anche la disciplina della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. è declinata in termini del tutto anomali rispetto ai principi generali quando si parla di danni da amianto.
Sul punto occorre muovere dal presupposto per cui il primo comma di tale norma, come noto, stabilisce che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, ciascuna è obbligata in solido al risarcimento del danno.
Pertanto, il presupposto della solidarietà risarcitoria è che il danno sia unico e che esso sia eziologicamente ricollegabile a più persone, avuto riguardo indifferentemente a condotte commissive o omissive, dolose o colpose (ovvero imputabili per responsabilità oggettiva), o ancora al diverso titolo (contrattuale o extracontrattuale) cui ciascuno dei responsabili è tenuto.
Si è invece al di fuori dell’area della solidarietà allorché le più condotte (commissive od omissive) abbiano cagionato danni autonomamente identificabili.
Non occorre, poi, che le diverse condotte si inquadrino in un piano unitario, non essendo previsto che il danno scaturisca da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti; conseguentemente, essi sono tenuto in solido, concorrendone i presupposti, anche se abbiano agito – o siano loro riferibili le condizioni fondanti le rispettive responsabilità – autonomamente o ignorando l’azione altrui.
Orbene, l’operatività della teoria scientifica “trigger dose”, per cui ai fini della contrazione del mesotelioma pleurico rileva la sola esposizione iniziale all’asbesto (attribuendosi l’insorgenza della malattia ad una dose killer, risultando irrilevanti sul piano eziologico le ulteriori fibre eventualmente inalate), impone l’indispensabilità dell’accertamento del momento in cui si verifica tale esposizione iniziale.
Questa può avvenire, almeno in via generale, in tre momenti della vita di una persona: prima dell’inizio dell’attività lavorativa; durante l’attività lavorativa (con la necessità di individuare presso quale datore di lavoro nel caso in cui se ne siano succeduti diversi); durante la pensione.
L’accertamento del momento dell’inalazione della dose killer si accompagna all’individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia nei confronti di chi si ammali (e quindi se accade in età lavorativa tale soggetto – al netto dell’accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c. – sarà il datore di lavoro) e impedisce, mettendola fuori gioco, la fattispecie ex art. 2055 c.c. giacché il fatto dannoso è ascrivibile a un solo soggetto.
Successione di datori e individuazione del soggetto responsabile
A riprova di un’applicazione non corretta dell’art. 2055 c.c. nei casi di danno da amianto si veda Trib. Roma, Sez. III Lav., 10 settembre 2024, n. 8708.
Sin dalla sua primissima lettura la dottrina non ha mancato di sollevare più di un dubbio proprio con riferimento alla solidarietà passiva e, ancora, quanto all’operatività del litisconsorzio nel processo civile.
Il Giudice capitolino, nella vicenda sottoposta al suo esame, per addivenire alla pronunciata sentenza di condanna avrebbe dovuto individuare e vagliare singolarmente le condotte tenute da tutti i soggetti che si assumevano coinvolti nella causazione dei danni lamentati dal lavoratore (rectius, dagli eredi-ricorrenti) e cioè adire di tutti i datori di lavoro nel tempo succedutisi.
La responsabilità solidale per l’intero danno stabilita dal primo comma dell’art. 2055 c.c. obbliga il Giudice, quando sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all’accertamento e all’attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all’ultimo comma dello stessa norma, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale.
Il che si traduce necessariamente, sul piano processuale, nella necessità di un giudizio fondato su un contraddittorio esteso a tutti i possibili danneggianti (e cioè, si ripete, a tutti i possibili datori lavoro susseguitisi nella vita lavorativa del dipendente poi ammalatosi)
Nel caso in cui risulti impossibile (come nella vicenda all’esame del Giudice del lavoro di Roma) l’individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, che rende causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è necessaria l’integrale, o quasi integrale, sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività lavorativa della vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro convenuto in giudizio.
Quando dunque non sia processualmente possibile individuare il failure time la soluzione univoca può raggiungersi solo nel caso dell’unicità del garante (ipotesi nella quale non si pone neppure la necessità di ricercare, e di collocare temporalmente, il momento in cui le successive esposizioni all’amianto perdono rilevanza patogenetica).
Questo argomentare – proprio della giurisprudenza penale – è un faro che orienta l’interprete e, ancora prima il Giudice civile in sede di assegnazione del risarcimento danni.
Quando, al contrario, sia pacifico e incontestabile il succedersi di una pluralità di garanti (datori di lavoro) in costanza di esposizione all’amianto della vittima, la possibilità di argomentare su basi scientifiche l’affermazione individuale di responsabilità è prioritariamente, e necessariamente, legata alla soluzione del problema di fondo, costituito dalla possibilità, o meno, di individuare, anche sul piano temporale, il discrimen tra la fase di induzione e quella di progressione (latenza clinica), in modo da accertare (e da argomentare) la sovrapponibilità almeno parziale fra la posizione di garanzia concretamente assunta dal soggetto convenuto con richiesta di danni e il protrarsi di un’esposizione all’amianto causalmente rilevante nel progredire delle patologie contratte dal lavoratore danneggiato.
S’intende che tale problema di fondo può trovare adeguata soluzione, nell’ambito della singola vicenda processuale, selezionando e quindi individuando la legge scientifica di copertura ritenuta idonea, facendo buon governo, in sede applicativa, dei principi che la sorreggono e dando veste argomentativa alla soluzione così raggiunta, alla luce delle emergenze fattuali ricavabili dall’istruttoria e caratterizzanti il caso concreto, nell’ambito delle quali collocare i suddetti principi.
In questo contesto il tema di indagine, per la formazione della prova e l’accertamento delle responsabilità, deve necessariamente essere filtrato attraverso la norma processuale dell’art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario) quando i datori di lavoro siano più di uno.
Intervenuta sulla corretta esegesi di tale disposizione codicistica più volte la Suprema Corte ha sottolineato che il litisconsorzio e, correlativamente, l’ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l’eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti. Con la conseguenza che questi ultimi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla loro posizione giuridica e ciò anche nell’interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune.