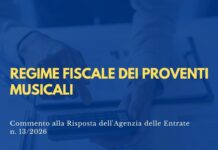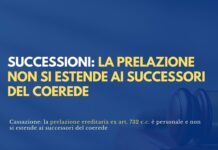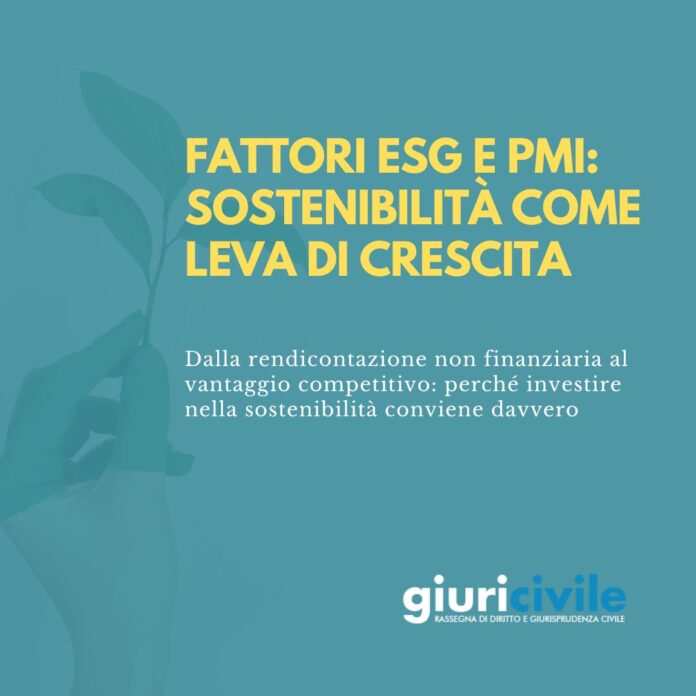
Negli ultimi decenni, il concetto di sostenibilità ha acquisito una rilevanza crescente, trasformandosi da semplice opzione ad imperativo inderogabile per il posizionamento strategico delle imprese.
Il presente elaborato esaminerà l’impatto dei fattori ESG (Environmental – Social – Governance) sulle piccole e medie imprese (Pmi), esplicitando in che modo far penetrare gradatamente tali principi all’interno dei processi di gestione aziendale.
L’obiettivo principale è dimostrare che l’implementazione di bilanci di sostenibilità nel proprio business non rappresenta un mero onere, assurgendo, di contro, a rilevante opportunità da cui trarre vantaggio (anche economico).
È dimostrato, infatti, che l’integrazione dei fattori ESG nella strategia aziendale sia essenziale per migliorare la reputazione dell’organizzazione, attirare investitori, occupare porzioni competitive di mercato, ed accedere nuove opportunità di finanziamento.
Per far ciò, sarà nevralgico intervenire sull’efficienza dei fattori produttivi, assicurando la realizzazione di maggior output utilizzando la stessa, o minore, quantità di input che, a loro volta, riducano o migliorino l’impatto ambientale.
Il concetto di sviluppo sostenibile
Nella consapevolezza che l’obiettivo della sostenibilità non si sostanzia nella mera soddisfazione dei bisogni del presente, imponendo, invece, una visione dell’economia solidaristica capace di non scalfire i presupposti di sviluppo delle generazioni future, i nuovi sistemi di gestione aziendale virano tutti verso la concretizzazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile attraverso: la predisposizione di nuovi standard su cui valutare la performance economica dell’azienda (Profit), la misurazione dell’impatto aziendale sugli individui e quindi sulla società (People) ed infine, la creazione di processi produttivi capaci di ridurre il deterioramento ambientale (Planet).
Ne deriva che i tre elementi su cui si erge il concetto di business sostenibile, sono:
- valore economico > La sostenibilità deve essere prima di tutto finanziaria ed economica. La finalità dell’azienda continua ad essere la creazione di modelli di gestione che generano profitti, mantengono alti livelli di competitività e si plasmano quotidianamente per posizionare strategicamente l’impresa all’interno del mercato globale.
- valore sociale > Questo parametro misura e rendiconta l’impatto delle attività aziendali sul benessere delle persone e della comunità di riferimento, includendo iniziative a garanzia delle pari opportunità e/o a tutela dei diritti fondamentali.
- valore ambientale > Questo indice introduce analisi metriche qualitative/quantitative aventi ad oggetto: il consumo di energia, il livello di emissioni, la gestione dei rifiuti, l’uso delle risorse primarie e le azioni a tutela dell’ambiente. Si rivolge, dunque, alle pratiche adottate dall’azienda per gestire gli impatti ambientali delle e/o sulle sue attività.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo la pubblicazione del “Codice della normativa ESG”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli.
I canoni ESG
Per lungo tempo le aziende hanno avuto totale arbitrio nella realizzazione di iniziative volte all’ impegno sociale, ambientale e nell’adottare buone pratiche di governance. Di conseguenza, non solo la realizzazione ma anche la relativa comunicazione dei risultati raggiunti si basavano su scelte volontaristiche, le quali inibivano la comparazione tra le imprese e scoraggiavano l’esecuzione di valutazioni sorrette da parametri oggettivi.
Così, per sopperire a questa carenza e, contemporaneamente, innestare nelle aziende processi di verificazione concreti, nel 2005 sono stati introdotti i cd. fattori ESG; ossia, una serie di criteri di misurazione afferenti all’incidenza dell’attività di impresa nel contesto ambientale e sociale in cui la stessa opera.
Le tre lettere dell’acronimo ESG, infatti, fanno riferimento a tutti gli aspetti che le aziende devono prendere in considerazione per poter allineare la loro politica economica ai canoni di sostenibilità, i quali, a loro volta, si declinano nella sensibilità rivolta alle questioni ambientali, alla responsabilità sociale ed alla gestione etica delle risorse produttive.
In particolare, il criterio “E – Environment” riguarda l’impatto ambientale generato dall’attività d’impresa (o da essa subito) a causa dei cambiamenti climatici. Include diverse tematiche come l’attenzione al cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti, l’uso sostenibile delle risorse, la sicurezza alimentare e la riduzione delle emissioni di carbonio, oltre agli sforzi mirati alla conservazione della biodiversità.
Il criterio “S – Social”, invece, interessa l’impatto sociale dell’attività d’impresa rispetto a tutti coloro che, a vario titolo, si configurano portatori d’interessi nei confronti dell’azienda. Nello specifico, si tratta di questioni sociali inerenti al rispetto dei diritti umani, la diversità e l’inclusione, ponendo particolare attenzione alle condizioni di lavoro, alla parità di genere ed al rifiuto d’ogni forma di discriminazione.
Infine, il criterio “G – Governance” rappresenta il fattore che promuove la transizione verso il nuovo modello di business sostenibile, incentivando la realizzazione di strategie conformi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo circolare. Esso include aspetti nodali quali l’etica aziendale, il rispetto della meritocrazia, la trasparenza decisionale, la prevenzione dei rischi, l’indipendenza gestionale del Consiglio di amministrazione.
Rendicontazione non finanziaria: contesto normativo
Quando si parla di sostenibilità occorre far riferimento alla Direttiva UE/95/2014, successivamente recepita in Italia dal D.lgs. n. 254/2016, la quale imponeva l’obbligo di redazione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), inizialmente, solo in capo ai soggetti di interesse pubblico, ossia banche, assicurazioni, società quotate e tutti gli enti indicati all’art. 16 del D. lgs. n. 39/2010.
Successivamente, il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la quale regolamenta la comunicazione societaria sulla sostenibilità.
Nel dettaglio, la nuova direttiva ha introdotto importanti novità, tra cui si segnalano:
- l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati alla pubblicazione della reportistica di sostenibilità;
- l’introduzione di Standard europei per il reporting di sostenibilità;
- la creazione di limitazioni al fenomeno del greenwashing.
È previsto, inoltre, un percorso di adeguamento a tappe, secondo cui:
- Dal 1° gennaio 2024 le imprese già soggette all’obbligo di redazione della DNF dovranno adeguarsi ai nuovi standard europei dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) con termine di pubblicazione dati previsto nel 2025;
- Dal 1° gennaio 2025 le imprese con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di fatturato e/0 20 milioni di attivo, non soggette alla Direttiva DNF, saranno chiamate a redigere il report di sostenibilità con termine di pubblicazione dati previsto nel 2026;
- Infine, dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di redazione del report di sostenibilità verrà esteso alle PMI quotate con termine di pubblicazione dati previsto nel 2027.
La nuova Direttiva vincola alla redazione della Supply Chain Management. Le aziende, infatti, saranno chiamate ad inserire nel loro report i dati relativi a tutti gli operatori (persone fisiche e giuridiche) che compongono la filiera produttiva, realizzando così un coinvolgimento (anche indiretto) di tutto l’indotto nell’adozione delle politiche sostenibili.
Report di sostenibilità
Il D.lgs. n. 254/2016, attualmente in vigore, richiama cinque ambiti di rendicontazione per la DNF:
Lotta alla corruzione
Cosa include: le politiche e le procedure adottate dall’azienda per prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi in seno ad essa e nelle interazioni esterne.
Obiettivo: promuovere un ambiente aziendale etico e trasparente.
Diritti Umani
Cosa include: il rispetto dei diritti umani all’interno dell’azienda e nella catena di fornitura, attraverso l’attuazione di politiche di due diligence, non discriminazione ed integrità.
Obiettivo: prevenire e mitigare le violazioni dei diritti umani e garantire che le operazioni aziendali siano in simmetria con gli standard internazionali.
Governance
Cosa include: la realizzazione di una struttura aziendale etica, trasparente in armonia con i dettami normativi nazionali ed internazionali.
Obiettivo: garantire una gestione etica dell’azienda attraverso l’applicazione di principi morali a tutti i livelli della compagine aziendale, integrando i principi di sostenibilità nelle decisioni strategiche.
Ambito sociale
Cosa include: politiche del personale, tutela della diversità ed inclusione, diritti umani, benessere dei lavoratori, sguardo sulla comunità di riferimento in cui operano l’azienda.
Obiettivo: assicurare condizioni di lavoro etiche, eque e sicure, contribuendo ove possibile al miglioramento dello stato di benessere della realtà sociale radicata nel territorio in cui opera l’azienda.
Ambito ambientale
Cosa include: gestione delle risorse produttive, contenimento dei livelli di inquinamento, smaltimento circolare dei rifiuti.
Obiettivo: monitorare l’impatto dell’attività aziendale sull’ecosistema, definendo nuove strategie per preservarne la salubrità.
Stabiliti gli obiettivi, fanno seguito le cinque fasi di reporting:
- Definizione dell’impegno verso la sostenibilità
- Analisi di materialità
- Definizione dei KPI (Key Performance Indicators)
- Raccolta dei dati
- Definizione degli obiettivi e piano di miglioramento.
Sulla scorta di quanto esposto, infine, occorre analizzare i vantaggi conseguenti alla redazione del report di sostenibilità.
Invero, la scelta di adottare questo strumento genera benefici che si diramano verso l’intero, ad esempio attraverso una migliore organizzazione dei processi gestionali; e verso l’esterno, in termini di maggiore visibilità ed affidabilità nei confronti degli stakeholders.
In particolare, i vantaggi possono identificarsi in:
- Migliore impatto ambientale e sociale
- Attrazione di nuovi modelli di business sostenibili
- Riduzione dei costi operativi
- Adozione di processi operativi innovativi
- Gestione dei rischi più efficiente
- Aumento della fidelizzazione e della motivazione dei dipendenti
- Aumento della reputazione aziendale
Conclusioni
In conclusione, è fondamentale per le realtà imprenditoriali esplorare ed adottare pratiche gestionali sostenibili. L’integrazione dei fattori ESG e la successiva redazione del bilancio di sostenibilità, infatti, non rappresentano solo una risposta concreta per osteggiare il depauperamento ambientale globale, costituendo leve cruciali per garantire competitività e posizionamento strategico dell’azienda all’interno delle dinamiche di mercato.
Formazione in materia: Criteri ESG e Corporate Governance
Il corso online in diretta “Criteri ESG e Corporate Governance” (Maggioli Editore), si concentra sull’integrazione dei principi ESG (Environment, Social, Governance) nel contesto della sostenibilità aziendale, con particolare attenzione alla Governance.
Il programma, strutturato in quattro sessioni, approfondisce:
- i fondamenti della sostenibilità e i requisiti normativi, tra cui la finanza d’impatto e la direttiva CSRD;
- il ruolo cruciale della governance aziendale, dalle procedure organizzative alla gestione del rischio;
- la protezione dei dati personali e i criteri di reporting legati alla privacy;
- i rischi legati al greenwashing e le implicazioni della direttiva 825/2024. <<<clicca qui per iscriverti>>>