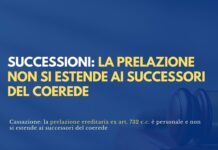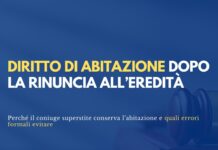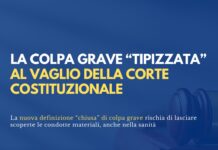La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24006 del 27 agosto 2025 (che puoi leggere cliccando qui), chiarisce che la costituzione in giudizio degli eredi del de cuius costituisce un’accettazione legale dell’eredità. La Corte, così, conferma il principio di diritto secondo il quale la costituzione in giudizio degli eredi, allo scopo di paralizzare una pretesa creditoria esperita verso il loro dante causa, assume l’efficacia, ai sensi dell’art. 476, c.c., di un’accettazione tacita dell’eredità.
Consiglio: il “Manuale pratico per la successione testamentaria e le donazioni”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria.

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Leggi descrizione
Riccardo Mazzon, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
L’accettazione dell’eredità
Com’è noto, l’accettazione dell’eredità può essere espressa, formalizzata mediante una dichiarazione di accettazione resa in un atto pubblico oppure una scrittura privata ai sensi dell’art. 475 c.c.
Mentre l’accettazione tramite il beneficio d’inventario si rende obbligatoria per le persone giuridiche – escluse le società – le fondazioni, le associazioni ed enti non riconosciuti ex art. 473 c.c. ovvero per i soggetti privi in tutto o in parte della capacità d’intendere e volere, come minori, interdetti, ovvero minori emancipati ed inabilitati, ex artt. 471, 472, c.c.
A fronte dell’accettazione espressa, anche la condotta compiuta dal chiamato all’eredità, da valutarsi unitamente ad altri fattori, può assurgere a un’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476, c.c.
Con riguardo all’accettazione tacita dell’eredità abbiamo assodato, sulla base della giurisprudenza formatasi in materia, che essa può scaturire, tra l’altro, dal pagamento degli oneri condominiali, dalla percezione dei canoni di locazione di un immobile appartenuto al de cuius ovvero, come esaminato di recente, anche dalla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare tra i promittenti eredi, aventi causa del de cuius, ed il promissario acquirente (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 9436/2025: ne avevamo parlato qui).
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
Quando la costituzione in giudizio equivale ad accettazione tacita dell’eredità
A seguito del decesso del de cuius, ai sensi dell’art. 456, c.c., si apre la successione cui sono imputati tutti i beni di cui il medesimo era proprietario.
Con i beni si trasmettono, allo stesso modo, anche tutti i rapporti attivi o passivi di cui il defunto era titolare fino al momento del suo decesso e tra questi anche i debiti pertinenti alle domande risarcitorie scaturenti da illeciti civili.
Azioni giudiziarie pendenti e posizione dei chiamati all’eredità
Ora, si supponga, per esempio, che tra i rapporti giuridici passivi che i chiamati all’eredità si trovano a seguito dell’apertura della successione vi sia anche un’azione giudiziale esperita da un creditore del loro dante causa.
Oppure si può, finanche, supporre, che i chiamati all’eredità accettino di ricevere, dopo l’apertura della successione, la notifica di un atto di citazione avente a oggetto sempre una pretesa creditoria esercitata dal creditore del de cuius.
Costituzione in giudizio e rischio di accettazione tacita
In ragione di ciò, i chiamati all’eredità possono decidere di costituirsi in giudizio, facendo attenzione, tuttavia, al contenuto di tal atto processuale, il quale potrebbe essere anche qualificato dal giudicante come una forma di accettazione tacita dell’eredità.
Se quindi nell’atto di costituzione i chiamati all’eredità si limitano a contestare la legittimazione processuale passiva rispetto al rapporto dedotto in contestazione, senza, peraltro, prendere posizione, nel merito, sulla pretesa azionata verso il de cuius, tal atto non potrà esser valutato come una forma d’accettazione tacita d’eredità.
Contestazione nel merito e configurabilità dell’accettazione tacita
Viceversa, qualora con l’atto di costituzione i chiamati all’eredità si determino a contestare, nel merito, il fondamento e la natura del diritto – di credito – azionato dall’attore verso il de cuius, invocando la loro qualità di eredi, ecco che, allora, tal atto processuale equivale ad una accettazione tacita dell’eredità.
La contestazione del chiamato all’eredità, sul piano sostanziale, del fondamento del diritto azionato dal creditore all’indirizzo del de cuius, implica, necessariamente, l’affermazione della qualità di erede incompatibile, come tale, la volontà di rinuncia all’eredità.
Atti conservativi e limiti dell’amministrazione prima dell’accettazione
Anche l’atto di costituzione in giudizio del chiamato all’eredità, può essere annoverato tra gli atti di conservazione del patrimonio del defunto, purché con esso non si miri ad affermare, quale presupposto della propria posizione processuale, la qualità di erede inconciliabile con la rinuncia all’eredità.
In tal direzione, non soltanto gli atti di disposizione, bensì anche quelli di gestione del patrimonio del defunto possono significare un’accettazione tacita dell’eredità.
Gli atti ex art. 460 c.c. e la valutazione caso per caso
Pensando all’art. 460 c.c., il chiamato all’eredità è abilitato a compiere quegli atti volti alla conservazione del patrimonio del defunto, cosicché le azioni possessorie ovvero conservative che questi può esperire altro scopo non hanno se non quello di garantire l’integrità dell’eredità fintantoché essa non sarà accettata.
Il giudizio sulla natura degli atti compiuti, ai sensi dell’art. 460, c.c., dal chiamato all’eredità deve essere valutata con riguardo alla singola fattispecie facendo attenzione a verificare se tal azione esorbiti dall’ordinaria amministrazione o conservazione del patrimonio ereditario.
In tal direzione, secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, si precisa che “…sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un’effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell’ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall’art. 460 c.c. (…) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede” (Cass. Civ., Sent. n. 1183 del 18 gennaio 2017).
Se, pertanto, a fronte dell’azione intrapresa dal lavoratore, volta a ottenere, tra l’atro, il pagamento di differenze retributive, gli eredi del datore di lavoro si costituiscono in giudizio contestando, nel merito, la pretesa azionata dal creditore, tal atto dovrà essere qualificato come accettazione tacita dell’eredità (Cfr. Cass. Civ, Sent. n. 1183/ 2017, cit.).
Il principio confermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 24006 del 27 agosto 2025
Tale conclusione è coerente con i principi sopra illustrati in virtù dei quali al fine di accertare se un atto compiuto dal chiamato all’eredità esorbiti o meno dall’ordinaria amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario, è necessario indagarne la finalità, nel senso, cioè, di acclarare se esso comporti un mutamento dello stato da chiamato all’eredità ad erede.
Ne consegue che se con la costituzione in giudizio il chiamato all’eredità si limita a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla controversia, tal atto non potrà esser qualificato come un’accettazione tacita dell’eredità, giacché essa non esorbita dalla gestione ordinaria e conservativa del compendio ereditario.
Di converso, laddove con la costituzione in giudizio il chiamato all’eredità contesti la fondatezza giuridica, deducendo fatti estintivi e/o modificativi, del diritto azionato dal creditore del de cuius, affermando, implicitamente, la propria qualità di erede, essa dovrà qualificarsi, secondo le regole ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza in commento, come un’accettazione tacita dell’eredità, perché atto esorbitante dall’ordinaria amministrazione e gestione dei beni devoluti.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato
Ed è proprio sulla scorta del citato orientamento giurisprudenziale che la pronuncia in rassegna ha ribadito il principio secondo il quale “…l’assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell’eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità (…) ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla…” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 24006 del 27 agosto 2025).
Nel caso sottoposto allo scrutinio dell’ordinanza in esame, la costituzione in giudizio degli eredi del defunto imprenditore, con la quale contestavano, nel merito, la domanda risarcitoria del danno formulata dal fallimento, deve esser qualificata come un’accettazione tacita dell’eredità, poiché con essa i medesimi “…non solo si sono espressamente qualificati quali coeredi dello stesso (sia nella comparsa di costituzione, che nella relativa procura ad litem), ma hanno, altresì, insistito nelle difese spiegate dal de cuius, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei confronti di quest’ultimo…”(Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 24006/2025, cit.).
Giova, inoltre, osservare, quale corollario dei principi sopra esaminati, che anche l’atto di costituzione in giudizio, deputato a cristallizzare la posizione processuale dei chiamati all’eredità, collima con il principio della ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., considerando la necessità di non vedere frustata la pretesa del creditore in attesa che si maturi il termine decennale per l’accettazione dell’eredità dell’originario debitore.
Conclusioni
Alla luce delle superiori argomentazioni giuridiche, si possono trarre le seguenti riflessioni.
Abbiamo visto che tra gli atti che possono essere qualificati come un’accettazione tacita dell’eredità, si possono annoverare il pagamento degli oneri condominiali, la stipulazione di contratti preliminari di compravendita immobiliare, la voltura catastale degli immobili ricevuti in eredità.
Eppur, tuttavia, il novero degli atti che possono qualificarsi come accettazione tacita dell’eredità si ampia, perché la giurisprudenza di legittimità c’insegna che anche l’atto di costituzione in giudizio del chiamato all’eredità, laddove sia improntato a contestare, nel merito, l’azione esperita dal creditore avverso, l’originario debitore, non limitandosi, indi, a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, assume il valore, ex art. 476, c.c., di un’accettazione tacita dell’eredità.
Calandosi nel contesto processuale dell’atto in esame, vale la pena, poi, evidenziare che un tal orientamento risulta coerente anche con il principio della ragionevole durata del processo, ex art. 111, Cost., anche al fine di preservare il diritto del creditore esposto ad un’incertezza processuale durante il tempo necessario della prescrizione decennale prevista per l’accettazione dell’eredità.