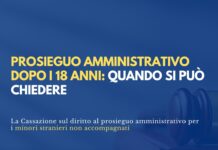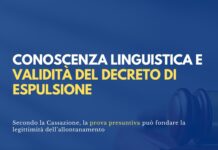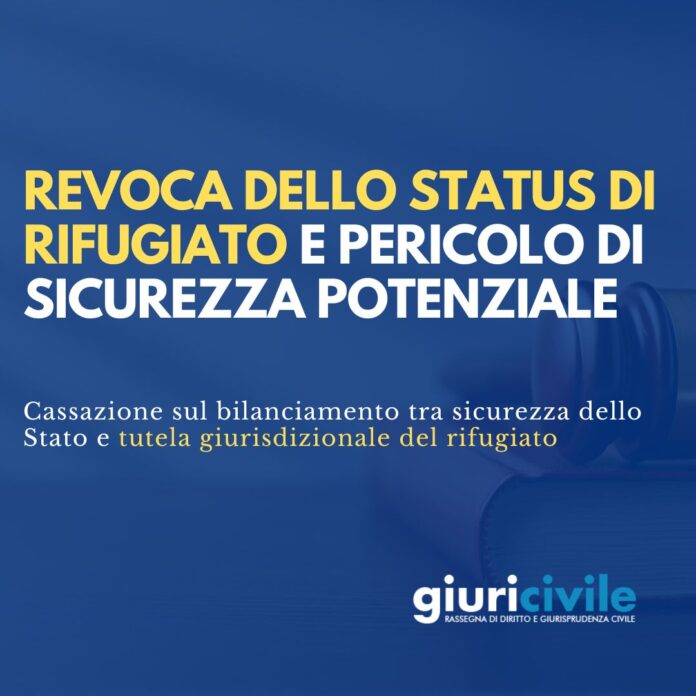
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 18427/2025, del 7 luglio (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), interviene sul delicato bilanciamento tra sicurezza dello Stato e tutela giurisdizionale del rifugiato, affrontando due aspetti di particolare rilievo: la motivazione per relationem a documenti con apposta la “classifica di segretezza”, e la nozione di “pericolo” ai fini della revoca dello status. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.
Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).
Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.
Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Leggi descrizione
Paolo Morozzo della Rocca, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €

Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.
Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).
Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.
Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Il caso
La vicenda prende le mosse da un decreto del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso di un cittadino straniero, aveva annullato la revoca dello status di rifugiato disposta dalla Commissione Nazionale per il diritto d’asilo. Tale revoca era stata motivata sotto due distinti profili: da un lato, la presunta pericolosità del soggetto per la sicurezza dello Stato, attestata da una nota riservata della Polizia di Prevenzione; dall’altro, l’asserita infondatezza originaria della richiesta di protezione, con riferimento all’orientamento sessuale dichiarato dal richiedente.
Il Tribunale, ritenendo che l’Amministrazione avesse scelto di non produrre la nota riservata, ha considerato l’atto “tamquam non esset” e ha escluso che le manifestazioni online del ricorrente, seppur violente, fossero di per sé idonee a fondare la revoca. Da qui il ricorso in Cassazione del Ministero dell’Interno, fondato su due motivi: l’omesso utilizzo della procedura ex art. 42, comma 8, legge n. 124/2007 per l’ostensione controllata del documento classificato e una presunta erronea interpretazione dei requisiti di pericolosità di cui alla Direttiva 2011/95/UE.
La motivazione per relationem a documenti secretati
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte ha accolto integralmente la doglianza dell’Amministrazione. La pronuncia ricostruisce puntualmente la disciplina dell’accesso ai documenti classificati come “riservati”, chiarendo che l’autorità giudiziaria non solo può, ma deve attivare la procedura prevista dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007 ogniqualvolta un provvedimento amministrativo faccia rinvio a un documento riservato.
La motivazione per relationem, spiega la Corte, è legittima anche quando fondata su atti secretati, a condizione che sia possibile un vaglio giurisdizionale della loro idoneità e coerenza. Escludere aprioristicamente l’utilizzabilità di tali atti in giudizio senza attivare il canale processuale dedicato significa, secondo i giudici, compromettere il corretto bilanciamento tra esigenze di sicurezza e garanzie difensive.
Ne deriva che il giudice di merito non avrebbe potuto ignorare la nota ministeriale senza prima acquisirla con le cautele imposte dalla legge. L’omissione di questo passaggio, osserva la Cassazione, ha privato il contraddittorio di un elemento decisivo e vanificato la possibilità di un controllo giurisdizionale completo sulla decisione amministrativa.
Potrebbero interessarti anche:
-
Limiti del sindacato giurisdizionale sul Regolamento Dublino III (Sezioni Unite)
-
Trattenimento dei migranti e responsabilità civile dello Stato: le Sezioni Unite sul Caso Diciotti
Il concetto di “pericolo per la sicurezza dello Stato”: tra attualità e potenzialità
La seconda questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda il parametro di giudizio applicato dal Tribunale per valutare la sussistenza del pericolo richiesto ai fini della revoca dello status. Il giudice di merito aveva subordinato la legittimità della revoca alla prova di un rischio “concreto” e “attuale” di passaggio all’azione offensiva, escludendo che i soli messaggi minacciosi pubblicati sui social potessero integrare il requisito.
La Cassazione, al contrario, evidenzia come l’art. 14, par. 4, lett. a), della Direttiva 2011/95/UE — norma di riferimento per il diritto interno — richiede solo che vi siano “fondati motivi per ritenere” che il soggetto costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Non è dunque necessario accertare un pericolo attuale nel senso stretto del termine: anche un rischio potenziale, purché ragionevolmente fondato, è sufficiente a giustificare la revoca dello status di protezione internazionale.
Questa lettura, coerente con la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare causa C-454/23), riconosce agli Stati un margine di discrezionalità nel valutare i profili di sicurezza nazionale, nel rispetto però di un controllo di proporzionalità esercitabile dal giudice. Quest’ultimo, sottolinea la Cassazione, deve evitare una sovrapposizione con il merito amministrativo, ma può e deve verificare la congruità del giudizio di pericolosità, soprattutto alla luce di situazioni non ancora sfociate in condotte delittuose ma suscettibili di evoluzione radicale.
La Suprema Corte ha, quindi, accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Conclusioni e prospettive applicative
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione offre due indicazioni di sistema, destinate a orientare stabilmente il contenzioso in materia di protezione internazionale. Da un lato, richiama l’obbligo per il giudice di garantire l’accessibilità in contraddittorio ai documenti con apposta la classifica di “segretezza”, nei limiti e con le forme delineate dalla normativa sulla sicurezza nazionale. Dall’altro, chiarisce che il pericolo per la sicurezza dello Stato non va ridotto a una mera attualità del rischio, potendo includere situazioni prefigurate sulla base di segnali concreti ma non ancora esplosi.