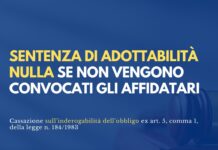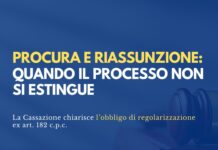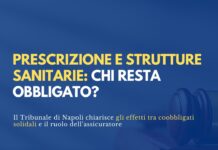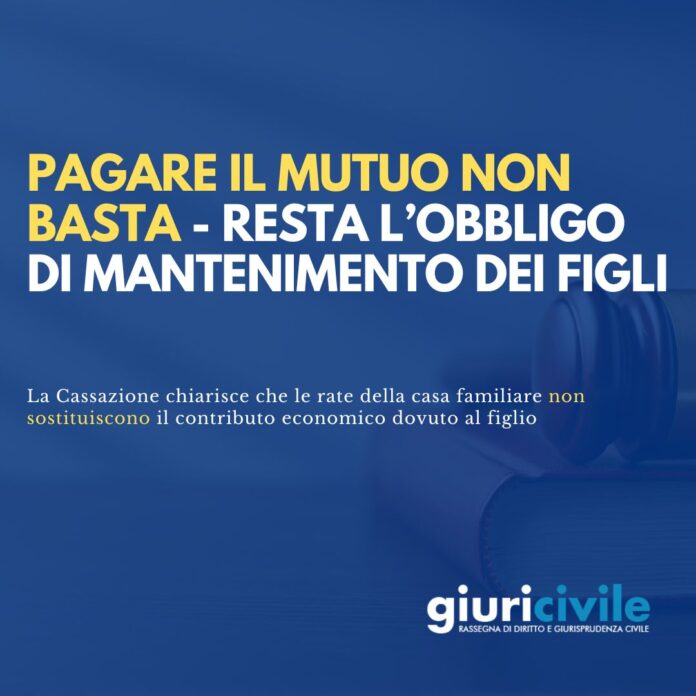
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 25558 del 18 settembre 2025, ha affrontato nuovamente il tema del rapporto tra il pagamento del mutuo dell’abitazione familiare e l’obbligo di mantenimento dei figli. La questione riguarda la pretesa del genitore proprietario, non collocatario, di considerare la rata del mutuo come parte del contributo di mantenimento. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Formulario commentato della famiglia e delle persone”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Formulario commentato della famiglia e delle persone
Il testo, aggiornato al D.L. 8 agosto 2025, n. 117 (decreto giustizia) e ai decreti correttivi “Cartabia” e “mediazione”, raccoglie oltre 240 formule, coordinate con il nuovo rito unificato, corredate da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Le formule contengono la doppia indicazione del tribunale attualmente competente e del nuovo TMPF, che entrerà in vigore a ottobre 2026.
Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
73.00 €
69.35 €

Formulario commentato della famiglia e delle persone
Il testo, aggiornato al D.L. 8 agosto 2025, n. 117 (decreto giustizia) e ai decreti correttivi “Cartabia” e “mediazione”, raccoglie oltre 240 formule, coordinate con il nuovo rito unificato, corredate da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Le formule contengono la doppia indicazione del tribunale attualmente competente e del nuovo TMPF, che entrerà in vigore a ottobre 2026.
Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.
La controversia tra ex coniugi
La controversia tra gli ex coniugi trae origine da un giudizio di divorzio definito dal Tribunale di Lodi nel 2023 e successivamente riformato in parte dalla Corte d’appello di Milano. Quest’ultima, accertata una significativa differenza di capacità patrimoniali tra le parti, aveva posto a carico del padre – socio al 40% di una società familiare – un contributo perequativo per la figlia minore, fissato in euro 450 mensili, comprensivi delle spese condominiali e utenze.
Il giudice di secondo grado aveva altresì escluso che la rata del mutuo gravante sull’abitazione familiare, di esclusiva proprietà del padre e assegnata alla madre con la figlia, potesse essere computata come parte del mantenimento.
Il ricorso per cassazione proposto dal padre denunciava, tra l’altro, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove e invertito l’onere probatorio in ordine alle sue reali capacità economiche.
La madre, in via incidentale, lamentava la contraddittorietà della motivazione sulla decorrenza del contributo per la figlia e sulla ripartizione delle spese abitative.
La valutazione della capacità reddituale effettiva
La Cassazione ha ritenuto infondati i primi motivi del ricorso principale, confermando la correttezza del ragionamento della Corte d’appello circa la valutazione della capacità reddituale del padre.
Il giudice di merito – rileva la Suprema Corte – non ha violato i criteri di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), avendo fondato il proprio convincimento su elementi oggettivi e coerenti con l’art. 115 c.p.c. Le dichiarazioni dei redditi, di natura meramente fiscale, non vincolano il giudice civile, che può basarsi su altri indici rivelatori della reale capacità economica: tenore di vita, investimenti, proprietà societarie e assenza di indebitamento.
In tal senso, l’art. 2729 c.c. consente il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La Corte ha ribadito che il reddito dichiarato (poco più di 1.000 euro annui) non poteva giustificare il tenore di vita mantenuto e la capacità di far fronte a oneri economici significativi. Tale discrasia legittimava la conclusione che il genitore disponesse di risorse ulteriori, riconducibili alla redditività effettiva della società familiare.
Potrebbero interessarti anche:
- Assegno di mantenimento figli minori: va determinato secondo criteri di proporzionalità e concretezza
- Mantenimento figli maggiorenni: il genitore collocatario può scegliere se tenere il figlio in casa o versare l’assegno di mantenimento?
- Il mantenimento dei figli maggiorenni tra responsabilità genitoriale e autoresponsabilità
- L’assegno di mantenimento per i figli minori: criteri di determinazione e procedura di revisione
- Revoca del mantenimento al figlio maggiorenne: i presupposti
- Rimborso spese straordinarie dei figli: quando serve la documentazione nel precetto
Il pagamento del mutuo e l’obbligo di mantenimento
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda l’esclusione dell’equivalenza tra pagamento del mutuo e mantenimento dei figli.
Secondo la Corte, quando l’abitazione familiare è di proprietà esclusiva del genitore obbligato, il pagamento delle rate del mutuo costituisce un adempimento connesso alla propria sfera patrimoniale e non integra una forma di mantenimento.
Diversa è l’ipotesi in cui l’immobile sia cointestato ai coniugi e il mutuo condiviso: in tal caso, l’accollo integrale delle rate da parte di un genitore può generare uno sgravio economico per l’altro e incidere sulla misura dell’assegno.
Nel caso esaminato, la Corte ha precisato che il beneficio di godimento dell’abitazione da parte della madre e della figlia rappresenta solo un vantaggio in natura, idoneo a ridurre l’esborso per canone di locazione, ma non sostitutivo dell’obbligo di mantenimento.
Il giudice deve pertanto determinare l’assegno considerando tale beneficio, ma senza imputare il pagamento del mutuo come contributo diretto al mantenimento.
La questione della decorrenza dell’assegno
L’unico profilo accolto dalla Cassazione riguarda la decorrenza dell’assegno di mantenimento.
La Corte ha riscontrato una contraddizione logica nella sentenza impugnata: nella motivazione si indicava come data iniziale il trasferimento della figlia maggiore presso il padre (febbraio 2023), mentre nel dispositivo la decorrenza era fissata al passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Tale incoerenza, priva di fondamento logico-giuridico, ha imposto la cassazione con rinvio, con l’indicazione che la decorrenza deve essere ancorata alla modifica di fatto delle condizioni familiari, non a eventi processuali formali.
La decisione in sintesi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25558/2025, ha quindi:
-
confermato la piena discrezionalità del giudice di merito nel valutare la capacità reddituale effettiva del genitore obbligato, anche mediante presunzioni semplici;
-
precisato che il pagamento del mutuo sull’abitazione familiare non costituisce adempimento dell’obbligo di mantenimento, ma una prestazione personale diretta all’acquisto o alla conservazione della proprietà;
-
chiarito che il godimento dell’immobile da parte dell’altro genitore rileva solo come elemento valutativo nella quantificazione dell’assegno;
-
cassato la sentenza limitatamente alla decorrenza dell’assegno, che deve coincidere con il momento del mutamento di fatto delle condizioni economiche o familiari.
Il principio affermato, di grande rilievo pratico, rafforza la netta distinzione tra obblighi patrimoniali individuali e doveri genitoriali di mantenimento, valorizzando l’effettiva capacità contributiva e il criterio dell’equità.