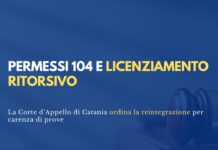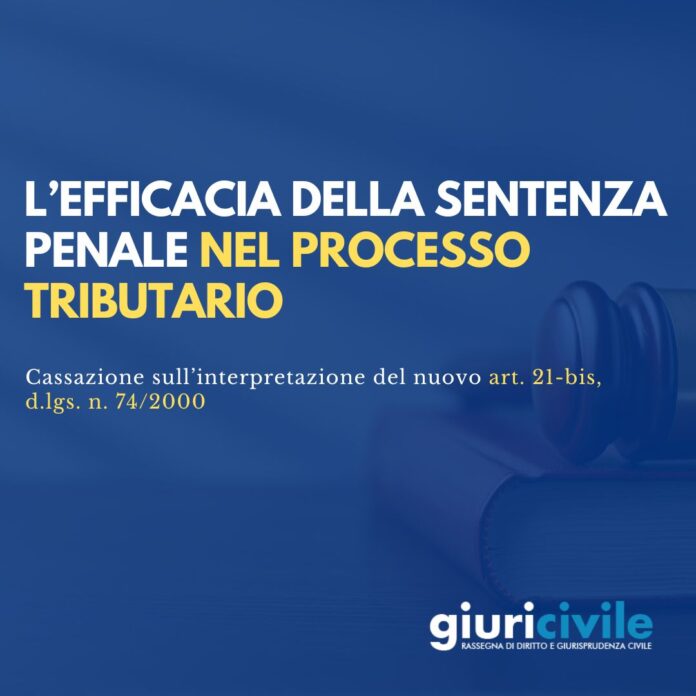
Il rapporto tra giudizio penale e processo tributario rappresenta una fattispecie complessa, in rappresentazione della tensione tra l’autonomia dei rispettivi procedimenti e la necessità di evitare esiti decisori contraddittori. Con la sentenza n. 21594 del 27 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione offre un’approfondita interpretazione del nuovo art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, che dispone sull’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Il caso
La decisione
La pronuncia della Suprema Corte offre un’articolata esegesi del nuovo art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000. Tale norma stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario avente ad oggetto i medesimi fatti materiali. La Corte, discostandosi da una lettura potenzialmente dirompente, sposa un’interpretazione restrittiva, concludendo che la norma si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non all’imposta.
Ragioni dell’interpretazione restrittiva
Le ragioni di tale approdo sono le seguenti:
- Interpretazione sistematica: l’art. 21-bis è stato introdotto nell’ambito di una riforma (d.lgs. n. 87/2024) la cui ratio, desumibile dalla legge delega (L. n. 111/2023), era la revisione del sistema sanzionatorio tributario, in un’ottica di rafforzamento del principio del ne bis in idem. La norma va quindi letta in coerenza con gli artt. 19-21 dello stesso decreto, che delineano l’autonoma gestione dei rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo-tributario, confermando l’assetto del “doppio binario”.
- Interpretazione letterale: il comma 3 dell’art. 21-bis estende l’applicabilità della norma “anche” nei confronti della persona fisica che ha agito per conto dell’ente o dei soci. Secondo la Corte, l’uso della congiunzione “anche” ha senso solo in una prospettiva sanzionatoria, poiché l’obbligazione tributaria principale grava unicamente sul soggetto passivo d’imposta (la società o l’imprenditore), e non sui suoi rappresentanti o soci in quanto tali.
- Compatibilità Costituzionale e Unionale: un’efficacia estesa all’imposta porrebbe seri dubbi di legittimità costituzionale. Si creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.): i contribuenti autori di evasioni più gravi (penalmente rilevanti) potrebbero beneficiare del più favorevole regime probatorio penale (dove l’onere della prova è tutto a carico dell’accusa), mentre per le evasioni di minor entità si applicherebbe sempre il più rigoroso regime tributario. Inoltre, verrebbe leso il diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate, che non partecipa al giudizio penale. La limitazione alle sole sanzioni elide queste criticità e allinea la norma ai principi dell’Unione Europea, che non consentirebbero di paralizzare l’accertamento di tributi armonizzati come l’IVA sulla base di un giudicato penale fondato su presupposti e standard probatori diversi.
Ambito applicativo della norma
- Tipo di procedimento: la sentenza penale deve essere stata pronunciata “in seguito a dibattimento“. Ciò esclude categoricamente, come nel caso di specie, le sentenze emesse all’esito di un giudizio abbreviato, che è per definizione celebrato “allo stato degli atti” e senza fase dibattimentale. Sono altresì escluse le sentenze di patteggiamento e i decreti di archiviazione.
- Formula dell’assoluzione: rilevano unicamente le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”.
- Contenuto dell’accertamento: l’assoluzione non deve derivare da una mera insufficienza di prove (art. 530, co. 2, c.p.p.), ma da un effettivo e positivo accertamento circa l’insussistenza del fatto. Un’assoluzione “dubitativa” non è idonea a formare giudicato nel processo tributario.
Applicazione al caso concreto
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Poiché la sentenza di assoluzione del legale rappresentante era stata emessa all’esito di un giudizio abbreviato, l’art. 21-bis non era applicabile. Di conseguenza, la CTR aveva errato nel ritenersi vincolata da tale pronuncia. Avrebbe dovuto, invece, procedere a un’autonoma valutazione di tutti gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione Finanziaria per dimostrare la consapevolezza del contribuente di essere parte di una frode (come la mancanza di una reale struttura del fornitore e l’assenza di contatti diretti), senza potersi fermare alla mera regolarità formale delle fatture e dei pagamenti. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame.