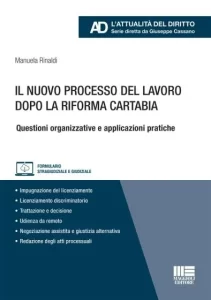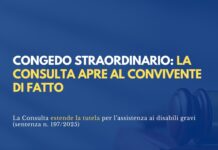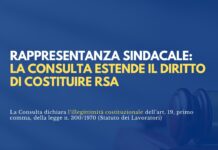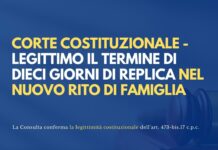La sentenza della Corte costituzionale (n. 22/2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. primo comma in quanto limitava la tutela reintegratoria ai casi di nullità espressamente previsti dalla legge.
Corte costituzionale-sent. n. 22 del 22-02-2024
La questione
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, il 7 aprile 2023, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulll’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015. Questo articolo è stato contestato per non essere conforme al criterio di delega stabilito dall’art. 1, comma 7, lettera c) della legge n. 183 del 2014. Tale questione è emersa durante l’appello contro una sentenza che ha dichiarato nullo un licenziamento disciplinare e ha ordinato al datore di lavoro di pagare le relative indennità.
Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
La Corte costituzionale ha precisato che la questione sollevata non presenta aspetti di inammissibilità. Con riferimento alla rilevanza, i dettagli relativi al procedimento principale e gli argomenti avanzati a sostegno della tesi interpretativa risultano plausibili, supportando l’applicabilità temporale della disposizione oggetto di impugnazione. In particolare, la Corte rimettente ha confermato che il licenziamento è stato notificato a un dipendente autoferrotranviere assunto successivamente al 7 marzo 2015, quindi rientrante nel contesto normativo introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2015.
La nullità del provvedimento impugnato richiede una considerazione del principio giuridico attuale che regolamenta l’istituto dei Consigli di disciplina per la maggior parte delle aziende di trasporto, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il tribunale di primo grado ha chiarito che la richiesta di coinvolgimento del Consiglio di disciplina non solo fornisce ulteriori tutele al lavoratore, ma trasferisce anche il potere decisionale sul licenziamento dal datore di lavoro a un organo terzo e collegiale. La violazione di questa disposizione, considerata inderogabile, porta alla nullità della sanzione disciplinare, ritenuta una nullità protettiva in quanto mira a salvaguardare il dipendente. Questo principio è stato confermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ribadisce l’importanza della disciplina speciale dei licenziamenti per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione.
In relazione alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ha offerto una motivazione dettagliata riguardo ai dubbi di legittimità costituzionale relativi alla norma contestata, specificando il tipo di intervento richiesto, limitato alla rimozione dell’avverbio “espressamente”, la cui inclusione nella disposizione impugnata potrebbe rappresentare un eccesso di delega legislativa.
Tutela reintegratoria
Per comprendere la questione, è fondamentale richiamare la tutela reintegratoria introdotta dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La Corte Suprema ha riconosciuto una portata estensiva alle disposizioni dell’art. 18, capaci di garantire la tutela effettiva del posto di lavoro anche in assenza di cause specifiche previste dalla legge. Tuttavia, successive riforme hanno progressivamente ridimensionato questa tutela, introducendo diversi regimi per tutelare i lavoratori dai licenziamenti illegittimi.
Un primo cambiamento è stato introdotto dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, che ha modificato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, differenziando i regimi di tutela per i licenziamenti individuali illegittimi. La reintegrazione è stata riservata solo per i licenziamenti con gravi violazioni, mentre per gli altri è stata prevista una compensazione economica. In seguito, il Jobs Act (legge n. 183 del 2014), ha introdotto una nuova disciplina, il cd. contratto a tutele crescenti. Questo regime ha ridimensionato del tutto la tutela reintegratoria nei casi di licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Tuttavia, come previsto dalla legge n. 92 del 2012, il licenziamento discriminatorio è stato mantenuto come causa di nullità, soggetto alla tutela reintegratoria.
In sintesi, la Corte rimettente ha sottolineato la necessità di rimuovere l’avverbio “espressamente” dalla norma contestata per evitare un eccesso di delega legislativa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il licenziamento nullo non si esaurisce nelle sole situazioni di licenziamento discriminatorio o di licenziamento ingiustificato. Esso può verificarsi sia nei tassativamente previsti dalla legge, come nel caso del licenziamento per motivi connessi al matrimonio, durante lo stato di gravidanza e il periodo di maternità, sia per violazione di norme imperative, in base all’art. 1418, comma 1, c.c.
Tuttavia, in seguito, il legislatore modificando parzialmente l’art. 1418, primo comma, del codice civile, ha stabilito che la violazione delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina automaticamente l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che non si comprometta irrimediabilmente il diritto di difesa del dipendente. Di conseguenza, tale cambiamento ha attenuato il carattere imperativo della disciplina.
Licenziamento nullo
Nel contesto normativo del decreto legislativo n. 23 del 2015, la disciplina del licenziamento nullo è delineata dall’art. 2, che distingue chiaramente tra licenziamento discriminatorio e licenziamento nullo. Il primo comma stabilisce che il giudice, nel dichiarare la nullità del licenziamento per motivi discriminatori o per altre ipotesi di nullità previste dalla legge, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dalla motivazione formalmente addotta.
La questione della nullità del licenziamento per violazione di norme imperative non è messa in discussione dalla possibilità di prevedere specifiche ipotesi di nullità di protezione a seguito della violazione delle prescrizioni procedurali a tutela del lavoratore.
La Corte rimettente parte dall’interpretazione che l’inserimento dell’avverbio “espressamente” escluda dall’ambito applicativo tutte le ipotesi in cui, pur violando una norma imperativa, la nullità non sia prevista come conseguenza.
I giudici hanno ritenuto la questione sollevata in relazione all’articolo 76 della Costituzione pertinente.
La questione sollevata riguarda l’eccesso di delega nel vincolare la reintegrazione esclusivamente ai licenziamenti espressamente nulli, escludendo altre forme di nullità. Ciò contrasta con il principio direttivo della legge di delega, che prevede la reintegrazione in caso di licenziamento nullo in generale.
La giurisprudenza costituzionale ha adottato un’interpretazione flessibile dei limiti alla delegazione legislativa, considerando la complessità di settori dell’ordinamento che richiedono tale modalità di intervento. Tuttavia, la legge delega può essere anche molto specifica, limitando il margine di discrezionalità del legislatore delegato e richiedendo un’applicazione quasi letterale delle disposizioni delegate. In questi casi, il controllo sulla conformità ai principi direttivi e sugli oggetti della delega diventa molto rigoroso.
L’eccesso di delega
Secondo l’opinione del giudice delle leggi, il confronto tra l’interpretazione letterale e quella funzionale-teleologica delle norme giuridiche riveste un ruolo chiave nel valutare la conformità delle norme delegate alla legge che le ha delegate. In questo caso, dalla lettura della legge delega non emerge una distinzione esplicita tra le nullità “espressamente” previste e quelle derivanti dalla violazione di norme imperative senza una specifica previsione di nullità. La previsione della reintegrazione è limitata ai “licenziamenti nulli” senza una ulteriore distinzione che sarebbe stata necessaria se il legislatore delegante avesse voluto includere tale differenziazione.
Inoltre, una valutazione sistematica della legge di delega suggerisce che la limitazione alla nullità testuale sia incoerente con l’obiettivo complessivo della legge, volta a disciplinare in modo generale i licenziamenti per i lavoratori assunti dopo una determinata data.La restrizione dell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015 ai licenziamenti in cui la nullità è esplicitamente prevista costituisce una discrasia rispetto alla volontà originaria del legislatore delegante. Questa restrizione lascia un vuote normativo nelle situazioni di licenziamento ritenute nulli ma non specificamente indicate come tali dalla legge. Tali situazioni, non rientrando nell’ambito dei licenziamenti “economici”, non possono godere della tutela reintegratoria ma allo stesso tempo non sono soggette alla protezione indennitaria prevista per altre forme di licenziamento illegittimo.
Tra le numerose situazioni in cui manca una previsione esplicita di nullità, emergono casi come il licenziamento durante il periodo di comporto per malattia, il licenziamento motivato dall’azione legittima del dipendente di segnalare illeciti del datore di lavoro, il licenziamento in violazione delle restrizioni sui licenziamenti economici durante l’emergenza COVID-19, il licenziamento contrario alle norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e il licenziamento in violazione del diritto alla conservazione del posto per dipendenti con problemi di tossicodipendenza.
La giurisprudenza consolidata, sia nel campo del diritto del lavoro che in altri settori, ha equiparato la violazione di norme imperative alla nullità, stabilendo che entrambe implicano la sanzione della nullità. Questo principio ha comportato una inversione della regola civile secondo cui la nullità è la conseguenza per la violazione di norme imperative, a meno che una legge non disponga diversamente. In questo contesto, la previsione di una sanzione “diversa” da parte della legge ha lo scopo di derogare alla nullità che normalmente deriverebbe dalla violazione di norme imperative.
L’eccesso di delega nell’ambito del caso in esame si manifesta sia nella chiara formulazione del criterio direttivo, che consente distinzioni per i licenziamenti disciplinari ma non per quelli nulli, sia nell’interpretazione sistematica, che evidenzia la contraddizione di una distinzione non accompagnata dalla previsione del tipo di tutela applicabile alla situazione esclusa dal regime della reintegrazione.
Conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015, limitatamente alla parola “espressamente”. Dunque, spetta al legislatore, tenendo conto delle indicazioni fornite in diverse occasioni dalla Corte costituzionale, riformulare in modo coerente la norma oggetto della questione.
Volume consigliato