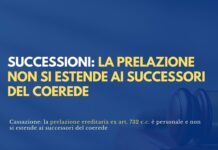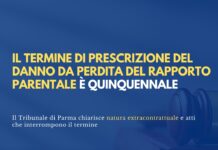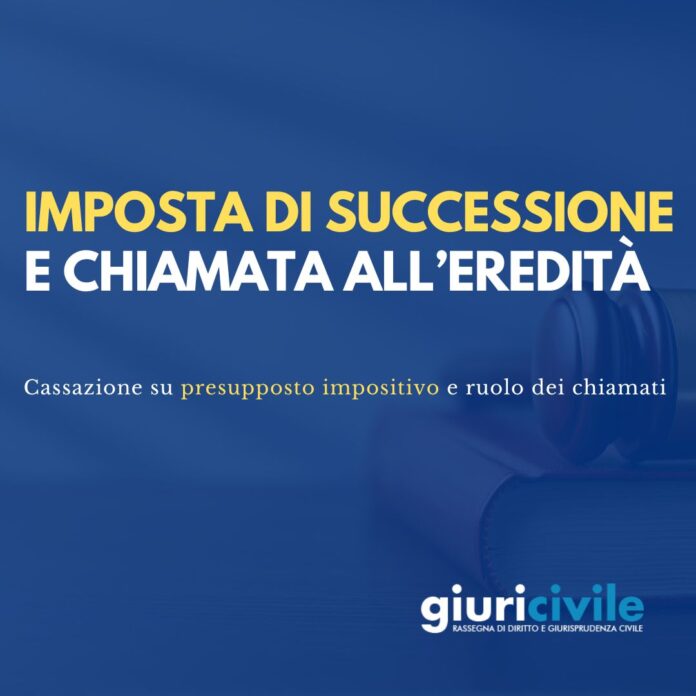
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18252/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha riaffermato un principio in materia di imposta di successione: il soggetto passivo del tributo è individuato nella chiamata all’eredità, a prescindere dall’accettazione formale dell’eredità medesima. La decisione chiarisce che, ai fini tributari, la delazione ereditaria comporta l’obbligo di pagamento del tributo finanche in assenza di accettazione, disciplinando in tal modo il caso di successioni “a catena” con plurimi eredi coinvolti. Pertanto, ai fini dell’imposta sulle successioni, la chiamata all’eredità integra il presupposto impositivo, a prescindere dall’accettazione dell’erede, e l’obbligo tributario grava sui chiamati che non hanno rinunciato, con responsabilità limitata al valore dei beni ereditari eventualmente posseduti.
Consiglio: il “Manuale pratico per la successione testamentaria e le donazioni”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria.

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Leggi descrizione
Riccardo Mazzon, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
La qualità di eredi “diretti” o “indiretti”
Il caso affrontato dalla Sezione Tributaria ha riguardato la successione di una donna deceduta nel 2016, la cui eredità era stata in parte devoluta a titolo testamentario con un testamento olografo. La prima dichiarazione di successione, presentata dall’erede testamentario, indicava erroneamente come erede un fratello deceduto, venuto a mancare appena un giorno dopo la sorella. In seguito, furono presentate dichiarazioni integrative che modificavano tale circostanza, sostituendo tale fratello coi suoi due figli, rappresentanti della linea successoria in luogo del padre defunto.
L’Agenzia delle Entrate notificò un avviso di liquidazione dell’imposta di successione agli eredi, qualificando i due nipoti della defunta come eredi “del chiamato” fratello, anche lui deceduto. Per l’effetto origina il contenzioso, in quanto i contribuenti sostennero di dover essere considerati eredi diretti della zia e non come eredi del padre deceduto, poiché quest’ultimo non aveva potuto accettare l’eredità per la sua morte sopraggiunta poco dopo la sorella.
Le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che non potesse essere imputata loro la qualità di eredi “indiretti” bensì solamente quella di eredi “diretti”, e quindi contestando il presupposto dell’imposizione tributaria espresso dall’Ufficio.
Fondamento del ricorso e posizione della Cassazione
L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli articoli 7, 28 e 36 del Decreto Legislativo n. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, cd. T.U.S.). Nello specifico, l’Ufficio ha affermato che l’obbligo di presentazione della dichiarazione e il relativo pagamento d’imposta gravano sui “chiamati all’eredità” anche in assenza dell’accettazione formale, salvo la rinuncia esplicita entro i termini di legge. Ai sensi del T.U.S., infatti, la chiamata determina, nell’ambito tributario, un’acquisizione di fatto dell’eredità.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, definendo il seguente principio di diritto:
“In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell’imposizione tributaria è la chiamata all’eredità e non già l’accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c.”.
Potrebbero interessarti anche:
-
Riforma imposta di successione e donazione: novità e impatto su tassazione Trust
-
Dichiarazione di successione 2025: novità, modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Sulla scia dei precedenti
La sentenza si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che ha da tempo distinto la disciplina dell’imposta di successione da quella civilistica riguardante l’acquisto della qualità di erede.
La disciplina civilistica richiede, infatti, l’accettazione dell’eredità a opera del chiamato per farlo diventare erede, come evidenziato in numerose pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 6479/2002; Cass. n. 11634/1991; Cass. n. 1885/1988). Tuttavia, la dimensione fiscale, per ragioni di tutela erariale e semplificazione amministrativa, tratta la mera chiamata come momento di delazione e imposizione tributaria, ben consolidato nel precedente Cass. n. 21394/2014 e ribadito in plurime occasioni (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21394; Cass. 23 marzo 2016, n. 5750).
Il presupposto del tributo
Ulteriormente, la Cassazione si è soffermata sulla sentenza dell’11 novembre 2021, n. 32611, che aveva già qualificato quale presupposto del tributo la chiamata all’eredità e non l’accettazione. La ratio si fonda anche sulle disposizioni del T.U.S., dagli articoli 7 e 28, che regolano l’obbligo di dichiarazione e la responsabilità dei chiamati, come pure dall’articolo 36 che disciplina la solidarietà degli eredi nel pagamento del tributo, distinguendo le ipotesi di accettazione o meno.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato la peculiarità dell’imposta di successione, differente dalla nozione civilistica tradizionale, in quanto la “delazione determina per sé stessa l’acquisto dell’eredità”, ai fini dell’imposizione tributaria. In dettaglio, occorre rilevare che la responsabilità del chiamato all’eredità è limitata al valore dei beni ereditari da lui eventualmente posseduti, come previsto dall’art. 36, comma 3 del T.U.S. Ciò comporta di fatto una tutela per chiamati che non abbiano ancora accettato e non detengano alcun bene ereditario, escludendoli dall’obbligo tributario.
L’unicità della normativa fiscale sulle successioni è poi evidente anche nel superamento della sentenza Cass. n. 8053/2017, che aveva vincolato l’obbligo successorio ai debiti tributari alla condizione dell’accettazione, ipotesi che la Corte ha circoscritto esclusivamente all’ambito civilistico e non a quello tributario.
La riammissione del giudizio
In conclusione, la Cassazione ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame della vicenda alla luce del principio di diritto espresso. Il nuovo giudizio dovrà tener conto di:
- imputazione della responsabilità tributaria ai chiamati all’eredità, anche in assenza di accettazione;
- verifica del possesso dei beni ereditari e la conseguente limitazione dell’obbligo tributario;
- corretto inquadramento degli eredi diretti e degli eredi per trasmissione mortis causa temporanea (successori del dante causa non ancora subentrati formalmente).
La vicenda esemplifica la complessità delle successioni multiple e delle implicazioni fiscali che ne derivano, sollecitando una più attenta valutazione dei rapporti tra diritti civili e obbligazioni fiscali nel contesto ereditario. La pronuncia in disamina si inserisce in un percorso giurisprudenziale volto a chiarire ambiti e limiti della responsabilità tributaria nelle successioni, tutelando gli interessi erariali senza tuttavia travolgere il principio della limitazione della responsabilità in capo agli eredi in assenza di possesso diretto di beni.
L’indirizzo ribadisce un approccio pragmatico e coerente con la finalità fiscale, che rende la chiamata all’eredità presupposto sufficiente per l’imposizione tributaria, superando eventuali disallineamenti con la disciplina civilistica tradizionale, la quale continua a regolare i diritti soggettivi e le qualità degli eredi. In tal modo, la Corte di Cassazione fornisce un contributo prezioso per la corretta applicazione della disciplina successoria fiscale, evitando svalutazioni del tributo per mere formalità civilistiche e al contempo garantendo un equo bilanciamento degli interessi implicati.