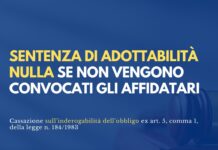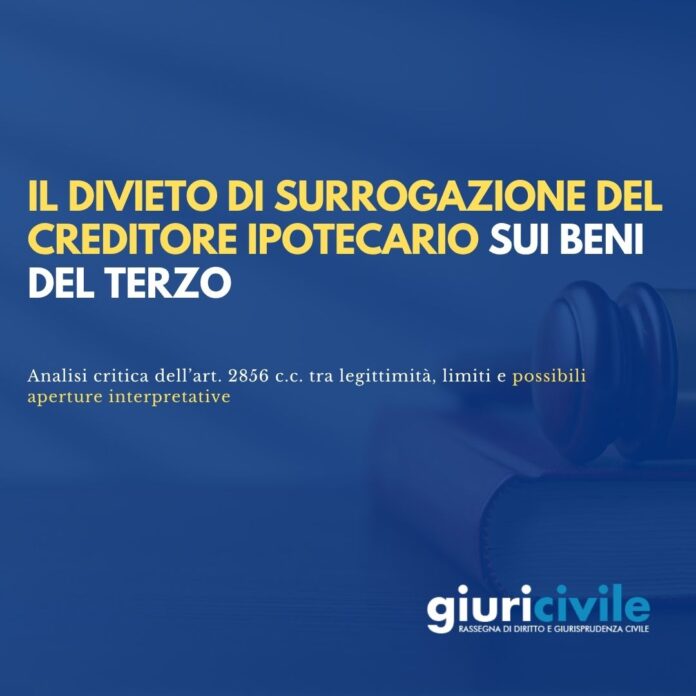
Il tema del divieto, previsto dall’art. 2856 c.c., di rivalersi sui beni concessi in ipoteca da un terzo datore solleva questioni di rilievo nel diritto civile e bancario.
La norma disciplina il caso in cui il creditore ipotecario, rimasto insoddisfatto a causa della priorità di altro creditore, non possa esercitare la surrogazione su beni gravati da ipoteca concessa da un soggetto diverso dal debitore principale.
L’analisi di questa disposizione mette in luce un delicato equilibrio tra tutela del creditore, liberazione del terzo garante e principi generali del sistema delle garanzie reali. Da un lato, il divieto appare coerente con la logica delle obbligazioni e con la disciplina della surrogazione; dall’altro, non mancano argomenti per considerarlo eccessivamente restrittivo, specie alla luce di altre norme che tutelano i creditori rimasti insoddisfatti.
La questione
Ai sensi dell’art. 2856 c.c., “il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione”.
Consiglio: il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.
L’art. 2857, comma 1, c.c. precisa tuttavia che “la surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo”.
Il creditore perdente è colui che non riesce a soddisfare le proprie ragioni perché preceduto, nel grado ipotecario, da un creditore anteriore.
Se il bene sul quale quest’ultimo si è soddisfatto presenta un valore superiore al credito, il residuo ricavato dalla vendita potrà essere destinato al creditore successivo.
Un esempio tipico è quello del creditore anteriore che ha iscritto ipoteca su due beni del debitore, il bene X e il bene Y.
Egli sceglie di soddisfarsi soltanto sul bene X: di conseguenza, sul bene Y potrà esercitare il proprio diritto, in via surrogatoria, il creditore posteriore.
La surrogazione e il limite del bene concesso da un terzo
Tuttavia, questa possibilità è soggetta a un limite fondamentale.
La surrogazione, ai sensi dell’art. 2857, comma 1, c.c., può essere esercitata solo se l’ipoteca gravante sul bene Y è stata concessa dal medesimo debitore.
Essa non può, invece, estendersi ai beni ipotecati da un terzo datore.
La ratio del divieto è chiara: l’ipoteca concessa dal terzo non rappresenta una garanzia “reale” in senso lato, ma una garanzia personale rivolta esclusivamente a tutelare “quel” specifico creditore, e non altri.
Il terzo datore, infatti, ha inteso rafforzare la posizione del creditore (ad esempio, di una banca) per favorire la concessione del finanziamento al debitore, ma lo ha fatto unicamente a beneficio di quel creditore.
Ne consegue che la garanzia prestata dal terzo è destinata a soddisfare solo il credito di grado anteriore e non anche quello di grado posteriore.
Pertanto, se il creditore di primo grado decide di soddisfarsi esclusivamente mediante la vendita del bene X, ossia il bene ipotecato direttamente dal debitore, l’ulteriore ipoteca concessa dal terzo sul bene Y si estingue automaticamente e non permane a beneficio del creditore rimasto insoddisfatto.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
Le ragioni di legittimità del divieto di surrogazione sui beni del terzo datore
Il fondamento normativo: artt. 1203, 1204 e 1197 c.c.
L’estinzione dell’ipoteca concessa dal terzo datore, e, conseguentemente, l’impossibilità per il creditore di grado posteriore di soddisfarsi su di essa, trova fondamento nel principio generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1203 e 1204 c.c.
La surrogazione del creditore può aver luogo anche nei confronti dei terzi garanti (art. 1204 c.c.), ma soltanto a condizione che il creditore che intende surrogarsi abbia previamente pagato il creditore che, in virtù di un’ipoteca di grado anteriore, aveva diritto di essere preferito (art. 1203 c.c.).
Applicando tale principio al caso previsto dall’art. 2856 c.c., se ne ricava che il creditore di grado posteriore potrebbe surrogarsi nell’ipoteca concessa dal terzo datore solo qualora avesse prima soddisfatto direttamente il creditore di grado anteriore.
Tuttavia, in questa fattispecie il pagamento non avviene: il creditore posteriore tenta di insinuarsi nell’ipoteca del terzo senza aver previamente pagato il creditore che lo precede, il quale si è già soddisfatto attraverso la vendita del bene ipotecato dal debitore (bene X) e non di quello gravato dall’ipoteca del terzo (bene Y).
Anche l’art. 1197 c.c. conferma indirettamente questo principio.
La norma, disciplinando la “datio in solutum”, prevede che il debitore, con il consenso del creditore, possa liberarsi dall’obbligazione mediante una prestazione diversa da quella originaria, precisando, al terzo comma, che “in ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi”.
Se la garanzia del terzo si estingue persino quando il creditore resta lo stesso, a maggior ragione essa non può sopravvivere a beneficio di un creditore diverso, come quello di grado posteriore.
Pertanto, nel contesto dell’art. 2856 c.c., la garanzia del terzo datore deve ritenersi estinta una volta soddisfatto il creditore originariamente garantito.
Potrebbero interessarti anche:
- Efficacia del precetto in caso di esecuzione iniziata (e definita): normativa e giurisprudenza utile
- Usucapione e mantenimento dell’ipoteca: tra tutela del credito e certezza giuridica
- Ipoteca e confisca edilizia: le Sezioni Unite chiariscono gli effetti sull’esecuzione forzata
Il ruolo e la funzione liberatoria del terzo datore di ipoteca
Ritenere che il terzo datore debba garantire anche il creditore rimasto insoddisfatto dopo il soddisfacimento del creditore anteriore significherebbe imporre al terzo un onere sproporzionato.
Egli si troverebbe, infatti, a sopportare le conseguenze della “naturale aleatorietà” che caratterizza le procedure esecutive, dove l’insoddisfazione del creditore posteriore è un rischio connaturato al concorso tra più creditori.
Non è dunque legittimo pretendere che il terzo supplisca a tale rischio: la sua ipoteca è stata concessa a garanzia esclusiva di un determinato credito e deve estinguersi una volta che quel credito sia stato soddisfatto.
Tra l’interesse alla “ottimizzazione” dell’ipoteca concessa dal terzo (ossia il suo riutilizzo da parte di creditori successivi) e l’interesse alla definitiva liberazione del terzo garante, il legislatore ha chiaramente ritenuto prevalente quest’ultimo.
È vero che la legge riconosce una tutela espressa al creditore rimasto insoddisfatto in altri ambiti, come in materia societaria.
L’art. 2495 c.c. prevede infatti che, dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possano agire nei confronti dei soci o dei liquidatori.
Tuttavia, il parallelismo con il terzo datore di ipoteca non regge: il socio non è un “terzo” rispetto al debitore, poiché partecipa della stessa soggettività giuridica della società e, quindi, è egli stesso debitore.
Di conseguenza, il richiamo all’art. 2495 c.c. non appare idoneo a giustificare una deroga al principio sancito dall’art. 2856 c.c., che resta ancorato alla logica della liberazione del terzo garante una volta soddisfatto il creditore garantito.
Le ragioni di illegittimità del divieto di surrogazione sui beni del terzo datore
L’art. 2899 c.c. e il divieto di rinuncia dannosa
L’art. 2899 c.c., rubricato “Divieto di rinuncia ad ipoteca a danno di un altro creditore”, disciplina una fattispecie che offre un utile termine di confronto.
Il creditore ipotecario di grado anteriore (Tizio) ha iscritto ipoteca su uno o più immobili, senza che la norma distingua tra ipoteca concessa dal debitore e ipoteca concessa da un terzo datore.
Tizio può dunque aver iscritto ipoteca su un bene X di proprietà del debitore e su un bene Y appartenente a un terzo.
Un altro creditore, Caio, di grado posteriore, ha iscritto ipoteca sul bene X.
Tizio sceglie di soddisfarsi solo su quest’ultimo, poiché la sua vendita basta a coprire il credito. Contestualmente, rinuncia all’ipoteca sul bene Y, costituita dal terzo datore, a favore di Caio, rimasto insoddisfatto.
Tuttavia, prima di Caio esisteva un ulteriore creditore ipotecario, Mevio, di grado posteriore rispetto a Tizio ma anteriore rispetto a Caio.
La rinuncia di Tizio, compiuta a vantaggio di Caio e a scapito di Mevio, è ritenuta illegittima proprio ai sensi dell’art. 2899 c.c., in quanto comporta un indebito vantaggio per un creditore posteriore a danno di un altro di grado intermedio.
Ne consegue che la rinuncia sarebbe stata legittima se Tizio avesse voluto beneficiare Mevio, creditore di grado anteriore rispetto a Caio ma posteriore a sé.
Dal momento che la norma non distingue tra beni ipotecati dal debitore e beni ipotecati da un terzo, si deve ritenere che anche l’ipoteca di quest’ultimo possa essere oggetto di rinuncia e, in via interpretativa, di surrogazione a favore del creditore successivo.
In questo senso, l’art. 2899 c.c. sembra ammettere la possibilità, contrariamente a quanto dispone l’art. 2856 c.c., che un creditore posteriore si soddisfi sui beni concessi in ipoteca da un terzo datore.
Il confronto con l’art. 1276 c.c.: la modifica soggettiva del debitore
Un’altra prospettiva deriva dall’art. 1276 c.c., che disciplina l’estinzione delle garanzie prestate da terzi nel caso di modifica soggettiva del debitore.
Quando, a seguito di delegazione, espromissione o accollo, un nuovo debitore assume l’obbligazione e il creditore libera quello originario, la garanzia prestata dal terzo si estingue.
Se l’obbligazione del nuovo debitore viene poi dichiarata nulla o annullata, l’obbligazione originaria rivive, ma non rivive la garanzia del terzo, poiché quest’ultimo non può rimanere vincolato dopo la liberazione del debitore.
Nel caso dell’art. 2856 c.c., però, il debitore non risulta liberato: il creditore di grado posteriore conserva il proprio credito integro ed esigibile.
Pertanto, non essendo intervenuta alcuna liberazione, si potrebbe ritenere che la garanzia del terzo debba permanere anche a favore del creditore successivo, in contrapposizione alla regola generale che ne prevede l’estinzione.
Questo rafforzerebbe l’idea che il divieto di surrogazione imposto dall’art. 2856 c.c. non sia assoluto, ma suscettibile di interpretazione più flessibile.
Il parallelismo con la disciplina successoria e l’art. 756 c.c.
Un ulteriore argomento a favore dell’illegittimità del divieto può essere rinvenuto nella disciplina delle obbligazioni ereditarie.
In ambito successorio, l’art. 495 c.c. consente ai creditori ereditari rimasti insoddisfatti, dopo la liquidazione dell’attivo ereditario, di agire in regresso contro i legatari, ossia verso soggetti che non sono personalmente tenuti al pagamento dei debiti ereditari.
Il legatario, dunque, pur essendo un “terzo non obbligato”, resta esposto all’azione dei creditori insoddisfatti.
Ciò trova conferma anche nell’art. 756 c.c., che individua proprio nei creditori ipotecari l’unica categoria di soggetti che possono agire nei confronti del legatario.
Questo parallelismo dimostra che il legislatore riconosce, in determinati contesti, la possibilità che un soggetto “terzo” rispetto al debitore sia comunque responsabile nei confronti dei creditori ipotecari.
Per analogia, si può sostenere che anche il terzo datore di ipoteca, pur non essendo debitore principale, possa trovarsi nella posizione di garantire, almeno in via residuale, il creditore ipotecario di grado posteriore.
Considerazioni conclusive
Dalle argomentazioni esposte si ricava che il principio previsto dall’art. 2856 c.c., secondo cui il creditore ipotecario rimasto insoddisfatto non può soddisfarsi sui beni dati in ipoteca da un terzo, non appare del tutto pacifico.
Il coordinamento sistematico con altre disposizioni (artt. 2899, 1276 e 756 c.c.) mostra come il legislatore, in più occasioni, ammetta la possibilità che la garanzia del terzo produca effetti anche in favore di soggetti diversi dal creditore originariamente garantito.
Ne consegue che l’esclusione rigida del creditore posteriore dai beni ipotecati da un terzo datore potrebbe essere rivista in chiave interpretativa, riconoscendo al principio dell’art. 2856 c.c. un valore non assoluto, ma relativo, suscettibile di temperamenti volti a una più equa tutela dei creditori.
Ricapitoliamo insieme
Cosa si intende per creditore ipotecario “perdente”?
È il creditore che non riesce a soddisfare il proprio credito perché, nel concorso, viene preceduto da un altro creditore con ipoteca di grado anteriore. In tale caso, egli può surrogarsi nell’ipoteca del creditore soddisfatto, ma solo nei limiti previsti dall’art. 2856 c.c.
Il creditore rimasto insoddisfatto può rivalersi sui beni concessi in ipoteca da un terzo?
No, salvo casi particolari. L’art. 2857, comma 1, c.c. esclude espressamente la possibilità di esercitare la surrogazione sui beni ipotecati da un terzo datore.
La garanzia del terzo ha infatti natura personale: è prestata in favore di uno specifico creditore e si estingue una volta che quest’ultimo sia stato soddisfatto.
Esistono orientamenti o argomenti che mettono in dubbio questo divieto?
Sì. Parte della dottrina ha osservato che altre norme del codice civile (artt. 2899, 1276 e 756 c.c.) sembrano ammettere, in determinati casi, la possibilità che la garanzia prestata da un terzo produca effetti anche a favore di altri creditori.
Tali disposizioni suggeriscono un’interpretazione meno rigida del principio stabilito dall’art. 2856 c.c.
In che modo l’art. 2899 c.c. incide sulla questione?
L’art. 2899 vieta la rinuncia all’ipoteca a danno di altri creditori e non distingue tra ipoteche del debitore e ipoteche del terzo datore.
Da ciò si desume che, in linea di principio, la rinuncia, e, in estensione, la surrogazione, potrebbe riguardare anche beni concessi in garanzia da un terzo, purché non si arrechi pregiudizio a creditori di grado intermedio.
Perché si richiama anche l’art. 756 c.c.?
Perché in ambito successorio esso consente ai creditori ipotecari di agire contro i legatari, cioè contro soggetti “terzi” rispetto ai debitori ereditari.
Questo esempio mostra come, in determinati contesti, l’ordinamento riconosca la possibilità che un terzo risponda verso i creditori ipotecari, rafforzando l’idea che il divieto dell’art. 2856 c.c. non sia assoluto.
Qual è la ratio complessiva della disciplina?
L’ordinamento mira a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela del creditore rimasto insoddisfatto; dall’altro, la protezione del terzo che ha prestato garanzia per un debito non proprio.
Nell’attuale impostazione, prevale l’interesse del terzo alla definitiva liberazione, ma non mancano argomenti per una lettura più elastica del divieto di surrogazione.