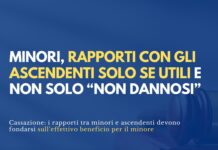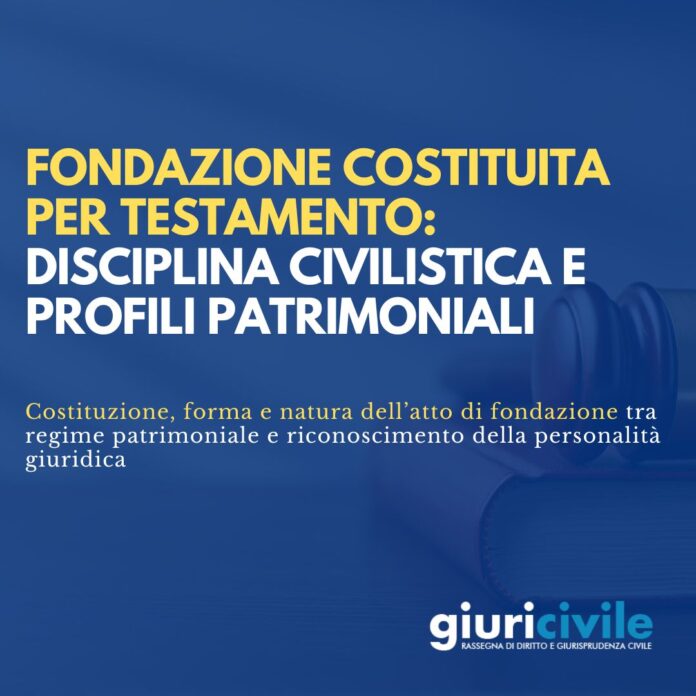
Nel nostro ordinamento, le fondazioni rappresentano uno dei principali modelli organizzativi collettivi attraverso cui un patrimonio viene destinato a finalità di pubblica utilità. Se il codice civile prevede la possibilità di costituirle anche per testamento, non mancano questioni aperte circa la forma, la struttura dell’atto e la natura giuridica dell’attribuzione. L’analisi del regime patrimoniale delle fondazioni consente di cogliere le principali peculiarità che distinguono questi enti dalle associazioni, anche alla luce del riconoscimento della personalità giuridica.
Consiglio: il “Manuale pratico per la successione testamentaria e le donazioni”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria.

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Leggi descrizione
Riccardo Mazzon, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €

Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni
Il volume offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria e donazioni.
La presente edizione è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, tra cui il principio della ridotta entità del conguaglio per la divisione ereditaria (Cass. n. 1686/2025); il valore della cartella clinica nella decisione sulla capacità del testatore (Cass. 1632/2025) e la valutazione della CTU in riferimento ai cd. solchi ciechi dello scritto (Cass. 1012/2025).
Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite SEZIONI DI SINTESI e SCHEMI SINOTTICI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.
Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante. La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.
Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
La fondazione come formazione sociale costituzionalmente garantita
L’art. 2 della Costituzione statuisce che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tra le formazioni sociali rientrano le associazioni, le fondazioni e i comitati, enti collettivi ai quali l’ordinamento riconosce personalità giuridica, ossia capacità d’agire di diritto privato, seppur declinando tale riconoscimento in virtù della loro peculiare natura. Il codice civile, al titolo secondo, rubricato “delle persone giuridiche”, disciplina la materia, regolamentando le diverse fasi di vita dell’ente, dalla costituzione all’estinzione.
Atto costitutivo e struttura della fondazione
Secondo l’art. 14 c.c., le fondazioni devono essere costituite per atto pubblico, con possibilità alternativa di disposizione testamentaria. Il d.p.r. 361/2000 ne definisce e completa il regime patrimoniale. L’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 15 c.c., è un atto unilaterale non recettizio, anche in presenza di più fondatori. Viceversa, l’atto costitutivo dell’associazione è un contratto. Per la sua efficacia, l’atto deve contenere, come stabilito dall’art. 16 c.c., elementi essenziali quali la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Peraltro, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.p.r. 361/2000, il patrimonio della fondazione deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.
Differenze funzionali tra fondazioni e associazioni
Fondazioni e associazioni condividono la natura di enti collettivi, ma si differenziano per struttura e dinamiche gestionali. Il fondatore, una volta destinati i beni allo scopo si spoglia di questi e non partecipa alla loro amministrazione, a differenza di quanto avviene nell’associazione dove l’associato partecipa sempre alla gestione dell’ente se non direttamente, quanto meno indirettamente in sede assembleare.
Nella fondazione, all’opposto, l’amministrazione è affidata a soggetti distinti dal fondatore, che si trovano in posizione diversa rispetto ai membri di un’associazione. Nell’associazione, infatti, gli associati sono liberi di determinare le scelte organizzative in virtù del principio dell’autonomia negoziale. Nella fondazione gli amministratori sono meri “organi serventi”, adempiono ad un ufficio, essendo vincolati al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore.
Un ulteriore elemento di differenziazione riguarda la posizione degli amministratori dell’associazione rispetto a quelli della fondazione. L’assemblea degli associati, infatti, deve pronunciarsi sui criteri di gestione adottati dagli amministratori con l’approvazione o disapprovazione del bilancio; deve confermare o sostituire periodicamente gli amministratori; esprimere direttive di carattere generale sul modo di amministrare in sede di approvazione del bilancio annuale o di nomina degli amministratori.
D’altro canto, gli amministratori della fondazione, una volta investiti dell’ufficio, sono liberi nella determinazione dei criteri di gestione, non sono sottoposti al controllo né da parte dell’assemblea, né da parte dell’autorità governativa, se non nei limiti del solo controllo di legittimità.
L’atto di fondazione tra disposizione patrimoniale e organizzazione
L’atto di fondazione è l’atto giuridico unilaterale mediante il quale il fondatore destina un patrimonio ad uno scopo determinato, predisponendo, altresì, la struttura organizzativa idonea a realizzarlo. Esso è, in primo luogo, un atto di disposizione patrimoniale, attraverso il quale il fondatore destina un patrimonio al conseguimento di uno scopo; in secondo luogo, è un atto di organizzazione che determina, attraverso una struttura organizzativa, le modalità di attuazione del suddetto scopo.
Il rapporto tra i due elementi contenutistici può diversamente articolarsi a seconda che prevalga l’elemento patrimoniale, come nel caso delle fondazioni erogatrici, o quello organizzativo, come nelle fondazioni culturali.
La costituzione testamentaria: forma e problemi interpretativi
L’art. 14, co. 2, c.c. ammette la costituzione della fondazione anche per testamento. Ciò pone il primo problema interpretativo: è sufficiente il testamento olografo o occorre la forma del testamento pubblico?
La dottrina oggi prevalente ritiene ammissibile che la costituzione di una fondazione possa avvenire tramite testamento olografo: il verbale di pubblicazione del testamento olografo, infatti, in forza della sua natura di atto pubblico, è considerato titolo legittimante la richiesta di iscrizione nel registro delle persone giuridiche della fondazione.
L’atto testamentario tra fondazione e dotazione
Altro aspetto rilevante riguarda la natura giuridica della disposizione testamentaria attraverso la quale si costituisce una fondazione.
- In forza di un primo orientamento dottrinale, l’atto di dotazione non avrebbe un’autonoma natura causale, ma costituirebbe elemento integrativo dell’unico negozio di fondazione, considerato come negozio tipico, unilaterale e gratuito.
- Secondo un altro orientamento, invece, sarebbe necessario distinguere tra negozio di fondazione e atto di dotazione: col negozio di fondazione si costituisce l’ente, esso sarebbe una disposizione non patrimoniale ex art. 587, secondo comma, cc.; l’atto di dotazione, invece, rappresenterebbe l’istituzione di erede o di legato.
Verso una nuova categoria negoziale?
Una parte consistente della dottrina ritiene superata la rigida dicotomia tra atto di fondazione e atto di dotazione: bisognerebbe, infatti, abbandonare il tradizionale postulato secondo il quale il testamento non possa contenere altri atti di disposizione patrimoniale che non siano l’istituzione di erede o il legato e che gli unici atti di liberalità tra vivi siano quelli ricompresi nello schema della donazione.
Viceversa, tale tesi riconosce l’esistenza di un’ulteriore figura negoziale, avente ad oggetto una disposizione patrimoniale che prende il nome di atto di fondazione.
Alle medesime conclusioni è giunta la giurisprudenza più recente, secondo cui, l’atto di fondazione avrebbe in comune con il legato, l’istituzione di erede e la donazione, la caratteristica di essere un atto di liberalità: le norme che regolano tali figure troveranno applicazione anche per l’atto di fondazione.
Potrebbero interessarti anche:
-
Irreperibilità del testamento olografo: equiparazione alla distruzione e presunzione di revoca
-
Fondo fiduciario vivente: cos’è, come funziona e quando è pignorabile
-
Validità del testamento pubblico: è sufficiente una dichiarazione a monosillabi?
-
Obbligazioni fiscali delle associazioni non riconosciute: responsabilità del presidente
Conclusioni
La fondazione costituita per testamento rappresenta un istituto duttile ma complesso, che impone una lettura sistematica delle norme civilistiche e delle fonti costituzionali. La dottrina e la giurisprudenza più recenti convergono nel riconoscere all’atto di fondazione il carattere di liberalità, analogo a legati e donazioni, ma dotato di peculiarità proprie. Ciò apre alla possibilità di una categoria autonoma e ne evidenzia l’importanza nella costruzione di assetti patrimoniali destinati a scopi di utilità sociale.