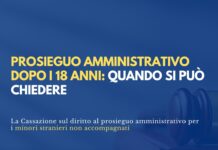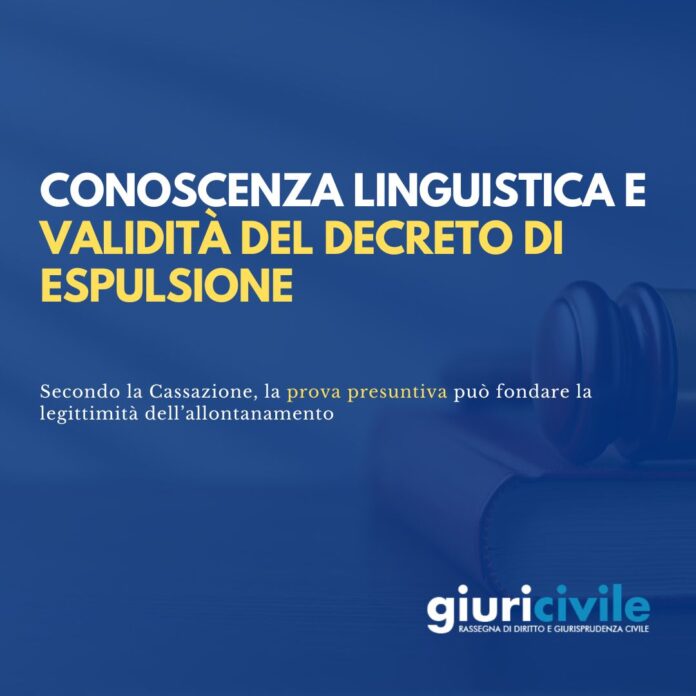
L’ordinanza n. 28132/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) interviene su due questioni di rilievo in ambito immigrazione: l’esatta portata del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria Penale ai fini dell’espulsione amministrativa (art. 13, comma 3, T.U.I.) nonché la verifica del diritto di difesa dello straniero con riferimento alla lingua di redazione del decreto di allontanamento (art. 13, comma 7, T.U.I.). Il collegio romano di legittimità ha ribadito l’autonomia dell’espulsione prefettizia rispetto al procedimento penale, al contempo riaffermando il principio della prova presuntiva della conoscenza linguistica basata su indizi gravi, precisi e concordanti.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.
Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).
Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.
Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Leggi descrizione
Paolo Morozzo della Rocca, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €

Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.
Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).
Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.
Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Due punti critici
La decisione della Prima Sezione Civile afferisce al contenzioso in materia di espulsione amministrativa di cittadini stranieri. Oggetto del giudizio è il ricorso interposto da un cittadino albanese contro la sentenza del Giudice di Pace capitolino che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione, notificato in lingua italiana e inglese.
I motivi di ricorso per cassazione hanno riguardato, peraltro, profili di legittimità:
- anzitutto, la presunta violazione dell’art. 13, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.) per difetto del nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria Penale;
- poi, la violazione dell’art. 13, comma 7, T.U.I. nonché dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 394/99, in ordine alla mancata traduzione dell’atto nella lingua madre (albanese), con conseguente lesione del diritto di difesa.
Le argomentazioni della Corte di legittimità, pur dichiarando inammissibili ambedue i motivi, offrono argomenti di riflessione per la prassi e per la dottrina, confermando gli orientamenti giurisprudenziali.
Contenuto del Nulla Osta (art. 13, comma 3, T.U.I.)
Attraverso la formulazione del primo motivo di ricorso, il cittadino albanese ha lamentato che il Questore avesse omesso di richiedere il necessario nulla osta all’Autorità Giudiziaria in pendenza di un procedimento penale a carico del medesimo. L’obbligo di acquisizione del nulla osta, contemplato dall’art. 13, comma 3, T.U.I. per lo straniero sottoposto a procedimento penale e non in stato di custodia cautelare in carcere, viene letto dal ricorrente come fondamentale per evitare che l’espulsione interferisca con le esigenze processuali.
La Corte di Cassazione dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato l’atto specifico in cui tale eccezione era stata sollevata in primo grado. Tale statuizione riafferma il principio di autosufficienza del ricorso, precludendo al giudice di legittimità la prospettazione di questioni nuove non comprese nel thema decidendum del giudizio di merito.
Tuttavia, la Corte non si limita al mero rilievo processuale, bensì affronta la questione nel merito, giudicandola in ogni caso irrilevante nella vicenda posta sotto la sua lente. In tal modo viene ribadita la completa autonomia applicativa dell’espulsione prefettizia rispetto al procedimento penale e alle misure alternative alla detenzione carceraria.
La giurisprudenza di legittimità (viene richiamata Cass. n. 35686/2023) ha già chiarito che l’espulsione amministrativa opera su un piano differente e distinto dalle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria. L’ordine di sospensione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., ad esempio, lascia intatto il potere prefettizio.
Natura eccezionale e limiti del nulla osta
Il nulla osta previsto dall’art. 13, comma 3, T.U.I. costituisce una salvaguardia procedurale di natura eccezionale, e la sua negazione da parte dell’Autorità Giudiziaria risulta limitata alla sola presenza di “inderogabili esigenze processuali”.
Esigenze siffatte, come costantemente interpretato, sono valutate unicamente in funzione dell’accertamento della responsabilità di terzi e dell’interesse della persona offesa, e non a tutela del diritto di difesa del medesimo straniero sottoposto al provvedimento di espulsione.
Il rigetto di tale motivo di ricorso conferma, quindi, la prevalenza dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’espulsione in presenza dei presupposti legali, pure a fronte di pendenze penali non detentive. Tale principio garantisce che l’instaurazione di un procedimento penale non si trasformi in una strategia per eludere l’allontanamento dal territorio nazionale.
Potrebbero interessarti anche:
- Protezione internazionale e sicurezza nazionale: revoca dello status di rifugiato
-
Limiti del sindacato giurisdizionale sul Regolamento Dublino III (Sezioni Unite)
-
Trattenimento dei migranti e responsabilità civile dello Stato: le Sezioni Unite sul Caso Diciotti
Lingua madre, lingua Veicolare e onere probatorio (art. 13, co. 7, T.U.I.)
La questione sollevata dal ricorrente
Il secondo motivo di ricorso ha riguardato la validità del decreto di espulsione in ragione della mancata traduzione in lingua albanese, lingua madre del ricorrente. La difesa ha sostenuto che la legge consentisse la traduzione in una delle lingue cosiddette “veicolari” (inglese, francese, spagnolo) solo “ove non sia possibile quella in una lingua nota all’interessato”.
L’impossibilità, richiamando precedente giurisprudenza (Cass. n. 9/2002), è configurabile solamente in ipotesi eccezionali, quali la mancata identificazione del paese di provenienza o la rarità della lingua, condizioni non sussistenti per la lingua albanese. La mancata traduzione, secondo l’assunto, avrebbe leso il diritto di difesa.
La decisione del Giudice di Pace
Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione rilevando che l’indicazione del testo in italiano e inglese non risultava incomprensibile, poiché l’opponente aveva soggiornato in Italia per circa tre anni, era stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo e aveva dichiarato di conoscere la lingua inglese. Aveva altresì potuto avvalersi di un legale per svolgere le proprie difese.
La prova presuntiva della conoscenza linguistica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile anche questo motivo, ritenendolo diretto a censurare impropriamente un accertamento di fatto del Giudice di Pace, il quale era stato adeguatamente motivato. La Suprema Corte riafferma il principio, già espresso (Cass. n. 4636/2019) secondo cui, in ambito di procedimento di espulsione amministrativa, la prova presuntiva della conoscenza della lingua italiana (ovvero di altra lingua veicolare in cui l’atto è stato tradotto) può essere desunta dal giudice di merito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Nella vicenda esaminata tali indizi sono stati individuati:
- nella permanenza triennale del ricorrente in Italia,
- nella pregressa titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- e nella dichiarazione di conoscenza della lingua inglese.
L’onere probatorio che grava sulla Pubblica Amministrazione (dimostrare che l’atto abbia raggiunto il suo scopo in una lingua comprensibile) può, quindi, essere assolto tramite un’adeguata valutazione presuntiva.
Bilanciamento tra celerità e tutela del diritto di difesa
La Cassazione non entra nel merito della concreta reperibilità di un traduttore di albanese, bensì si concentra sulla sufficienza della prova fornita dal primo giudice in merito alla conoscenza di una lingua (l’inglese, nella fattispecie) in cui l’atto era stato redatto in aggiunta all’italiano.
Tale orientamento bilancia l’esigenza di celerità del procedimento espulsivo con la tutela del diritto di difesa, subordinando l’eventuale nullità del provvedimento non alla mera omissione formale della traduzione in lingua madre, bensì all’accertamento concreto dell’impedimento alla comprensione e all’esercizio del diritto di ricorso.
Impostazione giurisprudenziale confermata
L’ordinanza in disamina costituisce un’importante conferma di due pilastri della giurisprudenza in materia di immigrazione:
- sull’art. 13, comma 3, T.U.I., si ribadisce l’autonomia funzionale dell’espulsione amministrativa, circoscrivendo il potere di intervento dell’Autorità Giudiziaria Penale (tramite il nulla osta) alla sola salvaguardia di inderogabili esigenze processuali estranee alla posizione del singolo espellendo. Tale interpretazione previene strumentalizzazioni della pendenza penale per paralizzare l’esecuzione del provvedimento di allontanamento;
- sull’art. 13, comma 7, T.U.I., si rafforza il ruolo del giudice di merito (Giudice di Pace) nell’accertamento, pure per via presuntiva, della conoscenza linguistica dello straniero. Tale accertamento, ove adeguatamente motivato sulla base di elementi concreti (durata del soggiorno, precedenti titoli di residenza, conoscenza di lingue veicolari) risulta tendenzialmente incensurabile in sede di legittimità. La validità dell’atto espulsivo viene in tal modo correlata all’effettivo raggiungimento dello scopo informativo e difensivo, piuttosto che al mero rispetto formale della traduzione in lingua madre.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l’effetto, non rappresenta un mero tecnicismo processuale, bensì il sigillo alla correttezza di un’ermeneutica che bilancia le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, inerenti alla gestione dei flussi migratori e all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi, con la tutela sostanziale del diritto di difesa dello straniero, ancorata a indizi di fatto di inequivoca significatività.