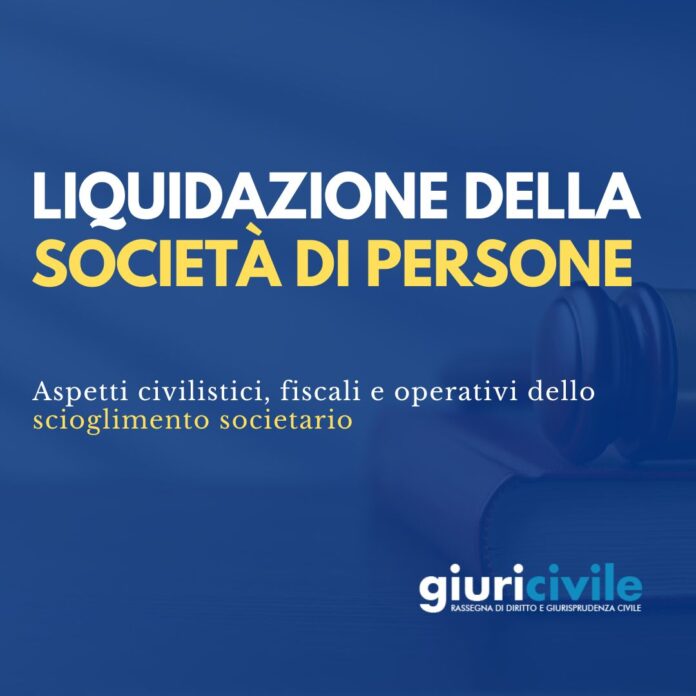
Lo scioglimento di una società non costituisce vicenda del contratto di società. Esso non è, dunque, un fenomeno regolabile attraverso l’istituto della risoluzione del contratto. Il contratto, infatti, una volta risolto è estinto; resta certo quale fatto storico, ma non produce più alcun effetto. Di contro, lo scioglimento della società, interessa la società in quanto ente: lo scioglimento introduce la società in una nuova fase, di durata variabile, non irreversibile, in cui la società è idealmente orientata alla fine dell’operatività, alla dismissione del patrimonio e, soprattutto, al soddisfacimento dei creditori sociali.
Di seguito si esaminerà la fase della liquidazione (afferente alle società di persone), quale atto propedeutico alla estinzione della società in quanto ente, con conseguente cancellazione dal RI, passando in rassegna gli specifici profili fiscali che contraddistinguono la vicenda. Per un approfondimento sulle soluzioni liquidatorie nei casi di crisi d’impresa, consigliamo il volume “Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Scioglimento della società di persone
Lo scioglimento di una società avviene mediante un procedimento che si articola generalmente in tre fasi:
- in primo luogo, si verifica la causa di scioglimento della società;
- segue la fase di liquidazione, in cui la società continua ad esistere. Il suo fine, tuttavia, non si indentifica più nella realizzazione dell’oggetto sociale, diventando il soddisfacimento dei creditori sociali e l’eventuale distribuzione dell’attivo rimanente. In questa fase, la legge prevede che la società sia gestita da liquidatori, salva la facoltà dei soci di eseguire la liquidazione con modalità differenti, ovvero ommettere del tutto, in specifici casi, il ricorso a questa fase;
- infine, si procede alla cancellazione della società del RI, quale atto formale/funzionale a suggellare l’estinzione della società, la quale, da quel momento, non esiste più in quanto soggetto giuridico.
Se non è diversamente previsto nell’atto costitutivo, la fase di scioglimento e quella di liquidazione sono regolate dalla disciplina della società semplice (ex artt.2272- 2283 c.c.), fatte salve le peculiarità previste per le s.n.c. (ex artt.2308- 2312 c.c.).
Cause di scioglimento
La società si scioglie per cause previste dalla legge ed eventualmente dall’atto costitutivo.
Tra le cause espressamente disciplinate dal Legislatore vi sono:
- conseguimento dell’oggetto sociale;
- sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale;
- decorso del termine previsto nell’atto costitutivo;
- delibera dei soci di scioglimento anticipato;
- mancanza della pluralità dei soci protratta per oltre mesi 6;
- cause previste nell’atto costitutivo;
- sentenza che dichiara la nullità della società;
- apertura della procedura di liquidazione giudiziale (ex art. 2308 c.c. come sostituito dall’art. 382 CCI novellato dal D.lgs. n. 147/2020);
- apertura della procedura di liquidazione controllata (ex art. 2272 c.c. introdotto dall’art. 382 CCI come modificato dal D.lgs. n. 147/2020);
- (solo per le s.a.s.) il venir meno di una intera categoria di soci (ex art. 2323 c.c.).
Liquidazione convenzionale
Come anticipato, lo scioglimento di una società non determina l’estinzione della medesima (che avviene per mezzo della cancellazione della società dal RI) ma l’apertura della fase di liquidazione, durante la quale lo scopo della società muta da “lucrativo” a “liquidatorio” (Cass. n.501/2016).
In sostanza, in fase di liquidazione, scopo della società non è più l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili tra i soci (ex art. 2247 c.c.), ma diventa la definizione dei rapporti giuridici sorti nella fase precedente mediante la realizzazione dell’attivo patrimoniale (monetarizzazione dei beni in natura e riscossione dei crediti esigibili) e l’eventuale distribuzione ai soci di ciò che residui, previo pagamento delle passività sociali.
I soci possono liberamente determinare le modalità con cui procedere alla liquidazione della società sia attraverso un’apposita previsione nell’atto costitutivo (ex art. 2275 c.c.) sia con successivo accordo, che può intervenire anche nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento. In ogni caso, la decisione avente ad oggetto la procedura di liquidazione deve essere assunta all’unanimità.
Nell’ambito delle modalità facoltative di attuazione della liquidazione, i soci, possono:
- decidere chi può essere nominato liquidatore, il numero dei liquidatori, i poteri conferiti e le relative modalità di nomina e compenso;
- derogare alla disciplina legale omettendo di nominare i liquidatori e provvedendo essi stessi alla realizzazione dell’attivo, all’estinzione delle passività e al riparto dell’eventuale residuo;
- procedere alla sistemazione dei rapporti pendenti verso i terzi attraverso il ricorso ad istituti pattizi predeterminati;
- dare atto, contestualmente alla delibera di scioglimento volontario, dell’insussistenza di debiti sociali;
- pervenire giudizialmente all’estinzione dell’ente previa definizione dei rapporti pregressi.
Infine, se i soci procedono allo scioglimento volontario della società, senza ricorrere alla liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal RI solo in presenza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da cui risultino:
- l’intervenuta causa di scioglimento;
- la volontà di tutti i soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare dalla fase di liquidazione.
Liquidazione legale
Se i soci non hanno diversamente stabilito nell’atto costitutivo, in caso di disaccordo sulle modalità di liquidazione, ovvero a seguito dell’insorgenza di contestazioni sulla sussistenza di asserite attività/passività da liquidare, si rende obbligatorio seguire la procedura legale di liquidazione di cui all’art. 2275 c.c.
L’attività è gestita dai liquidatori ed il loro scopo si sostanzia nella realizzazione dell’attivo societario per soddisfare i creditori sociali; e, se residua un attivo, nella ripartizione dello stesso tra i soci.
Normalmente i liquidatori sono nominati dai soci o, in determinate situazioni, dall’autorità giudiziaria. L’incarico è generalmente conferito agli amministratori o ai soci della società, ma può essere affidato anche a soggetti estranei al complesso societario.
Se l’atto costitutivo non indica i liquidatori né determina le modalità della loro nomina, vi provvedono i soci all’unanimità contestualmente alla decisione di sciogliere la società, ovvero una volta accertata la causa di scioglimento.
Se non viene raggiunta l’unanimità, o la maggioranza richiesta dall’atto costitutivo, provvede l’autorità giudiziaria.
Nomina, revoca e durata dell’incarico dei liquidatori
I liquidatori entrano in carica dal momento dell’accettazione della nomina, prendendo così il posto degli amministratori che decadono. Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, i liquidatori devono iscrivere presso il RI il provvedimento di nomina (art. 2309 c.c.). Se l’accettazione è contestuale alla nomina, l’iscrizione al RI avviene con l’iscrizione dell’atto di scioglimento.
Dal momento dell’iscrizione, la nomina dei liquidatori è opponibile ai terzi.
I liquidatori di società di persone (da chiunque siano nominati) possono essere revocati in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa. In ogni caso, la revoca diventa efficace dal momento in cui i soci nominano un nuovo liquidatore.
Infine, il liquidatore rimane in carica per tutto il periodo necessario a concludere le operazioni di liquidazione e fino al momento della cancellazione della società dal RI, salvo che si verifichi un’ipotesi di cessazione.
Attività operative della liquidazione
Ancora, dopo la nomina e la redazione dell’inventario, il procedimento di liquidazione entra nella fase operativa, nella quale i liquidatori sono chiamati a compiere gli atti necessari per la definizione dei rapporti giuridici pendenti tra la società e i terzi.
In particolare, la liquidazione si compone di tre attività strettamente connesse, ossia:
- la conversione delle poste patrimoniali attive in denaro;
- la destinazione del ricavato al pagamento dei debiti sociali;
- la ripartizione dell’eventuale residuo attivo tra i soci.
Bilancio finale, piano di riparto e cancellazione
Infine, completata l’attività di liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione entro i termini di legge e, se dalla liquidazione è residuato un attivo, anche il piano di riparto (tenendo conto delle rispettive quote di partecipazione alla società dei soci).
Entrambi i documenti devono essere comunicati ai soci per la loro approvazione.
Da ultimo, dopo la chiusura della liquidazione, si procede alla cancellazione della società dal RI.
Nel dettaglio, legittimati a chiedere la cancellazione della società sono:
- in caso di scioglimento con liquidazione: i liquidatori, decorsi 2 mesi dalla comunicazione ai soci del piano di riparto;
- in caso di scioglimento senza liquidazione: i soci – amministratori, contestualmente all’iscrizione al RI dell’atto di scioglimento. A tal fine, essi devono predisporre il S3 e trasmetterlo al RI mediante ComUnica. Parimenti, e con le stesse modalità, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’attività ai fini IVA. L’ufficio dispone la cancellazione definitiva dell’impresa dal RI entro 5 giorni dal rilascio della ricevuta della ComUnica. Essi devono altresì depositare presso il soggetto designato dalla maggioranza dei soci documenti e scritture contabili che non spettano ai singoli soci, il quale è chiamato a conservarli per 10 anni a decorrere dalla cancellazione della società (ex art. 2312 c.c.).
Effetti dell’estinzione della società
Dall’estinzione derivano i seguenti effetti:
- i liquidatori (o i soci amministratori in caso di liquidazione non formale) perdono il potere di rappresentanza della società estinta;
- cessa di esistere un patrimonio sociale distinto dal patrimonio personale dei soci, su cui i creditori sociali potranno soddisfarsi imputando eventuali attività non liquidate.
L’estinzione della società comporta l’inesistenza della società cancellata dal RI e la perdita di ogni legittimazione sostanziale e processuale.
Regime di tassazione
Per comprendere la disciplina fiscale di riferimento è opportuno distinguere almeno cinque aree d’indagine.
Periodo ante-liquidazione
Periodo ante-liquidazione (ex 182 c. 1 e 2 Dpr n. 917/1986). Il reddito d’impresa del periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico o, se si tratta di soggetti che adottano la contabilità semplificata, in base alle relative disposizioni di cui all’art. 66 Dpr n. 917/1986.
Il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, devono presentare, segnatamente: la dichiarazione dei redditi e IRAP, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento; quella dei sostituti d’imposta nei termini ordinari, in nome e per conto del sostituto, relativamente al periodo dell’anno in cui lo stesso ha effettivamente operato. L’IRAP a saldo scaturente dalla relativa dichiarazione va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione; mentre i soci pagano l’IRPEF, derivante dall’attribuzione del reddito del periodo, secondo le scadenze ordinarie.
Periodo di liquidazione
Periodo di liquidazione. Se la liquidazione si chiude nello stesso esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito d’impresa prodotto nel periodo di liquidazione è determinato e tassato, secondo le regole ordinarie, ossia in via definitiva. Se si protrae per più esercizi, l’IRAP si applica sempre in via definitiva; viceversa, l’IRPEF a carico dell’imprenditore individuale (Ris. AE 4 febbraio 2009 n. 31/E) o dei soci-persone fisiche, si applica in via provvisoria o definitiva, a seconda della durata della liquidazione.
In particolare, se la liquidazione non supera i tre esercizi:
- per ogni esercizio intermedio l’IRPEF è calcolata in via provvisoria e quindi all’atto della chiusura si procede al calcolo definitivo e all’evidenziazione dell’eventuale conguaglio;
- se ne ricorrono i presupposti, si applica la tassazione separata.
Di contro, se la liquidazione supera i tre esercizi, ovvero non viene presentato il bilancio finale di liquidazione:
- la tassazione degli esercizi intermedi è definitiva e non si può fare il conguaglio;
- si ha la decadenza dalla tassazione separata eventualmente applicata negli esercizi precedenti.
Tassazione separata
Tassazione separata (ex art. 17 Dpr n. 917/1986). La tassazione separata si applica alla quota di reddito imputato ai soci, persone fisiche, a condizione che alla data di inizio della liquidazione l’impresa sia esercitata o la società costituita da più di cinque anni (non rileva la data di assunzione della partecipazione da parte del socio). Nello specifico, essa rappresenta il regime tradizionale per i soci (non imprenditori) delle società di persone, salva l’opzione per la tassazione ordinaria; mentre, i soci che conseguono il reddito in regime d’impresa devono esercitare l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Se la liquidazione supera i tre esercizi oppure non viene presentato il bilancio finale di liquidazione, si ha la decadenza con effetto retroattivo dal beneficio della tassazione separata. In tal caso, i redditi attribuiti in ciascun esercizio si considerano definitivi e concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente per i vari periodi di competenza. Pertanto si deve procedere alla riliquidazione dell’imposta secondo il criterio ordinario, anche per i redditi già tassati separatamente.
Liquidazione chiusa in perdita
Liquidazione chiusa in perdita (ex art. 182 c. 2 Dpr n. 917/1986) Se la liquidazione si chiude in perdita, questa può essere attribuita ai soci. A tal fine, si ritiene che ci si debba riferire all’intero bilancio di liquidazione, anche se di durata superiore a tre esercizi. In pratica, nei periodi intermedi, prima del conguaglio finale, l’eventuale insorgenza di perdite di esercizio non permette alcuna attribuzione o compensazione. Occorre attendere la chiusura della liquidazione per verificare se è presente una perdita complessiva, che può verificarsi sia alternandosi, negli esercizi intermedi, utili e perdite, sia presentandosi una successione di perdite.
Chiusura della liquidazione e profili impositivi
Chiusura. In caso di distribuzione del residuo attivo tra i soci, il costo delle partecipazioni va ulteriormente aumentato/diminuito, rispettivamente, degli utili e delle perdite imputati per trasparenza. Se i soci sono persone fisiche si applica la tassazione separata, fatta salva la scelta del regime ordinario. Le riserve, essendo costituite con utili già tassati, sono distribuite ai soci liberamente. Infine, l’unica eccezione attiene alla distribuzione di fondi in sospensione d’imposta. Da ultimo l’IRAP, determinata dalla società di persone, va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione secondo quanto previsto dall’ 17 c.1 Dpr n. 435/2001.
Conclusioni
La disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di persone si configura come un sistema articolato, nel quale confluiscono regole civilistiche, tributarie e procedurali che concorrono alla definizione ordinata della cessazione dell’attività societaria. Il momento dello scioglimento, lungi dal determinare l’immediata estinzione del soggetto giuridico, inaugura una fase giuridicamente autonoma in cui prevale la funzione liquidatoria, a tutela dei creditori e dell’equilibrio patrimoniale interno alla compagine sociale.
La possibilità per i soci di disciplinare convenzionalmente modalità e tempi della liquidazione, anche derogando al modello legale, evidenzia la flessibilità dell’istituto, pur nel rispetto dei presidi minimi di trasparenza e responsabilità. Non meno rilevante è l’apparato fiscale che accompagna ciascuna fase della liquidazione, con effetti che si riverberano sulla determinazione dei redditi imponibili, sulla corretta imputazione ai soci e sulle opzioni disponibili tra regime ordinario e tassazione separata.
In definitiva, la corretta gestione della fase liquidatoria richiede un approccio sistemico e multidisciplinare, capace di coniugare le esigenze di certezza giuridica, economicità operativa e regolarità fiscale, al fine di giungere a una cancellazione dal Registro delle Imprese che sia non solo formalmente efficace, ma anche sostanzialmente compiuta sotto il profilo degli effetti giuridici e patrimoniali.













