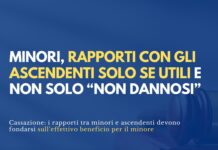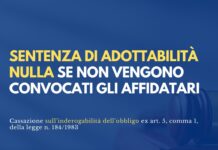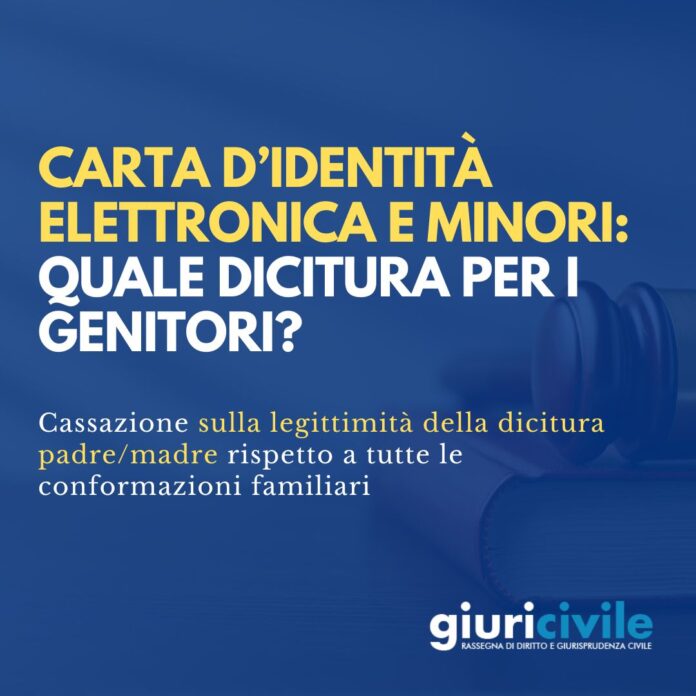
Dopo aver confermato la disapplicazione del D.M. 31/1/2019 disposta dal Tribunale e avallata dalla Corte distrettuale, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 9216/2025) ha ribadito che la sussistenza di istituti come l’adozione in casi particolari può dar luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso (l’uno naturale, l’altro adottivo), pertanto le diciture previste dai modelli ministeriali (padre/madre) per la CIE intestata a un minore non sono rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Il d.m. 31 gennaio 2019
Il Decreto del Ministero dell’Interno 31 gennaio 2019 titolato “Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica” (G.U. Serie Generale n. 79/2019), oltre a stabilire che “La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente”, aveva disposto che le parole “cognome e nome dei genitori” fossero sostituite da “cognome e nome del padre e della madre”.
L’adozione in casi particolari
Il Tribunale, adito da una coppia di donne, ordinava al Viminale la disapplicazione per illegittimità del d.m. 31 gennaio 2019, nonché di indicare sulla carta d’identità elettronica del minore, adottato da entrambe, la dicitura “genitore” o, in alternativa, “padre/genitore madre/genitore” in corrispondenza dei nomi delle due donne.

I nuovi procedimenti di famiglia
L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose.
Ida Grimaldi,
Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.
Leggi descrizione
Ida Grimaldi, 2025, Maggioli Editore
24.00 €
22.80 €

I nuovi procedimenti di famiglia
L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose.
Ida Grimaldi,
Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.
In particolare, l’adozione del minore, avvenuta grazie alla fattispecie giuridica “in casi particolari”, aveva prodotto effetti pieni, facendo nascere relazioni di parentela coi familiari della donna adottante, cosicché non era possibile stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identità potessero essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri da cui quei dati erano estratti.
L’esistenza di istituti come l’adozione in casi particolari, argomenta la Cassazione, può infatti dar luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso (l’uno naturale, l’altro adottivo), comprovando che le diciture previste dai modelli ministeriali (padre/madre) non risultano rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione.
Il Viminale, quindi, doveva indicare sulla carta d’identità elettronica del minore, in corrispondenza dei nomi di ambedue le donne, la qualità di “genitore” o altra dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile.
Potrebbe interessarti anche:
Le difese del Viminale
Tra gli altri motivi dedotti dal Viminale innanzi al giudice di legittimità, ha sostenuto che la disapplicazione del decreto ministeriale compiuta dai giudici distrettuali violasse il concetto di bigenitorialità in vigore nel sistema giuridico, collidendo coi principi di ordine pubblico.
Secondo il Ministero, il legislatore non avrebbe potuto ammettere la dicitura “genitori” in luogo di quella di “padre” e “madre” nella disciplina della carta di identità elettronica, poiché, altrimenti, avrebbe creato atti di stato civile a carattere eccezionale, non conformi a quelli prodotti sino ad allora in attuazione della normativa.
Il Viminale al contempo aveva osservato che il diritto all’identità personale del minore nel caso di specie non era stato in alcun modo pregiudicato dalla dicitura “madre” e “padre” riportata sulla carta d’identità elettronica, dato che la medesima non necessitava dell’indicazione dei nomi dei genitori del minore per poter espletare la funzione di identificazione.
La natura giuridica del d.m.
Nel dichiarare inammissibile il rilievo, il collegio ha evidenziato che la Corte d’appello aveva già condiviso le deduzioni difensive delle due donne appellate anche nella parte in cui rappresentavano che il decreto ministeriale (di contenuto tecnico-operativo, essendo volto a dettare mere specifiche tecniche su come realizzare la carta identità elettronica) era un “atto privo di carattere normativo” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 215/2020) e men che meno un atto del legislatore nazionale. Ciò ha reso inammissibile la doglianza, ma anche a voler riconoscere carattere normativo al d.m., ha argomentato il collegio, la censura non meriterebbe di essere accolta.
In dettaglio, la giurisprudenza (Cass. 22179/2022, Cass., Sez. U., 38162/2022, Cass. 4448/2024) ha riconosciuto, rispetto a una coppia omoaffettiva femminile, che l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983, si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (n. 79/2022). Se così è, allora la Corte d’appello, innanzi alla sentenza di adozione che riconosceva alla partner della madre naturale la condizione di madre adottiva, non poteva che addivenire alla disapplicazione del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019.
Il TULPS
L’art. 3, comma 5, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.) stabilisce che “la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati”.
Il d.m. viola il diritto del secondo genitore che “non corrisponde” al genere del modello ministeriale
Ulteriormente, il collegio ha osservato che il tenore di un decreto ministeriale che prevedeva che la parola “genitori” fosse sostituita da “madre e padre” sul verso del documento di identità, non solo contrastava con lo specifico contenuto della disposizione di legge, che si riferisce ai “genitori” quali soggetti richiedenti il rilascio della carta d’identità e presenti assieme al minore durante il viaggio all’estero, bensì astringeva pure il diritto di ogni genitore di veder riportata sulla carta di identità del figlio minore il proprio nome, poiché consentiva un’indicazione appropriata solamente per una delle due madri, imponendo all’altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità (“padre”) non consona al suo genere.
In una simile situazione il decreto ministeriale che impediva di assegnare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione, anche quando avesse rivestito natura di regolamento di attuazione (ex art. 17, comma 1, lett. b), l. 400/1988) anziché di provvedimento amministrativo di carattere generale, doveva comunque essere disapplicato, in virtù dell’art. 4, comma 1, preleggi, in quanto conteneva una norma contraria alla disposizione di legge di cui all’art. 3, comma 5, r.d. 773/1931.