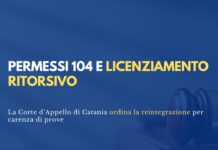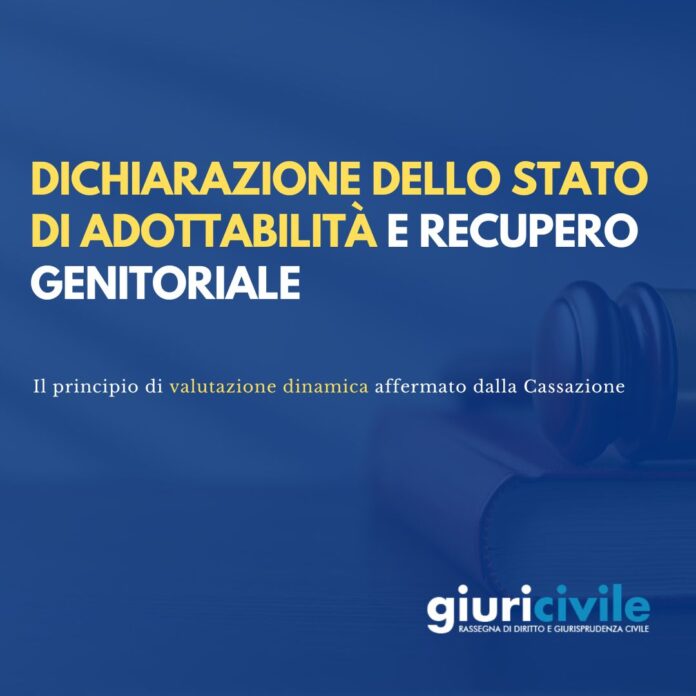
La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7 settembre 2025, n. 24728 (che puoi leggere cliccando qui), è tornata a pronunciarsi sul tema, nevralgico nel diritto minorile contemporaneo, del corretto perimetro della dichiarazione dello stato di adottabilità e del rapporto fra il giudizio sull’idoneità genitoriale e la natura evolutiva dei percorsi di sostegno intrapresi dai genitori in condizioni di fragilità.
La vicenda esaminata, assai complessa sul piano fattuale e umanamente sensibile, impone di riflettere sul modo in cui il giudice di merito debba confrontarsi con il principio di residualità dell’intervento ablativo e con l’obbligo, imposto sia dalla L. 184/1983 sia dalla giurisprudenza della Corte EDU, di valorizzare non solo la fotografia del passato, ma soprattutto i dinamismi, gli avanzamenti e le potenzialità di recupero emergenti da interventi psicologici, sociali e culturali in itinere.
Il perimetro normativo e il fondamento costituzionale della dichiarazione di adottabilità
L’istituto della dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinato dagli articoli 8 e seguenti della L. 184/1983, rappresenta uno degli interventi più incisivi che l’ordinamento consente nei confronti della famiglia. L’allontanamento definitivo del minore dal proprio nucleo di origine, secondo una costruzione normativa ormai consolidata, trova legittimazione solo quando risultano integrate circostanze di abbandono morale e materiale, in senso tecnico, e quando sia accertata l’impossibilità, non meramente astratta, ma concreta, attuale e irreversibile, di recuperare le competenze genitoriali entro tempi adeguati ai bisogni evolutivi del minore.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
La razionalità costituzionale dell’istituto impone un bilanciamento non semplice:
- da un lato, la protezione del superiore interesse del minore, che include la possibilità di vivere in un ambiente affettivamente stabile e adeguato;
- dall’altro, il diritto del genitore – anch’esso costituzionalmente garantito – di mantenere, recuperare e consolidare il legame con il figlio, diritto che, come affermato anche dalla Corte EDU, non può essere sacrificato sulla base di mere presunzioni o valutazioni predittive non suffragate da elementi obiettivi.
In questa dimensione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha svolto negli ultimi anni un ruolo fondamentale nel chiarire che la misura ablativa deve possedere una natura residuale, estrema, subordinata all’impossibilità di percorrere misure alternative. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 35110/2021, hanno stabilito che la dichiarazione di adottabilità deve fondarsi su una verifica rigorosa delle condizioni familiari, condotta attraverso un percorso istruttorio completo, sensibile alle caratteristiche culturali e psicologiche del genitore, e non può basarsi né su modelli ideali di genitorialità né su giudizi intrinsecamente moralistici o stereotipati.
Gli elementi fattuali della vicenda: dalla crisi genitoriale iniziale al percorso di recupero
La vicenda esaminata dalla Corte d’Appello e sottoposta al vaglio della Suprema Corte si connota da una prima fase segnata da gravi criticità. La madre, rifugiata, priva di reti sociali, con un passato di violenze e pressioni culturali complesse, aveva incontrato difficoltà significative nell’accudimento delle figlie gemelle, nate in Italia e affette da patologie e vulnerabilità proprie della prematurità e di un’infanzia trascorsa in un contesto di frammentazione socio-affettiva.
Le relazioni dei servizi sociali riferivano di episodi di incuria, difetti igienici, carenze alimentari, difficoltà relazionali durante gli incontri protetti, nonché della scarsa capacità della madre di mantenere una continuità nella partecipazione ai programmi di sostegno offerti dal sistema SPRAR. Episodi ospedalieri, tra cui un infortunio che aveva richiesto l’intervento dei sanitari, confermavano uno stato di preoccupante fragilità della relazione madre-bambine, tale da indurre i servizi e, poi, il Tribunale per i minorenni a dichiarare un quadro di abbandono.
Il percorso alternativo in una cooperativa
È, tuttavia, nel periodo successivo che la vicenda assume contorni significativi per la ricostruzione giuridica: la madre, consapevole delle proprie difficoltà e ritenendo il progetto SPRAR insufficiente a colmare le lacune maturate in un contesto biografico estremamente traumatico, sceglie volontariamente di inserirsi in un percorso alternativo presso la cooperativa Dedalus. Si tratta di un contesto dotato di équipe multidisciplinare specializzata, mediatori culturali, psicologi, operatori formati al lavoro con soggetti provenienti da scenari migratori e vittime di tratta, in grado di fornire un sostegno più articolato e continuo rispetto al progetto precedente.
Nel corso degli anni successivi, le relazioni acquisite documentano cambiamenti rilevanti: miglioramenti nelle competenze linguistiche, regolarizzazione lavorativa, acquisizione di un alloggio dignitoso, cura adeguata di un’ulteriore figlia nata nel frattempo, partecipazione costante alle attività della cooperativa e un progressivo consolidamento delle abilità riflessive e relazionali. Anche la CTU disponeva elementi che avrebbero potuto orientare il giudizio verso una rivalutazione della genitorialità, nonostante le persistenti difficoltà.
Ed è proprio questo segmento dinamico, evolutivo, non cristallizzato, che l’ordinanza reputa essere stato sottovalutato dal giudice di merito.
La necessità di una valutazione attuale, non cristallizzata, della capacità genitoriale
La Cassazione muove delle critiche alla Corte d’Appello per aver ancorato la propria decisione quasi esclusivamente alla situazione originaria, trascurando l’evoluzione successiva, benché essa fosse adeguatamente documentata e benché le stesse parti – ricorrente, curatrice speciale e pubblico ministero – avessero chiesto un’integrazione della CTU per verificare l’effettiva portata dei miglioramenti.
Il punto decisivo dell’ordinanza risiede nel ribadire che la dichiarazione di adottabilità non può fondarsi su una fotografia statica e passata della genitorialità, ma richiede una valutazione in progress, capace di cogliere la traiettoria evolutiva del genitore. La funzione del giudice minorile non è quella di registrare l’inadeguatezza storica del genitore, bensì quella di verificare se, attraverso interventi adeguati, tale inadeguatezza possa essere colmata in tempi compatibili con le esigenze del minore. Se il passato documenta il problema, è il presente – e ancor di più la tendenza del presente verso il miglioramento – che documenta la possibilità di recupero.
Lo stato di abbandono richiede un deficit radicato e persistente
Questa impostazione costituisce il cuore della giurisprudenza contemporanea: lo stato di abbandono non si identifica con la mera difficoltà, con l’errore o con la disorganizzazione temporanea della vita familiare, ma richiede un deficit radicato e tendenzialmente persistente, non sanabile nonostante il sostegno ricevuto. L’omissione di verificare l’efficacia del sostegno, quando questo è in atto, costituisce dunque un vizio grave.
La Corte sottolinea, con un linguaggio che vale come monito generale, che il giudice deve “sperimentare” le possibilità di recupero, soprattutto quando i segnali emersi indicano una direzione positiva. Non si tratta di attendere illimitatamente, né di sacrificare l’interesse del minore in nome di una speranza vaga: si tratta di confrontarsi seriamente con gli strumenti a disposizione e verificare se essi siano in grado, nel caso concreto, di generare un assetto familiare sufficientemente adeguato. Solo la fallibilità provata, e non presunta, del sostegno può giustificare la misura ablativa.
La vulnerabilità culturale, lo status di rifugiata e il paradigma CEDU delle misure positive
L’ordinanza lascia emergere, in controluce, l’importanza di considerare la vulnerabilità culturale e biografica del genitore nel giudizio di abbandono.
La Corte EDU, in pronunce ormai classiche come –
- K. and T. v. Finland (il caso, deciso nel 2001, riguardava le decisioni di collocare i bambini in una casa famiglia e la riduzione dei diritti di visita a una sola visita mensile supervisionata),
- Saviny v. Ukraine (la decisione ,risalente al 2008, concerne il diritto dei bambini a non essere separati dai propri genitori, se non in circostanze eccezionali e legali, in questo caso legate al diritto dei genitori di prendersi cura dei propri figli),
- Zhou v. Italy ( nel 2014 arriva la condanna CEDU a carico dell’Italia per aver violato il diritto alla vita familiare di una cittadina cinese che non era riuscita ad accudire la figlia a causa di condizioni economiche e lavorative estremamente precarie)
– ha ribadito che le autorità nazionali devono adottare misure positive per mantenere e ricostruire la vita familiare, soprattutto quando il genitore appartiene a un gruppo vulnerabile e quando il contesto culturale rappresenta un fattore incidentale nella difficoltà genitoriale.
L’importanza di un approccio culturalmente sensibile
La condizione di rifugiata della madre, il suo vissuto traumatico, l’assenza di una rete familiare, la barriera linguistica e la differenza dei modelli educativi costituiscono elementi che avrebbero dovuto orientare il giudice verso un approccio culturalmente sensibile. Non si tratta di una mitigazione indulgente della responsabilità genitoriale, bensì della consapevolezza che la vulnerabilità non può essere interpretata come colpa, e che l’obiettivo del sistema non è quello di sanzionare il fallimento del passato, ma di favorire il recupero, quando possibile, attraverso percorsi calibrati sulle fragilità e sulle risorse del genitore.
Il mancato approfondimento delle reali condizioni culturali e psicologiche della madre, così come la mancata valutazione del percorso alternativo intrapreso presso una struttura – Dedalus – specificamente dedicata all’inclusione culturale, rappresentano, secondo la Cassazione, omissioni che ledono non solo la logica interna della L. 184/1983, ma anche il principio di proporzionalità richiesto dall’art. 8 CEDU.
La mancata valutazione delle misure meno afflittive e il ruolo dell’adozione mite
Un ulteriore profilo critico della sentenza impugnata, sottolineato dalla Cassazione, riguarda la totale assenza di considerazione delle misure alternative all’adozione piena. La Corte d’Appello non aveva preso in esame né la possibilità di un affidamento prolungato con sostegno intensivo, né quella di un’adozione mite, né la possibilità di un’adozione aperta con mantenimento dei rapporti ai sensi dell’art. 19, comma 2, L. 184/1983.
L’adozione piena è misura che determina un’estinzione totale dei legami giuridici e identitari con la famiglia di origine; proprio per questa sua natura radicale, deve essere preceduta dalla verifica della praticabilità di soluzioni intermedie. L’adozione mite, in particolare, rappresenta un istituto flessibile, adatto alle situazioni in cui la famiglia di origine, pur non essendo in grado di provvedere in autonomia alle esigenze quotidiane del minore, mantiene un ruolo affettivo, relazionale e identitario che non sarebbe conforme all’interesse del minore recidere.
La totale omissione, da parte della Corte territoriale, di una riflessione su tali alternative conferma, per la Cassazione, la mancanza di un approccio realmente graduato e proporzionato, e costituisce un ulteriore indice dell’insufficienza motivazionale.
Il significato sistemico dell’ordinanza: verso un modello di accertamento realmente dinamico
L’ordinanza si chiude affermando che la Corte d’Appello deve riesaminare la vicenda alla luce di un accertamento completo, attuale e culturalmente contestualizzato, senza preclusioni e senza automatismi. Il rinvio non rappresenta soltanto un invito a ripetere la valutazione, ma un monito metodologico rivolto all’intero sistema giudiziario minorile. Il giudice non può limitarsi a documentare la patologia del passato: deve confrontarsi con l’interrogativo più difficile e più delicato, ossia se la genitorialità possa essere recuperata con gli strumenti oggi disponibili.
In un sistema che riconosce la genitorialità come capacità evolutiva e non come tratto identitario fisso, l’intervento giurisdizionale deve essere sensibile alle traiettorie di vita, alle fragilità, alle potenzialità e alla possibilità di accompagnare il genitore verso un livello di adeguatezza sufficiente.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: la dichiarazione di adottabilità non è uno strumento di “messa in sicurezza” automatica quando un’infanzia è segnata da difficoltà, ma un istituto da utilizzare con cautela, rigore e consapevolezza del fatto che la recisione dei legami familiari è un atto definitivo, e come tale deve rappresentare davvero l’ultima soluzione possibile.
Conclusioni
L’ordinanza della Prima Sezione civile n. 24728 del 7 settembre 2025 si colloca nel solco di una traiettoria giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente affinato i criteri di legittimità della dichiarazione di adottabilità, spostando il baricentro dall’idea di una genitorialità concepita come dato statico a quella di una genitorialità intesa come capacità evolutiva, suscettibile di sostegno, correzione e recupero.
Il caso esaminato è emblematico perché porta all’estremo una tensione strutturale del sistema: da un lato, la doverosa protezione del minore contro situazioni di grave incuria e disorganizzazione familiare; dall’altro, il rischio di cristallizzare in modo irreversibile gli esiti di una fase patologica della storia familiare, senza verificare fino in fondo se e quanto gli strumenti di supporto attivati abbiano inciso sulle competenze genitoriali e sulla qualità del progetto di vita del genitore.
Il messaggio che la Corte di cassazione invia ai giudici di merito è nitido:
non può considerarsi conforme alla L. 184/1983, né ai parametri costituzionali ed eurounitari, una prassi decisoria che, una volta accertata una situazione iniziale di abbandono, si ritenga esonerata dal compito di monitorare l’evoluzione successiva, soprattutto quando questa sia segnata da percorsi terapeutici, formativi e di integrazione sociale seriamente intrapresi e sostenuti.
La dichiarazione di adottabilità, in altre parole, non può divenire la sanzione retrospettiva del fallimento familiare, ma deve rimanere uno strumento funzionale al solo caso in cui, nonostante gli interventi di sostegno, una prospettiva di recupero in tempi ragionevoli risulti insussistente. Ogni arretramento rispetto a questo modello espone l’ordinamento al rischio di utilizzare l’adozione come risposta standardizzata alle criticità, anziché come extrema ratio.