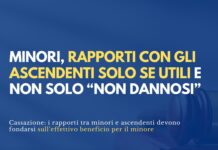Lo status giuridico dell’animale costituisce una questione centrale e irrisolta all’interno dell’ordinamento italiano, generando una dicotomia normativa tra la concezione dell’animale all’interno del Codice civile e le moderne riforme della Costituzione e del diritto penale. Le moderne conoscenze scientifiche ed etologiche, infatti, rendono oggi insostenibile la tradizionale classificazione dell’animale come mera res, ossia come bene privo di soggettività intrinseca e pienamente destinato alla disponibilità dell’uomo.
Questa visione anacronistica è ulteriormente contrastata dal diritto comunitario, che impone un chiaro orientamento in senso progressivo. In particolare, l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce inequivocabilmente che: “l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.”
Le radici civilistiche: l’animale come cosa
L’attuale statuto civilistico dell’animale trova la sua genesi nella rigida dicotomia res/persona di matrice romanistica. Il diritto civile moderno ha ereditato l’impostazione che definisce l’animale non in base alla sua natura biologica o sensoriale, ma in virtù della sua utilità economica per l’uomo.
Già nelle Institutiones, il giurista Gaio definiva gli animali da lavoro essenziali per l’economia agraria (come buoi e cavalli) come res mancipi (beni di maggiore importanza il cui trasferimento richiedeva la mancipatio), mentre gli animali selvatici (ferae bestiae) erano classificati come res nullius (cose di nessuno, acquisibili per occupazione), ribadendo il loro status di oggetti e la loro strumentalità economica.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
Il recepimento nel Codice Civile
Questa logica formale e strumentale è stata integralmente recepita dal Codice Civile italiano del 1942, che inquadra l’animale come un bene, privo di qualsivoglia soggettività giuridica. L’impostazione è desumibile dall’analisi combinata di diverse norme fondamentali.
In primo luogo, l’art. 810 c.c. fornisce la cornice generale, stabilendo che sono “beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. L’animale, in quanto cosa suscettibile di formare oggetto di proprietà, ricade in tale definizione. Conseguentemente, l’Art. 812 c.c., operando la distinzione fondamentale tra beni immobili e mobili, classifica l’animale per esclusione e prassi consolidata come bene mobile, rendendolo soggetto alle norme sulla circolazione e sul possesso tipiche delle res.
Inoltre, il Codice rafforza questa logica utilitaristica definendo i parti degli animali come frutti naturali (art. 820, comma 2, c.c.), assimilando la loro funzione a quella produttiva dei beni agricoli. La stessa disciplina dell’acquisto delle cose mobili che non sono proprietà di alcuno ribadisce lo status di res nullius per gli animali selvatici: l’art. 923 c.c. equipara infatti l’animale che forma oggetto di caccia o di pesca alle cose abbandonate, acquisibili per occupazione. Infine, la natura di res è confermata dalla disciplina contrattuale, poiché le norme sulla vendita di animali (art. 1490 c.c. e ss.) non prevedono regole specifiche legate alla loro natura senziente, ma applicano il regime ordinario dei contratti, come nel caso della garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1496 c.c.).
L’analisi degli articoli chiave del Codice Civile, dunque, conferma che, dal punto di vista del diritto privato, l’animale è considerato una mera entità patrimoniale, il cui valore risiede esclusivamente nella sua utilità e disponibilità per il proprietario.
Prime aperture: la tutela degli animali d’affezione
Nonostante la rigida qualificazione civilistica come res, l’ordinamento italiano presenta già in altri settori norme che, pur non riconoscendo una piena soggettività, iniziano a distanziarsi dalla logica della pura utilità economica, in particolare per gli animali d’affezione.
Tale tendenza è emblematicamente riscontrabile nell’ambito del diritto processuale civile. L’articolo 514 del Codice di Procedura Civile, che elenca le cose mobili assolutamente impignorabili, annovera al comma 1, n. 6bis e 6ter, gli animali da compagnia o d’affezione.
Questa disposizione è di fondamentale importanza: l’impignorabilità sottrae l’animale alla sua funzione meramente patrimoniale e salvaguarda il legame affettivo e la funzione relazionale che l’animale svolge all’interno del nucleo familiare.
Potrebbe interessarti anche:
La svolta penale e la deoggettivizzazione dell’animale
Il primo e più netto punto di rottura con l’impostazione civilistica si è realizzato in ambito penale, con l’introduzione della Legge 20 luglio 2004, n. 189, che introduce il Titolo IX-bis del Codice Penale, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, formula che rifletteva ancora una certa cautela concettuale, anche se la portata innovativa delle nuove norme trascende ampiamente la tutela del mero sentimento umano, in quanto già dalla semplice lettura delle nuove disposizioni introdotte, l’oggetto giuridico tutelato non appare essere il turbamento della sensibilità collettiva, bensì l’integrità psico-fisica e la vita dell’animale stesso, in quanto essere senziente.
Viene infatti riconosciuto, per la prima volta in modo esplicito, un bene giuridico autonomo in capo all’animale, che non dipende dal diritto di proprietà, come si evince dalla formulazione dell’art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali), norma che punisce chiunque, senza necessità o con crudeltà, cagioni la morte di un animale; o, ancora, l’art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), fattispecie che sanziona chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione all’animale, o lo sottoponga a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La centralità è, dunque, posta sulla sofferenza inflitta all’animale. Ricordiamo, infine, anche gli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. che introducono divieti specifici, punendo la promozione o l’organizzazione di spettacoli, manifestazioni o combattimenti che comportino sevizie, violando il principio di rispetto per la dignità dell’animale.
Attraverso questi articoli, lo Stato non interviene più per punire il danno al patrimonio del proprietario, ma interviene per tutelare l’animale direttamente in quanto tale. Ciò rappresenta la definitiva deoggettivizzazione dell’animale nell’ambito della responsabilità penale, ponendo le basi per il suo riconoscimento come essere senziente all’interno dell’ordinamento.
La Legge Brambilla
Tale direzione è stata decisamente consolidata e rafforzata dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82 (nota come Legge Brambilla, dal nome della deputata prima firmataria) che ha introdotto “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.
Con l’entrata in vigore di tale atto legislativo, viene modificato, ai sensi dell’articolo 1, il titolo IX-bis del codice penale, rubricato oggi “Dei delitti contro gli animali“. Viene così meno l’ultimo riferimento alla protezione degli animali in relazione al sentimento umano, riconoscendoli in tutto e per tutto quali oggetti di tutela diretti. Sulla base di tale nuovo e consolidato orientamento vengono dunque severamente inasprite le sanzioni, e vengono introdotte nuove aggravanti per fatti commessi in presenza di minori o diffusi online. Inoltre, vengono introdotti nuovi divieti che prevedono sanzioni anche di natura amministrativa, come l’articolo 10 che sancisce il divieto di detenere animali da affezione alla catena, stabilendo un parametro di benessere etologico come standard di detenzione.
La tutela costituzionale
Il culmine di tale evoluzione si ha poi con la Legge Costituzionale n. 1 del 2022 che, modificando l’articolo 9 della nostra Carta fondamentale, eleva la tutela degli animali al massimo rango normativo. La nuova formulazione del comma 3 stabilisce che “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali“, inserendo l’obbligo di tutela nel contesto più ampio della protezione dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Sebbene la norma si collochi in un ambito collettivo, essa consacra la tutela animale come principio fondamentale della Repubblica, vincolando il legislatore ordinario a superare la logica della res. Questo principio, unito alla nozione di “esseri senzienti” introdotta dall’art. 13 TFUE, rende insostenibile il mantenimento dello status di bene mobile nel Diritto Civile, generando l’attuale e irrisolta dicotomia normativa.
Il ruolo della giurisprudenza nel colmare il vuoto
La mancata riforma dello statuto privatistico dell’animale, in contrasto con l’evoluzione penale e costituzionale, genera un vuoto normativo che ricade interamente sulla giurisprudenza. I giudici sono così costretti a ricorrere a interpretazioni analogiche e a forzature del sistema civilistico per tutelare il valore non patrimoniale e affettivo dell’animale d’affezione, agendo come vero e proprio “diritto vivente” in contrasto con la legge codicistica.
Un primo ambito in cui si ha riscontro di tale intervento per colmare i “vuoti” del diritto da parte della giurisprudenza è quella del risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale. Se, infatti, l’animale fosse unicamente una res, il risarcimento dovrebbe limitarsi al suo valore economico. La giurisprudenza di merito ha, tuttavia, riconosciuto e ammesso la risarcibilità del danno esistenziale subito dal proprietario superando l’impostazione restrittiva della Cassazione che legava strettamente il danno non patrimoniale alla sussistenza di un reato, valorizzando il legame affettivo come bene meritevole di tutela risarcitoria autonoma.
Allo stesso modo, il paradosso emerge nelle controversie sull’affidamento degli animali domestici in caso di separazione o divorzio. In assenza di una norma specifica, nonostante una proposta di legge in merito, mai approvata, i giudici hanno scartato l’ipotesi di applicazione delle regole previste per la comunione o divisione dei beni, privilegiando una analisi ispirata analogicamente ai criteri stabiliti per l’affidamento dei figli minori, basata spesso sulla valutazione del maggiore benessere dell’animale. Questo approccio si oppone diametralmente alla concezione di res prevista dal codice civile, ma accoglie pienamente quella di essere senziente prevista dalle norme sovranazionali, dalla Costituzione e dal codice penale.
Conclusione: verso una riforma del Codice Civile
Da tale analisi si evince una insostenibile dicotomia normativa che caratterizza lo status giuridico dell’animale nell’ordinamento italiano. Infatti, se il Diritto Civile mantiene una concezione anacronistica dell’animale, equiparandolo a una res, il Diritto Penale e il Diritto Costituzionale lo riconoscono pienamente come essere senziente e oggetto di tutela diretta e primaria.
Per sanare tale aporia normativa, diviene indispensabile un intervento sulla normativa civile. La soluzione potrebbe essere l’introduzione di una categoria giuridica intermedia, nettamente distinta sia dalle persone che dalle cose, che riconosca l’animale come soggetto di tutela e non come mero oggetto di proprietà. Tale riforma dovrebbe inoltre dettare una disciplina specifica per l’animale d’affezione, in linea con la normativa sovranazionale e con la giurisprudenza di merito.
Questo orientamento è già stato adottato con successo in diversi Paesi dell’Unione Europea, quali Portogallo, Francia e Spagna, che hanno riconosciuto esplicitamente la senzienza e la dignità degli animali. In questi ordinamenti è, infatti, stato stabilito che sarà loro applicabile il regime giuridico dei beni e delle cose solo nella misura in cui tale applicazione risulti compatibile con la loro natura o con le disposizioni destinate alla loro protezione.
L’adeguamento del Codice Civile a questi principi non è più, dunque, una mera opzione etica, ma un imperativo giuridico richiesto dal quadro costituzionale ed europeo, essenziale per la coerenza e la modernità dell’ordinamento italiano.
Unisciti alla nostra comunità legale
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime notizie, analisi giuridiche e risorse esclusive direttamente nella tua casella di posta. Non perdere nessun aggiornamento importante nel campo del diritto civile. Iscriviti ora e rimani informato!