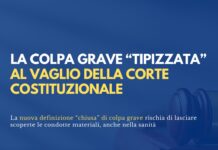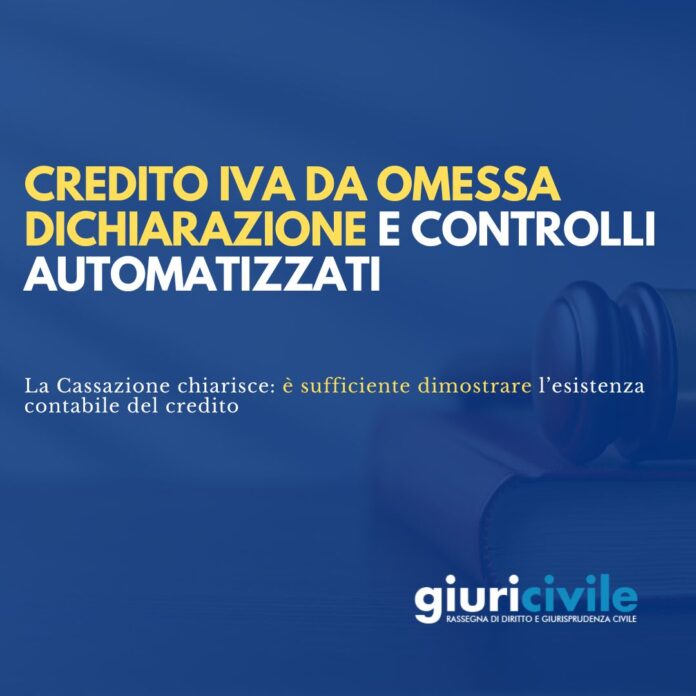
Con l’ordinanza n. 27238 dell’11 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Corte di Cassazione torna sul tema del diritto alla detrazione IVA, offrendo un chiarimento sui limiti dell’onere probatorio del soggetto passivo. La peculiarità della pronuncia non risiede nella riaffermazione di principi già consolidati, quanto nel censurare un grave errore di prospettiva dei giudici di merito in uno specifico contesto procedurale: quello del controllo automatizzato su un credito IVA emerso da una dichiarazione omessa. La Corte ribadisce come la prova del pagamento delle fatture sia estranea ai presupposti costitutivi della detrazione.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
La vicenda processuale
Il caso sottoposto alla Suprema Corte origina da una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA (ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972) per l’anno di imposta 2012. L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il diritto a computare in detrazione un’eccedenza creditoria maturata nell’annualità precedente, per la quale la dichiarazione era stata presentata con un ritardo superiore a novanta giorni e, dunque, ai sensi dell’art.2, comma 7, del DPR 322/1998, qualificata come omessa (cd. ultratardiva).
In questo scenario, il thema decidendum è circoscritto e specifico: spetta al contribuente, che intende far valere un credito non validamente esposto in dichiarazione, l’onere di dimostrarne l’esistenza e la spettanza. Le corti di merito, tuttavia, avevano rigettato le ragioni del contribuente sulla base di un unico e dirimente presupposto: la mancata prova dell’effettivo pagamento delle fatture passive. Tale impostazione costituisce, come vedremo, un’erronea commistione tra gli oneri probatori richiesti in sede di controllo formale e le dinamiche presuntive tipiche degli accertamenti.
Potrebbero interessarti anche:
- Società di comodo e detrazione IVA
- Rimborso IVA in assenza di operazioni attive: la Cassazione ribadisce la spettanza
- Rimborso IVA per ristrutturazione immobili: le Sezioni unite
- Proporzionalità delle sanzioni tributarie: il contribuente può ottenere una riduzione
I requisiti per la detrazione e l’errore di diritto della Corte di merito
La Cassazione, nel cassare la sentenza, riporta il dibattito sui binari della corretta applicazione del dato normativo, unionale e nazionale. I requisiti per l’esercizio del diritto alla detrazione sono solo due, uno sostanziale e uno formale:
- il requisito sostanziale attiene all’effettiva realizzazione dell’operazione imponibile (la cessione di beni o la prestazione di servizi) e alla sua inerenza all’attività d’impresa;
- il requisito formale si identifica nel possesso di una fattura correttamente redatta e nella sua corretta e tempestiva annotazione nell’apposito registro.
Questo impianto non contempla il pagamento del corrispettivo come condizione per la detrazione. Il diritto sorge “nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” (art. 19, d.P.R. n. 633/1972), non quando il debito verso il fornitore viene estinto.
L’errore dei giudici di merito è stato quindi quello di trasformare un elemento neutro, quale il pagamento, in un presupposto costitutivo del diritto. Anche se non chiaramente esplicitato nella sentenza in commento, ciò che rileva è che in un contesto come quello del controllo automatizzato, dove al contribuente è semplicemente richiesto di provare la legittimità del credito vantato, l’analisi deve arrestarsi alla verifica dei due requisiti normativamente previsti. Pretendere un quid pluris, come la quietanza delle fatture, significa violare i principi di neutralità e proporzionalità, gravando il soggetto passivo di un onere probatorio non previsto da alcuna norma.
I precedenti delle Sezioni Unite
Per chiarire il punto è sufficiente citare due importanti pronunce delle Sezioni Unite:
- la sentenza n. 17757/2016, secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta […] sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione […]”. In altri termini, “l‘infrazione è da ritenersi emendabile sul piano del rapporto impositivo laddove si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo (Cass. sez. 5, n.3586 del 2016), in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa (Cass. sez. 5, n.25871 del 2015), sempreché non risulti in concreto impedita la prova dell’adempimento dei requisiti sostanziali (Cass. sez. 5, n.4612 del 2016)”;
- la sentenza n. 17758/2016 che, da un lato legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, dall’altro precisa che attraverso le procedure automatizzate viene esercitato “un controllo formale che non tocc[a] la posizione sostanziale della parte contribuente e […] scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 bis e 60”. Ne consegue che il contribuente deve dimostrare solamente che la detrazione “[…] riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili“.
La prova del pagamento: elemento neutro ai fini della detrazione
Se il pagamento non è requisito per la detrazione, ciò non significa che sia un dato sempre irrilevante: la sua funzione può manifestarsi nell’ambito nella contestazione di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti. Tuttavia, va subito precisato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che neppure in tali casi il mancato pagamento (o anche il suo opposto) sia di per sé dirimente (ex multis Cassazione n. 4335/2016). Esistono operazioni perfettamente lecite ma non pagate per difficoltà finanziarie, così come esistono operazioni fraudolente interamente saldate, proprio per dare una parvenza di normalità alla transazione.
Il mancato pagamento, dunque, degrada a mero elemento indiziario (ex multis Cassazione n. 24130/2025), il cui peso deve essere valutato nel complesso del quadro probatorio delineato dall’Ufficio. L’errore del giudice di merito nel caso di specie è stato quello di decontestualizzare tale elemento, elevandolo a prova regina in un ambito – il controllo formale – dove non era in discussione alcuna ipotesi di frode.
Il principio di diritto
«Il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo che lo fa valere in giudizio dimostra il presupposto sostanziale dell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi e dà prova del requisito formale, attraverso la pertinente valida fattura d’acquisto annotata nei registri IVA, mentre non è necessaria la prova del pagamento».
L’evoluzione della prassi amministrativa
La gestione dei crediti IVA da dichiarazione omessa è un tema che ha impegnato non solo la giurisprudenza, ma anche l’Agenzia delle Entrate, la cui prassi ha mostrato una significativa evoluzione nel tempo.
In un primo momento, con la Circolare n. 34/E del 2012, l’approccio era marcatamente formalistico. A fronte del disconoscimento del credito riportato nella dichiarazione successiva, l’Agenzia affermava che il contribuente, pur avendo diritto sostanziale al credito (se effettivamente esistente), non potesse recuperarlo tramite la detrazione. L’unica via offerta era quella, più onerosa e complessa, di pagare l’intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità e, solo successivamente, presentare un’istanza di rimborso (ex art. 21, d.lgs. n. 546/1992). Una soluzione che salvaguardava il principio di neutralità solo in via postuma.
Consapevole dell’ingente contenzioso generato da tale rigidità, l’Amministrazione ha corretto il tiro con la successiva Circolare n. 21/E del 2013, che ha introdotto un approccio molto più pragmatico. Si è previsto che il contribuente, già in fase di riscontro alla comunicazione di irregolarità, possa produrre la documentazione attestante l’esistenza contabile del credito. A seguito di una positiva verifica, l’Ufficio è legittimato a “scomputare” direttamente l’importo del credito spettante dalle somme richieste, emettendo una comunicazione definitiva per l’eventuale debito residuo.
Per completezza, si segnala anche la Risoluzione n. 82/E del 2020, sul diverso caso in cui nella dichiarazione cd. ultratardiva si opti non per il riporto in avanti del credito, ma per il suo rimborso. Secondo l’Agenzia delle Entrate la mera indicazione non è sufficiente a fondare la richiesta, ma si rende necessaria una specifica ed ulteriore istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973. Tuttavia, secondo una recente pronuncia (Cassazione n. 18715/2025) sarebbe vero l’esatto contrario, valendo già la dichiarazione come istanza, se il credito è esplicitamente indicato nel campo della richiesta a rimborso.
Conclusioni
L’ordinanza in commento contribuisce a delineare il giusto perimetro dell’onere probatorio del contribuente in sede di controllo formale, escludendo nettamente dai presupposti costitutivi del diritto alla detrazione la prova del pagamento del corrispettivo, requisito non previsto dalla norma che minerebbe alla radice il principio di neutralità dell’IVA.