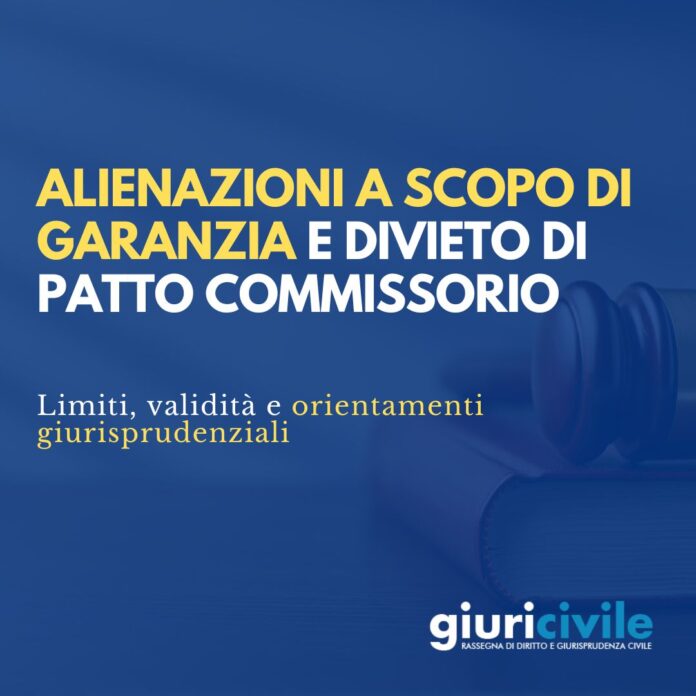
Le alienazioni a scopo di garanzia rappresentano uno dei terreni più fertili per l’emersione delle tensioni tra autonomia privata, funzione economica del contratto e limiti imposti dall’ordinamento. L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia ha posto in luce la necessità di una lettura funzionale degli atti di trasferimento patrimoniale, al fine di cogliere l’effettiva causa concreta dell’operazione e di prevenire fenomeni elusivi del divieto di patto commissorio.
Autonomia negoziale e causa concreta del contratto
L’avvento della nozione di causa in concreto, quale funzione economico individuale del contratto, ha dato nuova linfa al concetto di autonomia contrattuale. Le parti, nell’esercizio della propria libertà negoziale, possono ricorrere a contratti tipici o atipici, oppure plasmare i modelli normativi in funzione di scopi individuali.
La signoria della volontà, tuttavia, incontra il limite della liceità: l’illiceità della causa produce la nullità del contratto. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, ovvero quando costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
Nelle alienazioni a scopo di garanzia, le parti utilizzano contratti di vendita tipizzati adattandoli al perseguimento di una funzione sostanziale di finanziamento e di garanzia. Il ricorso a tali strumenti normativi, a scopo di garanzia, rappresenta, nella prassi, il mezzo per eludere il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.
Il contratto di vendita e la disciplina degli effetti traslativi
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La compravendita è un contratto consensuale, ad effetti reali: consensuale in quanto, per il suo perfezionamento, è sufficiente il semplice consenso delle parti e non occorre anche l’effettiva consegna della cosa; ad effetti reali, dal momento che, la compravendita, normalmente, produce il trasferimento della proprietà della cosa, ovvero l’acquisto di altro diritto.
Consiglio: stai approfondendo i profili strutturali e funzionali del contratto di vendita e delle garanzie nei trasferimenti immobiliari? Il volume “Casa in costruzione”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un’analisi completa, operativa e aggiornata della disciplina sugli immobili da costruire, tra normativa speciale, giurisprudenza e prassi notarile.

Casa in costruzione
Un manuale pensato per offrire risposte concrete alle problematiche quotidiane che avvocati, notai e professionisti del settore devono affrontare per tutelare chi acquista immobili in costruzione.
Dalla verifica delle garanzie fideiussorie alla consegna della polizza decennale postuma, dalla corretta redazione del contratto preliminare alla gestione delle varianti in corso d’opera e ai profili di responsabilità di costruttori e garanti, il volume propone una pratica guida con casi pratici, soluzioni interpretative aggiornate e schemi di atti, offrendo un’analisi completa della disciplina dettata dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, e del pacchetto di tutele predisposto dal legislatore al fine di riequilibrare una fattispecie contrattuale caratterizzata da una forte asimmetria.
Una particolare attenzione è dedicata alle prassi notarili e alle novità introdotte dalla normativa secondaria, nonché alle implicazioni concrete per la redazione degli atti.
Ivana Panella
Notaio in Cesenatico, si occupa di contratti, diritto societario, successioni e donazioni.
Leggi descrizione
Ivana Panella, 2025, Maggioli Editore
31.00 €
29.45 €

Casa in costruzione
Un manuale pensato per offrire risposte concrete alle problematiche quotidiane che avvocati, notai e professionisti del settore devono affrontare per tutelare chi acquista immobili in costruzione.
Dalla verifica delle garanzie fideiussorie alla consegna della polizza decennale postuma, dalla corretta redazione del contratto preliminare alla gestione delle varianti in corso d’opera e ai profili di responsabilità di costruttori e garanti, il volume propone una pratica guida con casi pratici, soluzioni interpretative aggiornate e schemi di atti, offrendo un’analisi completa della disciplina dettata dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, e del pacchetto di tutele predisposto dal legislatore al fine di riequilibrare una fattispecie contrattuale caratterizzata da una forte asimmetria.
Una particolare attenzione è dedicata alle prassi notarili e alle novità introdotte dalla normativa secondaria, nonché alle implicazioni concrete per la redazione degli atti.
Ivana Panella
Notaio in Cesenatico, si occupa di contratti, diritto societario, successioni e donazioni.
L’effetto traslativo, in virtù del principio consensualistico ex art. 1376 cc, si verifica in seguito alla libera manifestazione del consenso e, dunque, con la conclusione del contratto. Il legislatore, tuttavia, ha tipizzato anche ipotesi in cui l’effetto traslativo è differito o sottoposto a condizioni.
Vendita a rate con riserva di proprietà
Nella vendita a rate con riserva di proprietà, a norma dell’art. 1523 c.c., il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. In questi casi, si realizza un differimento dell’effetto traslativo: il venditore è titolare di un diritto di proprietà sul bene alienato che è, nel contempo, limitato dal concorrente diritto del compratore. Il compratore sarebbe titolare di un diritto reale sui generis che si sostanzierebbe nel potere di usare la cosa e di detenerla sia nell’interesse proprio che in quello del venditore.
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto, invece, è una vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa. A norma dell’art. 1500 c.c., tramite il patto di riscatto, il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge.
La facoltà concessa al venditore di tornare proprietario della cosa alienata trova il suo fondamento nell’intento del legislatore di consentire di riacquistare un bene a colui il quale si sia trovato nella necessità di alienarlo sul fondato presupposto della temporaneità di tale stato di necessità.
Nella vendita con patto di riscatto, il venditore e il compratore rivestono, dunque, due posizioni diverse:
- il primo (il venditore) è titolare di una proprietà temporanea o risolubile e ne potrà disporre con i limiti di cui all’art. 1357 cc;
- il secondo (il compratore) è titolare di un diritto personale che ha natura potestativa, in quanto l’esercizio del riscatto produce il mutamento automatico della situazione giuridica senza che sia necessaria alcuna collaborazione da parte del compratore, il quale si trova in uno stato di soggezione.
L’efficacia del riscatto è un limite al potere di disporre del bene da parte del compratore ed è pertanto soggetta a limitazioni temporali: in particolare, l’art. 1501 c.c. prevede che il temine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili.
Il venditore manifesta la propria intenzione di effettuare il riscatto mediante una dichiarazione unilaterale che ha natura negoziale e carattere recettizio e che deve essere fatta per iscritto, a pena di nullità, oltre che trascritta nel caso di beni immobili.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza, ex art. 1500, comma secondo, c.c.
L’utilizzo distorto del tipo e l’elusione del divieto di patto commissorio
Il ricorso, nella prassi, alla vendita con patto di riscatto si è concretizzato in un uso distorto del tipo: ogniqualvolta, infatti, le parti stipulino un contratto di vendita con patto di riscatto allo scopo di garantire un preesistente rapporto di debito tale per cui, l’esercizio del riscatto sia condizionato al pagamento di un credito del venditore nei confronti del compratore, si altera la causa di scambio e si realizza uno scopo di garanzia.
Le alienazioni a scopo di garanzia violano, indirettamente, il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., a norma del quale, è nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.
Il fondamento del divieto di patto commissorio
Dottrina e giurisprudenza, nel ricostruire i rapporti tra vendita con patto di riscatto e divieto di patto commissorio, hanno tentato di enucleare le ipotesi in cui la conclusione di un contratto, a scopo di garanzia, possa considerarsi lecita e non elusiva della regola di cui all’art. 2744 cc.
Innanzitutto, quanto al fondamento del divieto di patto commissorio, si deve evidenziare che tale questione rappresenta una problematica tuttora aperta:
- Un primo orientamento individua la ratio della norma nell’esigenza di evitare la coazione psicologica del debitore che sarebbe spinto al compimento dell’atto dallo stato di bisogno, accettando condizioni inique.
- Un secondo orientamento invoca l’esigenza di tutelare la par condicio creditorum per giustificare il divieto: il patto commissorio, infatti, realizzerebbe il soddisfacimento preferenziale di un creditore, al di fuori delle causa legittime di prelazione e con pregiudizio per gli altri.
- Una terza teoria fa leva sul principio di tipicità delle garanzie reali che sarebbe violato ove si consentisse all’autonomia privata di dar vita ad un sistema parallelo di garanzie convenzionali. Si obietta che, nel caso di specie, è lo stesso divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 cc a determinare la tipicità della fattispecie.
- Alla stregua di una diversa ricostruzione, occorrerebbe, invece, avere riguardo al monopolio statale nell’esercizio della funzione esecutiva che non consente ai privati di farsi giustizia da sé. In senso critico, si è osservato che tale affermazione non ha rilievo assoluto posto che, in determinati casi, l’ordinamento riconosce l’autotutela privata.
Prevalenza della teoria combinatoria
Il rilievo che nessuna delle soluzioni prospettate sia in grado di offrire una ricostruzione esaustiva e soddisfacente del fondamento del divieto, ha dato la stura per la prospettazione della teoria combinatoria che ritiene preferibile spiegare il divieto del patto commissorio sulla base della concorrente operatività di tutte le teorie che la dottrina ha elaborato, essendo tutte idonee a giustificare la previsione contenuta nell’art. 2744 c.c.
La giurisprudenza sulle vendite a scopo di garanzia
Per quanto riguarda le alienazioni a scopo di garanzia, un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità distingueva due ipotesi. Da un lato, la vendita sottoposta a condizione sospensiva legata all’inadempimento dell’obbligazione. Dall’altro, la vendita con finalità di garanzia, ma risolutivamente condizionata all’adempimento, accompagnata da un patto di riscatto.
Secondo questa impostazione, risultavano nulle solo le vendite con condizione sospensiva. In questi casi, il trasferimento della proprietà avveniva solo se il debitore non adempiva, realizzando così un effetto commissorio in contrasto con l’art. 2744 c.c.
Al contrario, si riteneva lecita la vendita risolutivamente condizionata. Qui la proprietà passava immediatamente al creditore, salvo risolversi se il debitore adempiva. L’effetto traslativo, quindi, si produceva al momento della conclusione del contratto, senza violare il divieto di patto commissorio.
In particolare, si considerava legittima la vendita con patto di riscatto utilizzata a scopo di garanzia, interpretandola come un negozio fiduciario. In tale schema, il proprietario trasferisce un diritto a un altro soggetto che si obbliga a rispettare finalità determinate, per poi ritrasferirlo a certe condizioni.
Il negozio fiduciario produce due effetti distinti: uno obbligatorio, valido solo tra le parti; l’altro reale, opponibile ai terzi solo se reso noto all’esterno.
In base a questa ricostruzione, la vendita trasferiva la proprietà in modo effettivo e opponibile, mentre il patto fiduciario vincolava le parti a una funzione di garanzia. Il debitore, adempiendo, poteva esercitare il riscatto e riacquistare il bene, secondo quanto stabilito nell’accordo fiduciario.
Critiche della dottrina
La dottrina, in senso critico rispetto a tale orientamento, ha osservato che l’individuazione di operazioni di vendita a scopo di garanzia dovrebbe essere effettuata non in base alla verifica se il passaggio del bene in proprietà dipenda dall’avverarsi di una condizione sospensiva o risolutiva, bensì, in base a un collegamento funzionale tra il trasferimento della proprietà ed il mancato adempimento di un obbligo scaturente da un preesistente rapporto di debito. La distinzione tra condizione risolutiva di adempimento e sospensiva di inadempimento non persuade, poiché i due fenomeni sono, in sostanza, gli stessi: nel primo caso, il trasferimento avviene con l’inadempimento dell’obbligazione, nel secondo diventa definitivo al verificarsi di quel momento.
L’evoluzione giurisprudenziale: l’accoglimento delle critiche dottrinali
La giurisprudenza di legittimità ha accolto le critiche dottrinali al precedente orientamento, inaugurando un nuovo filone interpretativo. Ha affermato la nullità, per violazione dell’art. 2744 c.c., di tutte le ipotesi di vendita poste in essere a scopo di garanzia. L’intento elusivo del divieto di patto commissorio emerge ogniqualvolta le diverse pattuizioni siano tra loro interdipendenti e funzionalmente preordinate alla realizzazione di una garanzia, anziché a uno scambio effettivo.
Patto commissorio e assetto negoziale complesso
La violazione dell’art. 2744 c.c. può ravvisarsi anche quando il patto commissorio non risulti da un singolo contratto, ma da più negozi tra loro collegati. È sufficiente che l’assetto di interessi complessivo evidenzi che il trasferimento del bene persegua, in concreto, uno scopo di garanzia. Ciò vale indipendentemente dalla natura obbligatoria o reale del contratto, dalla tempistica dell’effetto traslativo o dagli strumenti negoziali utilizzati.
Anche il patto di riscatto può integrare una fattispecie commissoria
In questo solco interpretativo, anche la vendita con patto di riscatto stipulata a scopo di garanzia è nulla. La causa apparente di scambio viene meno a fronte della finalità reale di garanzia, che assume rilievo dirimente nell’accertamento dell’illiceità.
La causa concreta come parametro di liceità
Secondo la giurisprudenza più recente e la dottrina maggioritaria, le alienazioni a scopo di garanzia si configurano come un collegamento negoziale, funzionale e genetico, tra un contratto di mutuo e un contratto di vendita. La causa concreta dell’intera operazione consiste nella garanzia di un credito, non nello scambio. Tale ricostruzione consente di accertare l’illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 c.c., trattandosi di contratto in frode alla legge volto a eludere una norma imperativa, l’art. 2744 c.c.
Dibattito dottrinale sulla qualificazione della nullità
Non manca, tuttavia, un contrasto dottrinale sul fondamento della nullità. Alcuni autori ritengono preferibile ricondurla all’art. 1343 c.c., trattandosi di contratto contrario a norma imperativa, piuttosto che in frode alla legge.
Secondo un primo orientamento, se la stipulazione manifesta apertamente la natura commissoria dell’operazione, l’elusione è palese. In tal caso, il contratto è nullo per causa illecita, senza necessità di ricorrere allo schema della frode. Al contrario, qualora le parti celino l’intento di garanzia dietro accordi simulatori, l’indagine dovrà seguire le logiche proprie della frode alla legge. Si tratterà, in questi casi, di una simulazione fraudolenta costruita mediante negozi apparentemente leciti.
Orientamenti alternativi e superamento dell’art. 1344 c.c.
Un diverso orientamento, invece, valorizza la nozione di causa in concreto fino a giungere a una sostanziale disapplicazione dell’art. 1344 c.c. In base a tale impostazione, si può ravvisare la contrarietà diretta del contratto alla legge anche in assenza di meccanismi simulatori.
La sorte del contratto collegato: mutuo e vendita
Un’ulteriore questione riguarda l’estensione della nullità dal contratto di vendita a quello da cui origina il credito garantito. La giurisprudenza di legittimità, facendo leva sul concetto di collegamento negoziale, ritiene che i contratti coinvolti siano legati da un nesso di reciproca dipendenza. Pertanto, la nullità, inefficacia o risoluzione di uno di essi si riflette sull’intera operazione. Si applica, in tal caso, l’art. 1419 c.c., secondo cui la nullità di una clausola o parte essenziale può travolgere l’intero contratto.
Nullità estesa al mutuo: presupposti e conseguenze
Alla luce di quanto sopra, si conclude che nelle alienazioni a scopo di garanzia anche il contratto di mutuo è nullo. Il creditore, infatti, eroga la somma solo in presenza della garanzia rappresentata dal trasferimento fittizio del bene. Il collegamento funzionale e causale tra mutuo e vendita impone di considerare l’intera operazione viziata dalla medesima illiceità, riconducibile all’intento commissorio vietato dalla legge.
Il contratto di sale and lease back e il rischio di elusione
In tale contesto, si inserisce la questione relativa al contratto di sale and lease back o vendita con leasing di ritorno: si tratta di un contratto con cui il proprietario di un bene che vuole continuare ad utilizzare per lo svolgimento, ad esempio, della sua attività produttiva, vende detto bene all’acquirente che, contemporaneamente glielo concede in leasing. In virtù di tale complessa operazione, l’utilizzatore-venditore paga all’acquirente-concedente i canoni periodici e, alla scadenza del periodo pattuito, può esercitare il diritto di opzione sul bene, scegliendo di acquistare la proprietà attraverso il pagamento di una somma differenziale.
La giurisprudenza ritiene che la vendita con leasing di ritorno sia un contratto lecito in quanto strumento, attraverso il quale, le parti, ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c., possono perseguire interessi meritevoli di tutela realizzando uno scopo di finanziamento, senza che il venditore debba privarsi della disponibilità del bene. Tuttavia, lo schema si presta ad essere utilizzato per ottenere un risultato analogo a quello ricadente nel divieto di patto commissorio: l’operazione, in concreto, posta in essere, infatti, può essere funzionale a perseguire uno scopo di garanzia e non di mero finanziamento, come nel caso in cui la vendita sia collegata ad un preesistente contratto di mutuo del quale si intende garantire l’adempimento.
A fronte di autorevole dottrina che ravvisa la nullità dei contratti di sale and lease back in quanto, nella pratica, diretti a realizzare un intento commissorio, la giurisprudenza recente, invece, al fine di effettuare un’indagine sul concreto scopo perseguito dei contraenti, ha elaborato una serie di indici rivelatori ai quali ricorrere per valutare l’operazione nel suo complesso (ne abbiamo parlato qui).
Conclusioni: la causa in concreto come strumento di legalità
L’analisi delle alienazioni a scopo di garanzia conferma l’utilità della teoria della causa in concreto quale criterio ermeneutico per distinguere le operazioni lecite da quelle elusive. L’indagine sull’effettiva funzione economico-individuale dell’operazione permette di smascherare i fenomeni di frode alla legge e di ristabilire l’equilibrio tra autonomia contrattuale e limiti ordinamentali, confermando la centralità della causa quale parametro di legalità sostanziale del contratto.












