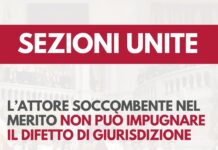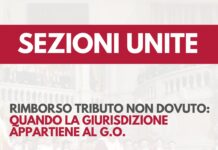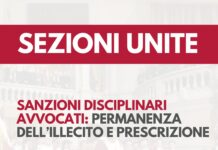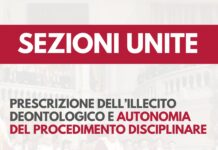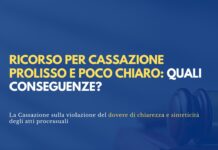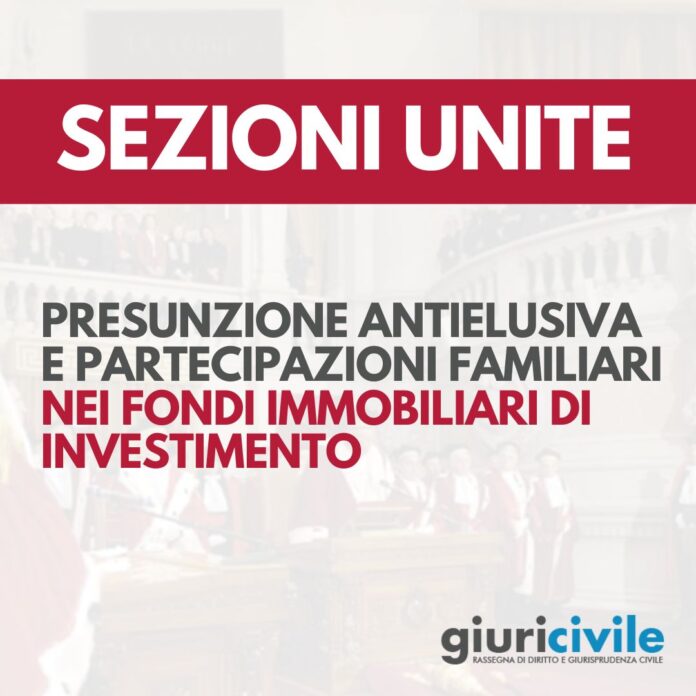
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 30657/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si sono pronunciate in materia di tassazione delle partecipazioni ai fondi immobiliari di investimento. La questione oggetto di contrasto, rimessa dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 32384 del 2024 (alla quale avevamo già dedicato un approfondito commento), riguardava la corretta applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 32 del Decreto-Legge n. 78/2010 e, in particolare, la rilevanza del vincolo familiare ai fini del superamento della soglia del 5%.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, segnaliamo il volume “Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il caso: imposta sostitutiva sui fondi immobiliari e partecipazioni “familiari”
Come anticipato, all’analisi del caso e all’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite avevamo già dedicato un approfondito commento (che puoi leggere cliccando qui). Per una maggiore chiarezza, tuttavia, ricapitoliamo insieme le fasi principali dell’iter processuale, fino al ricorso in Cassazione.
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva del 5% prevista per il 2011 dall’art. 32, comma 4-bis, d.l. 78/2010, formulata da due contribuenti, legati da rapporti di parentela (padre e figlio), i quali detenevano partecipazioni in fondi immobiliari alla data del 31 dicembre 2010.
Dinanzi al silenzio dell’Amministrazione finanziaria, i contribuenti adivano la Commissione tributaria provinciale, sostenendo che, essendo titolari di quote inferiori al 5%, non fossero soggetti all’imposizione. L’Agenzia delle Entrate replicava che la sommatoria delle partecipazioni dei due familiari superava la soglia rilevante, rendendo operativa la disciplina dell’imposta sostitutiva.
La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo irrilevante il cumulo delle quote in quanto i contribuenti non convivevano. La CTR confermava integralmente la decisione, fondando l’esclusione dell’imposta sulla diversa residenza dei familiari.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione per violazione dell’art. 32, comma 3-bis, d.l. 78/2010 e per errata applicazione della disciplina transitoria. La Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 32384/2024, rimetteva la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto interno circa la natura della presunzione sui familiari e la possibilità di superarla mediante elementi formali, quali la non convivenza.
Le Sezioni Unite, dunque, erano chiamate a risolvere le seguenti questioni interpretative:
- la natura della presunzione e l’onere probatorio correlato;
- la legittimità della disciplina transitoria che collega l’imposta 2011 alle quote detenute nell’anno precedente.
Il quadro normativo di riferimento e la ratio della disciplina
Le Sezioni Unite hanno ricostruito, in primo luogo, il contesto regolatorio dei fondi comuni di investimento immobiliare, richiamando le finalità perseguite dal legislatore del 2010: evitare l’utilizzo distorto dei fondi come strumenti di amministrazione di patrimoni personali o familiari, e non come strumenti di gestione collettiva del risparmio. Le fonti richiamate, dalla segnalazione della Banca d’Italia del 2005 alla giurisprudenza costituzionale, mostrano come si fosse diffusa la pratica di creare fondi immobiliari “a ristretta base partecipativa”, con conferimento di immobili e detenzione delle quote da parte di pochi soggetti legati da stretti vincoli familiari.
In tale contesto si inserisce l’art. 32 d.l. 78/2010, che distingue tra investitori istituzionali e non istituzionali, e soprattutto individua, per questi ultimi, il concetto di “partecipazione qualificata” al superamento della soglia del 5%. A tal fine, il comma 3-bis impone il cumulo delle partecipazioni detenute tramite società controllate, fiduciarie o interposte persone nonché, secondo il quinto periodo, delle partecipazioni dei familiari indicati dall’art. 5 TUIR.
La questione controversa: la natura della presunzione sui familiari
Il contrasto giurisprudenziale riguardava il significato da attribuire alla previsione secondo cui, per verificare il superamento del 5%, “si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari”. Una parte della giurisprudenza aveva letto tale norma come presunzione relativa superabile mediante elementi quali la diversa residenza dei familiari; altra giurisprudenza l’aveva considerata una presunzione rigida, di fatto tendenzialmente assoluta.
Le Sezioni Unite hanno rigettato entrambe le soluzioni estreme. Da un lato, hanno escluso che la norma configuri una presunzione assoluta: la mancanza di un espresso divieto di prova contraria e il favor ordinamentale per le presunzioni relative inducono a ritenere ammissibile la prova dell’assenza di finalità elusiva. Dall’altro lato, la Corte ha respinto l’idea che circostanze formali (come residenza o convivenza) siano idonee a vincere la presunzione, poiché estranee all’effettivo contenuto economico dell’operazione.
La presunzione si inserisce, infatti, in una logica unitaria: quella di intercettare la “fittizia frammentazione” delle quote tra soggetti legati da un rapporto tipicamente connotato da informalità gestionale e comunanza di interessi. Per tale ragione, la norma non si limita a richiamare il concetto di “interposta persona” (come nel caso delle società controllate), poiché la detenzione indiretta è già fisiologicamente insita nei rapporti familiari ritenuti rilevanti.
L’onere della prova e gli indici per superare la presunzione
Stabilito che la presunzione è relativa, le Sezioni Unite hanno individuato l’oggetto della prova contraria, ancorato alla finalità propria della norma antielusiva: evitare che i fondi immobiliari fungano da schermo per patrimoni familiari unitari.
La prova contraria grava sul contribuente e deve riguardare la effettività e autonomia della singola partecipazione. Non rilevano elementi formali come la diversa residenza o lo stato di famiglia; al contrario, occorre dimostrare:
- l’origine autonoma dell’investimento, mediante tracciabilità della provvista e assenza di finanziamenti occulti da altri familiari partecipanti;
- la destinazione personale dei proventi, valutando tanto l’accredito iniziale quanto le successive movimentazioni;
- l’autonomia nelle scelte di investimento, che, pur non riguardando la gestione del fondo (riservata alla SGR), attiene alle decisioni dell’investitore su acquisto, mantenimento, movimentazione o dismissione delle quote.
La Suprema Corte ha sottolineato che la verifica deve essere condotta in concreto dal giudice di merito, cui spetta valutare se la pluralità degli indici forniti renda effettivamente superata la presunzione di unitarietà patrimoniale familiare.
La disciplina transitoria dell’imposta sostitutiva e i profili di legittimità costituzionale
La seconda parte della pronuncia affronta le censure relative alla transitorietà dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma 4-bis dell’art. 32 per l’anno 2011. Le Sezioni Unite hanno escluso che essa abbia natura retroattiva: l’imposta riguarda il 2011, pur prendendo a riferimento una situazione preesistente (le quote possedute al 31 dicembre 2010). L’intervento legislativo è stato ritenuto pienamente ragionevole in quanto necessario per traghettare il sistema dal precedente regime di tassazione “per cassa” al nuovo regime “per trasparenza”.
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2015, la Cassazione ha ricordato che l’eliminazione della norma transitoria avrebbe comportato un’irragionevole “zona franca” di esenzione, in contrasto con i principi di capacità contributiva e uguaglianza. Vengono poi esclusi profili di incompatibilità con il diritto UE o con la CEDU, trattandosi di materia di imposizione diretta sottratta alla competenza unionale e caratterizzata da un ampio margine discrezionale degli Stati.
Il principio di diritto
La Sezioni Unite hanno concluso, quindi, formulando il seguente principio di diritto:
«In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l’art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010, ha una finalità antielusiva ed integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l’applicazione. A tal fine, la parte ha l’onere di provare l’effettività e l’autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l’originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l’autonomia delle scelte sull’an e sul quomodo dell’investimento».