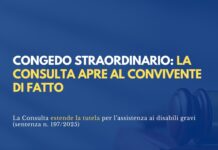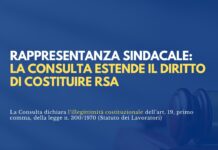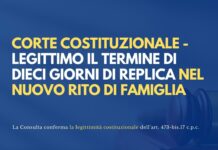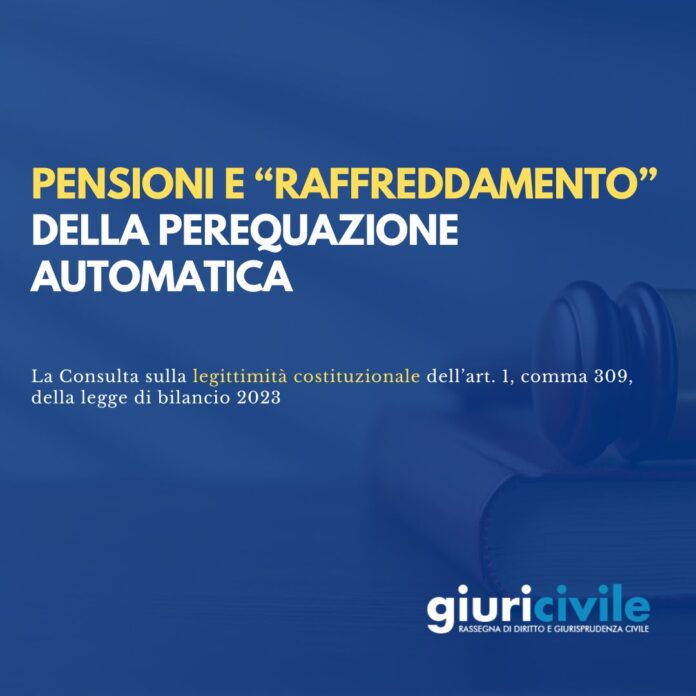
La Consulta, con la sentenza n. 167/2025 (che puoi leggere cliccando qui), si è pronunciata nuovamente sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge di bilancio 2023, che ha introdotto un meccanismo di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni. La questione era stata di recente analizzata dalla Corte con la sentenza n. 19/2025, ma il giudice rimettente riteneva sussistenti ulteriori profili di incostituzionalità, legati alla natura tributaria del taglio e alla presunta reiterazione irragionevole di misure eccezionali.
Consiglio: per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, Maggioli Editore ha organizzato il corso di formazione “Corso avanzato di diritto del lavoro – Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni”, a cura di Federico Torzo (clicca qui per iscriverti).
La questione di legittimità costituzionale sollevata
Il giudizio trae origine dal ricorso di ventiquattro ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza, i quali chiedevano il riconoscimento della rivalutazione piena del trattamento pensionistico secondo il meccanismo ordinario previsto dall’art. 1, comma 478, legge n. 160/2019. Tale disciplina era stata derogata dal comma 309 della legge n. 197/2022, che per il 2023 prevedeva un adeguamento integrale solo per le pensioni fino a quattro volte il minimo INPS, applicando percentuali ridotte – via via decrescenti – ai trattamenti superiori.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione:
-
dell’art. 53 Cost., ritenendo la norma un prelievo tributario selettivo e discriminatorio;
-
dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), lamentando la continua reiterazione di misure eccezionali che, secondo il rimettente, avrebbero perso ogni carattere di temporaneità.
La natura non tributaria del meccanismo di rivalutazione ridotta
La Corte Costituzionale ha chiarito, innanzitutto, che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione non integra una prestazione patrimoniale imposta. Non vi è infatti alcuna decurtazione del trattamento pensionistico: l’assegno non diminuisce, ma cresce semplicemente in misura inferiore rispetto al regime ordinario. Questo aspetto esclude l’esistenza di un prelievo ablatorio a carico dei beneficiari.
A ciò si aggiunge che la misura non determina un aumento di risorse destinate alla fiscalità generale. Il risparmio derivante dalla minore rivalutazione resta confinato nelle gestioni previdenziali dell’INPS e non affluisce alle finanze statali. L’intervento legislativo, pertanto, non può essere qualificato come tributo, mancando uno degli elementi essenziali della fattispecie tributaria: la destinazione delle risorse a spese pubbliche generali.
La Corte ha evidenziato anche che la norma non incide sul rapporto sinallagmatico sottostante alla pensione, che conserva la propria natura previdenziale. Da ciò deriva l’assenza di una violazione dell’art. 53 Cost., poiché non si è in presenza di un prelievo selettivo basato sulla capacità contributiva.
Potrebbero interessarti anche:
- Calcolo pensionistico e riscatto degli anni di laurea
- Riforma del sistema pensionistico per gli avvocati dal 2025
- Ritenute previdenziali non versate: perché il termine di 90 giorni è decisivo
La reiterazione delle misure e i limiti della ragionevolezza
Un secondo profilo affrontato dalla Consulta riguarda la presunta irragionevole reiterazione delle misure di contenimento della perequazione. Il giudice rimettente aveva richiamato precedenti che sottolineavano il carattere eccezionale di tali interventi. Tuttavia, la Corte distingue tra un vero e proprio “blocco” della rivalutazione, suscettibile di generare tensioni con i principi di proporzionalità, e un semplice rallentamento temporaneo, come quello oggetto del giudizio.
Il meccanismo del comma 309, infatti, non sospende la rivalutazione, ma la riduce in modo graduale e proporzionato in relazione all’importo della pensione. La struttura della norma – che mantiene l’adeguamento pieno per i trattamenti più bassi e modulato per quelli più elevati – riflette un bilanciamento ragionevole tra esigenze finanziarie e tutela del potere d’acquisto.
La Corte ha sottolineato, inoltre, che le giustificazioni economiche alla base della misura emergono in modo chiaro dalle relazioni che hanno accompagnato la legge di bilancio. Ciò conferma la piena legittimità della scelta legislativa e l’assenza del carattere patologico nella reiterazione, che resta nei limiti della discrezionalità del legislatore.
Il profilo dell’uguaglianza e l’assenza di discriminazioni
La Corte Costituzionale ha affrontato, anche, il tema della presunta disparità di trattamento tra diverse categorie di pensionati. Viene chiarito che la disposizione richiama l’art. 34 della legge n. 448/1998, il quale estende il meccanismo perequativo a tutte le gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria, comprese quelle relative ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. L’esclusione ipotizzata dal giudice rimettente non trova quindi riscontro nel dettato normativo.
Quanto al raffronto con i lavoratori in servizio, la Consulta ha osservato che i sistemi di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni rispondono a logiche differenti e non sono comparabili ai fini del giudizio di eguaglianza. Ne deriva che non sussiste alcuna discriminazione ai sensi dell’art. 3 Cost., poiché le situazioni messe a confronto non sono omogenee e non richiedono una disciplina identica.
Conclusioni
La sentenza conferma l’impianto già tracciato dalla sentenza n. 19/2025: il legislatore mantiene un margine di discrezionalità nella modulazione della perequazione, che può essere temporaneamente ridotta purché non si giunga alla sospensione totale del meccanismo e siano rispettati i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.