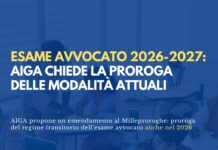La Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 30133 del 14 novembre 2025 (che puoi leggere cliccando qui), si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 2437, comma 1, del codice civile, il quale riconosce il diritto di recesso al socio che “non ha concorso alle deliberazioni”. La decisione affronta il quesito sulla portata del termine normativo “concorso” nel contesto di operazioni societarie articolate in plurime fasi e tra loro inscindibilmente collegate.
La Corte di legittimità ha rilasciato un principio di diritto statuendo che, in presenza di un’operazione complessa, il “concorso” non si esaurisce nel solo voto esplicitato in ambito assembleare finale, bensì si estende all’intera gamma degli atti preparatori e necessari, realizzati dal socio, precludendo il diritto di recesso a chi abbia concorso ab origine alla realizzazione dell’operazione, pure se assente, dissenziente, ovvero astenuto, alla delibera conclusiva. Il provvedimento rafforza il trend ermeneutico secondo cui la norma debba essere letta in ottica non meramente formalistica, bensì funzionale, a tutela della buona fede e contro l’esercizio opportunistico del diritto di exit.
Asset normativo del diritto di recesso
Il diritto di recesso del socio nelle società di capitali, specie nel contesto delle società per azioni (S.p.A.), ha subito una rivisitazione tramite la riforma del diritto societario di cui al D.lgs. n. 6/2003. L’intento del legislatore delegato era chiaro: ampliare le ipotesi di recesso legale e statutario, conferendo al socio una maggiore possibilità di disinvestimento (exit) in replica a modifiche strutturali ovvero statutarie che alterassero in modo significativo l’assetto e l’indole dell’investimento originario.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
L’obiettivo era duplice: tutelare la minoranza e incentivare l’investimento, garantendo che le condizioni di exit non potessero essere ridotte unilateralmente. Tra gli aspetti maggiormente di rilievo della riforma è emersa la sostituzione della locuzione “soci dissenzienti” (prevista dall’art. 2437 c.c. previgente) con la formula “soci che non hanno concorso alle deliberazioni” di cui al novellato art. 2437, comma 1, c.c. Modifica siffatta ha ampliato la platea dei legittimati attivi all’esercizio del recesso, includendo non solo i dissenzienti, ma pure gli assenti e gli astenuti. Tuttavia, il significato del termine “concorso” è rimasto un focus per il dibattito giuridico.
L’interpretazione tradizionale, sostenuta in via esclusiva dalle parti ricorrenti nel caso di specie, tende a limitare il “concorso” alla sola manifestazione di voto in assemblea. Al contrario, un orientamento dottrinale e giurisprudenziale (ora avallato dalla Suprema Corte) ha ritenuto che il termine, per la sua intrinseca valenza semantica di “contribuire, compartecipare, collaborare, cooperare”, potesse e dovesse estendersi a condotte poste in essere prima dell’assemblea, specialmente in contesti operativi complessi. La Cassazione, col pronunciamento in disamina, interviene per sciogliere in via nomofilattica il nodo interpretativo.
Contesto fattuale
Il caso giunto all’esame della Corte di Cassazione è emblematico dell’esigenza di superare un approccio puramente formalistico. La controversia origina da una complessa operazione di risanamento e integrazione tra gruppi societari, innescata da un Accordo di Investimento siglato nel gennaio 2012 tra la società incorporante (S.p.A., holding di un gruppo) e la holding del gruppo in crisi (Gruppo).
Il Progetto di Integrazione per Fusione, da realizzarsi mediante incorporazione in S.p.A., era stato concepito come un unicum inscindibile, funzionale a un rafforzamento patrimoniale essenziale per il rispetto dei vincoli di solvibilità e per scongiurare procedure concorsuali. L’operazione prevedeva, quale presupposto essenziale e inscindibile della Fusione, un Aumento di Capitale Riservato in S.p.A. che permise alla futura incorporante di assumerne il controllo di diritto (circa l’81% del capitale sociale).
Le parti che hanno in seguito esercitato il recesso – diverse società di diritto lussemburghese che facevano capo alla famiglia di controllo del Gruppo – avevano rivestito ruoli apicali nel Consiglio di amministrazione e avevano concorso in modo determinante all’avvio e alla realizzazione del Progetto di Integrazione, in particolare votando a favore della delibera di Aumento di Capitale Riservato. Tuttavia, alla successiva e finale delibera di fusione del 2013, le medesime società si astennero o furono assenti, inviando immediatamente dopo le dichiarazioni di recesso.
Decisioni di merito
Il Tribunale in primo grado, e successivamente la Corte di Appello, hanno respinto la domanda di recesso, accertando che i soci avevano, di fatto, concorso alla delibera di fusione. In particolare, la Corte d’Appello aveva esplicitamente sostenuto l’interpretazione estensiva di “concorso”, ritenendo che l’esercizio del recesso in tali circostanze si ponesse in contrasto con le finalità della legge (la tutela della minoranza) e costituisse un comportamento opportunistico in violazione dei principi di correttezza e buona fede (il cd. venire contra factum proprium).
Per la Corte territoriale consentire il recesso a soci di controllo che avevano contribuito in maniera causale e determinante all’operazione in plurime fasi per, in seguito, dissociarsene formalmente, “sarebbe effettivamente in contrasto con le finalità della legge”.
Interpretazione funzionale del “non concorso”
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 2437, comma 1, c.c. in relazione al principio del non concorso, ha rigettato i ricorsi dei soci recedenti, avallando la lettura funzionale del dettato normativo. L’importanza della sentenza risiede nell’enunciazione di un principio di diritto biforcato, che distingue tra la delibera assembleare isolata e l’operazione societaria complessa.
Potrebbero interessarti anche:
- Il recesso del socio nelle S.p.A.: effetti immediati o differiti?
- Il diritto di esclusione del socio si prescrive dopo cinque anni
- La sorte dei crediti dopo la cancellazione della società: le Sezioni Unite
La distinzione tra fattispecie “puntuale” e “complessa”
La Cassazione afferma in primo luogo che la locuzione “non hanno concorso alle deliberazioni” deve certamente riferirsi alle fattispecie in cui la “deliberazione” costituisca un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo. In tale ipotesi, il diritto di recesso spetta indubbiamente a tutti i soci che, rispetto a quell’atto, non abbiano espresso la propria volontà favorevole: l’assente, il dissenziente e l’astenuto.
In questo contesto, rileva la sola posizione assunta in assemblea, escludendo rilevanza a dichiarazioni fatte in sede extra-assembleare. Tuttavia, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione specifica che l’art. 2437, comma 1, c.c. si applica anche a situazioni in cui la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, “composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale”.
Concorso funzionale nelle operazioni inscindibili
È in questa seconda ipotesi, la fattispecie complessa, che il concetto di “concorso” assume una valenza più ampia, temporale e funzionale, rispetto all’espressione del mero voto formale. Il Collegio ha ritenuto che, se l’oggetto della delibera finale era conosciuto ab origine dai soci che avevano concorso agli atti preparatori, necessari e inscindibili, non è più possibile per tali soci invocare l’art. 2437, comma 1, c.c. per esercitare il recesso.
Il recesso viene precluso non in forza di un mero assenso preventivo o di una dichiarazione di intenti generica, ma in virtù di una compartecipazione attiva, consapevole e causalmente determinante all’intero iter che ha portato alla delibera finale. Il principio si fonda sulla necessità di evitare che il diritto di recesso diventi strumento di pratiche opportunistiche, in cui un socio di controllo o di riferimento possa “prima concorrere in modo determinante… all’assunzione… di tutte le deliberazioni volte all’avvio ed alla realizzazione del Progetto… e, poi, cercare di dissociarsene non partecipando alla deliberazione”.
La Cassazione, pur respingendo le tesi che identificavano il fondamento dell’esclusione del diritto di recesso esclusivamente nella violazione della buona fede o nel divieto di venire contra factum proprium (che sono questioni di merito non più dibattibili in Cassazione, a meno di una loro specifica impugnazione), ha di fatto riaffermato la rilevanza di questi principi per l’interpretazione sostanziale del “non concorso”.
I principi di diritto
Il comportamento pregresso del socio, sebbene non direttamente rilevante per la singola delibera puntuale, assurge a “fatto giuridico” rilevante ai fini della valutazione del “concorso” quando costituisca parte integrante di un’operazione inscindibile. In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito i seguenti principi di diritto:
- Interpretazione dell’art. 2437, comma 1, c.c.: la norma si riferisce sia alla deliberazione considerata in sé stessa (fatto puntuale), sia all’ultimo atto di un’operazione complessa di atti inscindibilmente collegati.
- Deliberazione puntuale: il diritto di recesso spetta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti.
- Operazione complessa: il diritto di recesso è escluso per i soci che abbiano concorso agli atti preparatori e necessari, il cui esito (la delibera finale) fosse noto ab origine, anche se formalmente assenti, dissenzienti o astenuti alla delibera conclusiva.
Impatti
La sentenza in disamina segna un punto fermo nell’interpretazione dell’art. 2437, comma 1, c.c., inquadrando il diritto di recesso in una prospettiva non solo formale, ma anche sostanziale e teleologica. Il principio enunciato presenta profonde implicazioni per il diritto societario, in particolare per le operazioni di ristrutturazione aziendale e di finanza straordinaria (come fusioni, scissioni e aumenti di capitale complessi).
Il Giudice di legittimità chiarisce che il diritto di recesso, sebbene inteso a tutelare il socio di fronte a mutamenti radicali del contratto sociale, non può essere utilizzato come un’arma opportunistica, specialmente da parte di soci che, con la loro azione o inazione nelle fasi preparatorie, abbiano di fatto consentito la realizzazione dell’evento scatenante il recesso.
La pronuncia, di fatto, mitiga l’applicazione puramente letterale del “non concorso” in favore di una valutazione complessiva della condotta del socio, ponendo un freno all’esercizio strumentale del diritto di exit da parte di soci di controllo o di riferimento che abbiano attivamente partecipato alla pianificazione e all’esecuzione di un’operazione societaria indivisibile.
La Cassazione riconosce la necessità di proteggere le minoranze dall’abuso della maggioranza, ma, al contempo, tutela la società e gli altri soci dalla slealtà e dall’incoerenza dei comportamenti dei key stakeholders.
Conclusioni
Il discrimen operativo essenziale per i pratici del diritto risiede, pertanto, nella verifica dell’inscindibilità e del nesso causale tra gli atti preliminari e la delibera finale. Quando un’operazione è strutturata in modo tale che il voto (o la compartecipazione attiva) ad un atto preliminare sia il presupposto necessario, causale e conosciuto ab origine per l’atto finale che dà luogo al recesso, la Cassazione stabilisce in modo inequivocabile che il “concorso” si considera realizzato in via funzionale, precludendo l’esercizio del diritto di recesso.
Si tratta di un’affermazione di principio che rafforza il ruolo della buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.) e del divieto di abuso del diritto nel diritto societario, elementi che, pur non essendo il perno diretto dell’interpretazione testuale dell’art. 2437 c.c., ne influenzano profondamente l’applicazione pratica nei complessi scenari della governance societaria moderna.