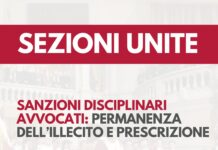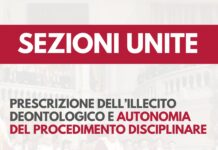Dalla pubblicazione nel 2008 del White Paper di Bitcoin, ad opera dell’imperscrutabile figura di Satoshi Nakamoto, il fenomeno della digitalizzazione e, più in generale, l’uso ipertrofico della tecnologia, si è imposto così rapidamente da plasmare le differenti conduzioni di vita degli individui, giungendo ad inventare nuovi sistemi di vita (ormai, quasi tutti) omologati.
Lo snellimento delle procedure, la fruizione di nuove applicazioni operative, la creazione di strumenti capaci di incidere sulle canoniche dimensioni della fisica, solo per citare alcuni esempi, rappresentano senza indugio gli ambiti nei quali l’innovazione tecnologica ha segnato un cambio di rotta netto e comprovato. Ma come sempre accade, ciò che è “nuovo” porta con sé l’esposizione al rischio di ciò che non può essere previsto proprio perché sconosciuto, obbligando alla ricerca di soluzioni protettive necessitate.
Quanto premesso, è accaduto con la tecnologia Distributer Ledger Technology (DLT) e la sua applicazione derivata più consistente: le cripto – attività.
Il presente elaborato, dunque, si pone l’obiettivo di indagare il fenomeno delle rappresentazioni digitali, dall’analisi del database blockchain fino alla regolamentazione fiscale della Legge di Bilancio 2026 rivolta ai token ancorati all’euro.
Tecnologia DLT e blockchain
Definizione e principi generali della DLT
L’analisi delle cripto-attività richiede preliminarmente l’inquadramento della Distributed Ledger Technology (DLT), ossia la tecnologia che consente la registrazione e la conservazione di dati all’interno di archivi denominati ledger, distribuiti e condivisi tra una rete di computer detti nodi.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Tale sistema consente di realizzare un registro digitale condiviso, in cui ogni partecipante dispone di una copia aggiornata e sincronizzata delle informazioni, garantendo trasparenza, tracciabilità e immutabilità dei dati.
Evoluzione del modello: dal ledger centralizzato a quello distribuito
L’attuale configurazione della DLT rappresenta l’evoluzione di due modelli originari:
-
Centralized ledger, basato su un unico soggetto o server centrale che gestisce la registrazione dei dati;
-
Decentralized ledger, che prevede invece nodi autonomi, ciascuno dotato di un proprio registro locale.
La DLT supera entrambi i modelli, eliminando la necessità di un’autorità centrale di verifica e validazione: le operazioni sono controllate collettivamente dai nodi della rete, che condividono e confermano le transazioni secondo regole prestabilite.
Modelli partecipativi: permissionless e permissioned
In base alla configurazione della rete e alle modalità di accesso e validazione, si distinguono due macro-modelli di DLT:
-
Permissionless ledger, aperto a tutti i partecipanti che possiedono i requisiti tecnici per interagire con la rete;
-
Permissioned ledger, nel quale la validazione è riservata a un numero limitato di nodi considerati trusted.
Quando il controllo è affidato a un solo validatore, la rete è definita privata; se, invece, la validazione è condivisa tra più soggetti, si parla di consortium DLT.
Dalla DLT alla Blockchain
L’evoluzione ulteriore della DLT è rappresentata dalla tecnologia a blocchi, ossia la blockchain.
Introdotta nel 1991 per assicurare la marcatura temporale (timestamping) dei documenti digitali, la blockchain ha assunto rilevanza globale con l’associazione alla criptovaluta Bitcoin, tanto da essere comunemente denominata “blockchain di Bitcoin”.
Struttura e funzionamento della blockchain
La blockchain è un database decentralizzato e distribuito, formato da una catena di blocchi collegati in sequenza tramite funzioni crittografiche.
Ogni blocco contiene:
-
l’hash identificativo;
-
l’index (numero progressivo del blocco);
-
il timestamp (data e ora di creazione);
-
l’hash code del blocco precedente.
La connessione di ogni blocco al precedente crea una catena crittograficamente sigillata: l’alterazione di un singolo blocco comprometterebbe l’intera sequenza, garantendo così l’immodificabilità delle informazioni.
Applicazione al sistema Bitcoin
Nel sistema Bitcoin, le transazioni degli utenti vengono validate da specifici nodi detti miners (validatori).
Un blocco viene generato quando si individua un codice hash che riassume tutte le transazioni contenute al suo interno; la creazione di ciascun blocco avviene mediamente ogni dieci minuti e la sua dimensione non può superare i 2 MB.
Il calcolo dell’hash, che richiede elevata potenza computazionale, è remunerato con un compenso in Bitcoin a favore del miner che completa per primo il processo.
Il meccanismo di consenso: Proof of Work
La validazione dei blocchi nella blockchain di Bitcoin si fonda sull’algoritmo di consenso denominato Proof of Work (PoW).
Questo meccanismo impone ai nodi partecipanti di risolvere un complesso problema crittografico per verificare la legittimità di una nuova transazione. Una volta trovato l’hash corretto, la proposta di blocco viene sottoposta al controllo della maggioranza dei nodi della rete.
Solo dopo la validazione collettiva il blocco è aggiunto in modo permanente alla catena, completando il processo e attribuendo la ricompensa al miner.
Sintesi del processo di creazione del blocco
In sintesi, la creazione di un nuovo blocco nella blockchain di Bitcoin segue le seguenti fasi:
-
Raggruppamento delle transazioni fino a un massimo di 2 MB.
-
Calcolo del codice hash da parte dei nodi (mining).
-
Creazione del blocco contenente le informazioni validate.
-
Condivisione del blocco nella rete e verifica della sua validità da parte della maggioranza dei nodi.
-
Inserimento definitivo del blocco nella catena e attribuzione del compenso al miner.
Classificazione delle cripto – attività
Premessa: la varietà del fenomeno
Nel corso del tempo sono state sviluppate numerose tipologie di cripto-attività, ciascuna in grado di offrire specifici vantaggi funzionali e, al contempo, di esporre gli investitori a differenti livelli di rischio.
La crescente eterogeneità del fenomeno ha reso necessario un tentativo di sistematizzazione, volto a definire in modo univoco la nozione giuridica e le categorie economiche di riferimento.
La definizione normativa nel Regolamento MiCAR
Il Regolamento (UE) 2023/1114, noto come Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), fornisce all’art. 3 una definizione generale di cripto-attività, qualificandola come:
“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito (DLT) o una tecnologia analoga.”
Tale definizione si distingue per la sua portata onnicomprensiva, in quanto include:
-
sia le cripto-attività utilizzate come strumenti di pagamento o investimento,
-
sia quelle che fungono da mezzo di rappresentazione e trasferimento di diritti su beni o servizi digitali.
La nozione MiCAR, pertanto, non si limita all’aspetto finanziario, ma riconosce la DLT come infrastruttura tecnologica idonea a supportare molteplici funzioni economiche e giuridiche.
Le principali categorie secondo la funzione economica
In ambito dottrinale e istituzionale, una prima distinzione si fonda sulla funzione economica svolta dalle cripto-attività.
Una tassonomia riconosciuta è quella delineata dall’EBA (European Banking Authority) nel Report with advice for the European Commission on crypto-assets del 2019, che individua tre tipologie fondamentali:
-
Utility token – strumenti che conferiscono al titolare il diritto di accedere a un bene o servizio digitale offerto dall’emittente.
-
Payment token – cripto-attività destinate principalmente a fungere da mezzo di scambio o pagamento.
-
Security token – rappresentazioni digitali di strumenti finanziari, che attribuiscono diritti di partecipazione o rendimento economico, analoghi a quelli dei titoli tradizionali.
Questa classificazione si basa dunque sulla funzione d’uso e sull’obiettivo economico perseguito dal token all’interno del mercato digitale.
La classificazione in base alla presenza di un collateral
Un secondo criterio classificatorio si fonda sulla presenza o meno di un’attività sottostante (collateral), che incide sulla stabilità e sul grado di rischio della cripto-attività.
In tale prospettiva si distinguono due sotto-categorie:
-
Unbacked crypto-asset – cripto-attività non garantite da alcun bene o attività reale. Il loro valore dipende esclusivamente dall’equilibrio tra domanda e offerta di mercato (es. Bitcoin).
-
Asset-linked stablecoin – cripto-attività il cui valore è ancorato a riserve o beni sottostanti, come valute legali, titoli o materie prime, al fine di mantenere una maggiore stabilità del prezzo.
Questa distinzione riveste particolare rilievo per la valutazione del rischio sistemico e per la definizione dei requisiti prudenziali previsti dal MiCAR.
L’emergere dei Non-Fungible Token (NFT)
Accanto alle categorie tradizionali, si è affermata una nuova tipologia di cripto-attività: i Non-Fungible Token (NFT).
Gli NFT si caratterizzano per la unicità e la non fungibilità, ossia l’impossibilità di essere scambiati alla pari con altri token identici.
Essi rappresentano un diritto digitale esclusivo, spesso associato a opere d’arte, contenuti multimediali o beni digitali unici, e si collocano in una posizione peculiare rispetto alle altre tipologie di token, poiché non assolvono una funzione monetaria ma piuttosto di certificazione e autenticità.
Payment Token e Legge di Bilancio 2026
Natura e funzione dei Payment Token
I payment token rappresentano la categoria più antica di token, nata con il progetto Bitcoin e con la creazione della relativa criptovaluta.
La loro peculiarità risiede nella funzione economica: a differenza degli utility token o degli investment token, non attribuiscono diritti specifici ai titolari, ma sono utilizzati come strumenti di scambio di beni o servizi, come mezzi di pagamento, nonché come forma di investimento o riserva di valore.
Le tre sottocategorie dei Payment Token
Per effetto della loro complessità funzionale, i payment token possono essere ulteriormente suddivisi in tre sottocategorie principali:
-
Valute virtuali “tradizionali”, come Bitcoin o Ether, il cui valore è determinato esclusivamente dall’incontro tra domanda e offerta sul mercato.
-
Stablecoin, ossia cripto-valute progettate per mantenere stabile il proprio valore rispetto a un singolo asset o a un paniere di attività sottostanti.
-
Central Bank Digital Currencies (CBDC), valute digitali emesse direttamente da Banche Centrali, che rappresentano un debito della banca nei confronti del detentore.
Questa tripartizione consente di distinguere le valute nate in ambito privato (Bitcoin, stablecoin) dalle versioni istituzionali (CBDC), in cui l’emittente è un soggetto pubblico con potere monetario.
L’inquadramento giuridico dei Payment Token
La qualificazione giuridica dei payment token rappresenta uno dei temi più complessi del diritto delle cripto-attività.
Un contributo rilevante in tal senso proviene dall’European Banking Authority (EBA), la quale, in presenza di determinate condizioni, ha riconosciuto la possibilità di equiparare il token di pagamento alla moneta elettronica, qualora venga utilizzato effettivamente come mezzo di pagamento.
Ai sensi della Direttiva 2009/110/CE, un token può essere considerato moneta elettronica solo se presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
-
è memorizzato elettronicamente;
-
possiede valore monetario;
-
costituisce credito nei confronti dell’emittente;
-
è emesso a fronte del ricevimento di fondi;
-
è emesso per l’esecuzione di pagamenti;
-
è accettato da soggetti diversi dall’emittente.
In presenza di tali condizioni, l’emittente del token è soggetto alle verifiche e autorizzazioni previste per gli istituti di moneta elettronica, con obblighi di trasparenza e vigilanza particolarmente stringenti.
Le novità della Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti disposizioni in materia di token ancorati all’euro (euro-backed token), sostenuti da riserve detenute presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
Gli interventi si concentrano su due macro-ambiti: la disciplina fiscale e l’istituzione di un Tavolo permanente di vigilanza.
1. Tassazione al 26% per i token in euro
L’art. 13 della bozza di Legge di Bilancio 2026 prevede che i redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro siano soggetti a un’aliquota ridotta del 26%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 33%.
Rientrano in tale regime i token:
-
il cui valore è stabilmente ancorato all’euro, e
-
i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso intermediari autorizzati nell’Unione Europea.
È inoltre previsto che la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, così come il rimborso in euro del valore nominale, non costituisca realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
La norma mira a incentivare l’uso di stablecoin ancorate all’euro, garantendo al contempo certezza fiscale e coerenza con il quadro MiCAR.
2. Il Tavolo permanente di controllo e vigilanza
Un secondo intervento di rilievo è l’istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, con funzione consultiva e di coordinamento tra le principali istituzioni nazionali.
Il Tavolo sarà composto da rappresentanti di:
-
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
-
Guardia di Finanza,
-
CONSOB,
-
Banca d’Italia,
-
Unità di informazione finanziaria (UIF).
Accanto agli organi istituzionali, potranno partecipare associazioni di categoria e esperti accademici, al fine di garantire un approccio aperto e interdisciplinare.
Ai membri del Tavolo non sono riconosciuti compensi o rimborsi, evitando nuovi oneri per la finanza pubblica.
Compiti e obiettivi del Tavolo permanente
Il Tavolo sarà chiamato a:
-
monitorare costantemente i rischi del settore delle cripto-attività;
-
definire una strategia nazionale di prevenzione di frodi, abusi e fenomeni di riciclaggio;
-
promuovere un protocollo di legalità contro il finanziamento del terrorismo;
-
redigere rapporti periodici sull’andamento del mercato e sulla tutela degli investitori;
-
sviluppare iniziative di educazione finanziaria, volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini sui nuovi strumenti digitali.
Considerazioni conclusive
L’introduzione del Tavolo permanente e l’allineamento della normativa nazionale al quadro MiCAR segnano una nuova fase nel rapporto tra ordinamento italiano e cripto-attività.
L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la vigilanza e la trasparenza del mercato; dall’altro, favorire l’innovazione tecnologica in un contesto normativo chiaro, coerente e competitivo.
Unisciti alla nostra comunità legale
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime notizie, analisi giuridiche e risorse esclusive direttamente nella tua casella di posta. Non perdere nessun aggiornamento importante nel campo del diritto civile. Iscriviti ora e resta informato!