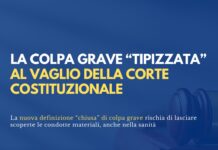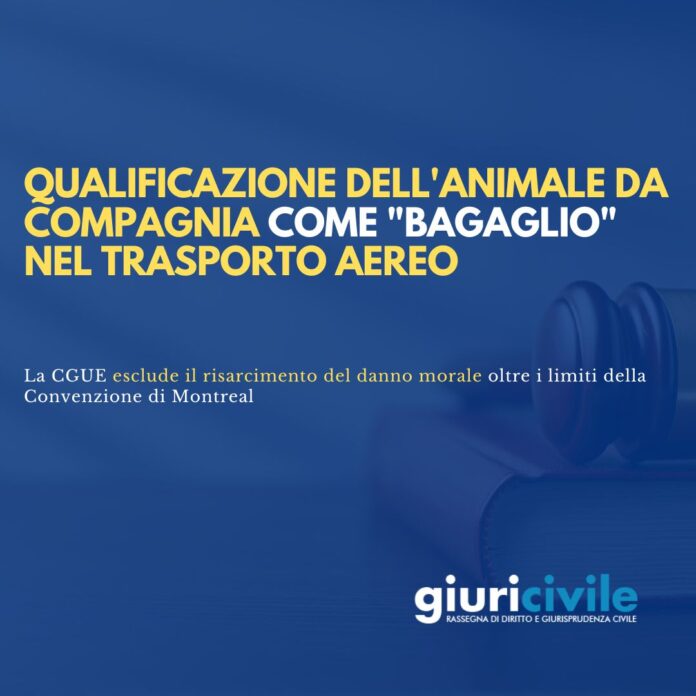
La crescente diffusione del trasporto aereo di animali da compagnia solleva questioni giuridiche complesse in caso di smarrimento, lesione o morte dell’animale. Il rapporto affettivo con il proprietario comporta richieste risarcitorie che superano il mero valore economico, includendo il danno morale. Tuttavia, la responsabilità del vettore aereo è rigidamente regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999. In questo quadro si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-218/24, Felicísima c. Iberia, 16 ottobre 2025), chiamata a chiarire se l’animale da compagnia debba essere considerato “bagaglio” ai fini dei limiti risarcitori previsti dalla Convenzione, o se, in quanto “essere senziente”, richieda un regime autonomo di tutela e di risarcimento anche del danno non patrimoniale (clicca qui per scaricare il PDF della decisione).
Consiglio: per approfondimenti sul tema, segnaliamo il volume “Il danno da vacanza rovinata”, a cura di Roberto Di Napoli, acquistabile cliccando su Shop Maggioli e su Amazon.

Il danno da vacanza rovinata
Il presente volume offre al lettore, professionista del settore turistico o avvocato, un quadro completo della procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Aggiornato alla giurisprudenza più recente e alle ultime novità normative relative ai contratti di trasporto, ai rapporti con le strutture ricettive e i pacchetti turistici e alle nuove forme di stipula attraverso piattaforme web, il testo, dal taglio operativo, esplora tutte le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato. Ogni capitolo è corredato da uno specifico Formulario, sia di carattere stragiudiziale che giudiziale. Completa il volume un’appendice online che contiene un’ampia rassegna di giurisprudenza, la normativa di riferimento e fac simili di diffide e di atti introduttivi di giudizio.
Roberto Di Napoli
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it
Leggi descrizione
Di Napoli Roberto, 2024, Maggioli Editore
52.00 €
49.40 €

Il danno da vacanza rovinata
Il presente volume offre al lettore, professionista del settore turistico o avvocato, un quadro completo della procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Aggiornato alla giurisprudenza più recente e alle ultime novità normative relative ai contratti di trasporto, ai rapporti con le strutture ricettive e i pacchetti turistici e alle nuove forme di stipula attraverso piattaforme web, il testo, dal taglio operativo, esplora tutte le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato. Ogni capitolo è corredato da uno specifico Formulario, sia di carattere stragiudiziale che giudiziale. Completa il volume un’appendice online che contiene un’ampia rassegna di giurisprudenza, la normativa di riferimento e fac simili di diffide e di atti introduttivi di giudizio.
Roberto Di Napoli
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it
Il caso
I fatti posti a fondamento della controversia principale attengono allo smarrimento di un cane trasportato in stiva, all’interno di un apposito trasportino, durante un volo internazionale operato da Iberia.
La passeggera (Felicísima) agiva in giudizio contro il vettore aereo, richiedendo il risarcimento del danno morale subito, quantificato in EUR 5 000. Il vettore, pur ammettendo la propria responsabilità per la perdita, invocava l’applicazione del regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal. Tale norma limita il risarcimento per la perdita dei bagagli a una somma predeterminata (all’epoca dei fatti 1131 DSP ), non avendo la passeggera effettuato la “dichiarazione speciale di interesse” ivi prevista al momento della consegna.
Il giudice del rinvio, rilevando la potenziale discrasia tra la qualificazione dell’animale come “essere vivente dotato di sensibilità” nel diritto nazionale e nel diritto dell’Unione (art. 13 TFUE ), e la sua classificazione come “bagaglio” ai sensi della Convenzione, ha dunque sollevato questione pregiudiziale. Il quesito verteva essenzialmente sulla corretta interpretazione degli artt. 17(2) e 22(2) della Convenzione, al fine di stabilire se gli animali da compagnia dovessero essere esclusi dalla nozione di “bagaglio”.
Potrebbero interessarti anche:
- Volo aereo in ritardo: quando è dovuto il risarcimento danni
- Compensazione voli e giurisdizione: le Sezioni Unite sulla validità delle clausole di proroga
- Compensazione per ritardi aerei: il valore probatorio della carta d’imbarco
L’interpretazione della nozione di “bagagli”
Nell’affrontare la questione, la CGUE ha preliminarmente ribadito la necessità di un’interpretazione uniforme e autonoma della nozione di “bagagli”, in linea con le regole ermeneutiche del diritto internazionale. L’argomento dirimente è stato rinvenuto nell’architettura sistematica della Convenzione, e in particolare nel suo art. 1. Tale disposizione definisce il campo di applicazione del trattato elencando tre categorie tassative di trasporto: persone, bagagli o merci.
La Corte ha escluso in via interpretativa che un animale da compagnia possa rientrare nella nozione di “persona”, riservata ai “passeggeri” umani. Di conseguenza, non potendo essere assimilato a un passeggero e non rientrando (nel contesto del trasporto passeggeri) nella categoria “merci”, l’animale deve necessariamente ricadere, in via residuale, nella nozione onnicomprensiva di “bagagli” ai sensi dell’art. 17, par. 4. Tale interpretazione, confermata anche dai lavori preparatori, risulta l’unica compatibile con la struttura della Convenzione. Ne consegue che il regime di responsabilità per la perdita dell’animale è quello previsto dall’art. 17, par. 2, ed è soggetto ai limiti risarcitori di cui all’art. 22, par. 2.
Necessità di un “giusto equilibrio di interessi”
La Corte ha inoltre richiamato la ratio della Convenzione, volta a preservare un “giusto equilibrio degli interessi” tra la tutela degli utenti e la sostenibilità economica dei vettori aerei. Il regime di responsabilità oggettiva del vettore, temperato dai correlati limiti risarcitori, assolve a questa esigenza. Il limite previsto dall’art. 22(2) è stato interpretato dalla giurisprudenza costante della Corte come un massimale assoluto.
Il punto nodale della sentenza risiede nella conferma che tale limite onnicomprensivo copre qualsiasi tipologia di danno, “tanto il danno morale quanto il danno materiale”. La Convenzione, nel fissare questo massimale, ha già operato un bilanciamento ex ante, includendo forfettariamente anche la potenziale sofferenza (danno non patrimoniale) del passeggero. Il sistema della Convenzione, sottolinea la Corte, offre al passeggero uno strumento per derogare al massimale standard, qualora lo ritenga inadeguato.
Il passeggero che ritenga il limite troppo esiguo – ad esempio per il valore materiale o, come nel caso di specie, affettivo del bene trasportato – ha la facoltà di effettuare una “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione”. Previo pagamento di un’eventuale tassa supplementare, tale dichiarazione consente di elevare il limite di responsabilità.
La decisione della Corte di Giustizia
L’inerzia della passeggera, che non si è avvalsa della dichiarazione speciale, ha comportato l’applicazione del massimale standard. La presenza di questa facoltà contrattuale rafforza l’interpretazione della Corte: in assenza di dichiarazione, il passeggero accetta consapevolmente il limite onnicomprensivo.
Infine, la Corte ha disatteso l’argomento fondato sull’art. 13 TFUE, che impone di considerare gli animali come “esseri senzienti”. Pur riconoscendo tale principio come un obiettivo di interesse generale dell’Unione, la CGUE ha operato una distinzione cruciale. L’art. 13 TFUE impone di tutelare il benessere dell’animale durante le fasi del trasporto (ad esempio garantendo condizioni di stivaggio idonee), ma non osta a che, ai fini del distinto e specifico regime della responsabilità per la perdita, l’animale sia giuridicamente qualificato come “bagaglio” ai sensi della Convenzione di Montreal.
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Giustizia ha statuito che l’art. 17, par. 2, e l’art. 22, par. 2, della Convenzione di Montreal devono essere interpretati nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di “bagagli”. La sentenza riafferma la natura tecnica e l’esigenza di interpretazione uniforme della Convenzione, concepita per creare un sistema globale prevedibile. Sebbene la soluzione possa apparire inadeguata a ristorare il legame affettivo, essa conferma che il pregiudizio morale è sì risarcibile, ma unicamente entro il massimale aggregato previsto per i bagagli. La pronuncia funge da chiaro monito per gli utenti del trasporto aereo: per ottenere una tutela risarcitoria superiore, commisurata al valore (anche affettivo) del proprio animale, è indispensabile avvalersi dello strumento contrattuale della dichiarazione speciale di interesse.