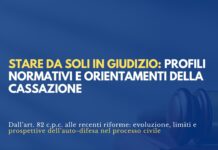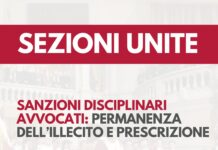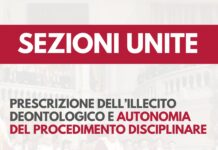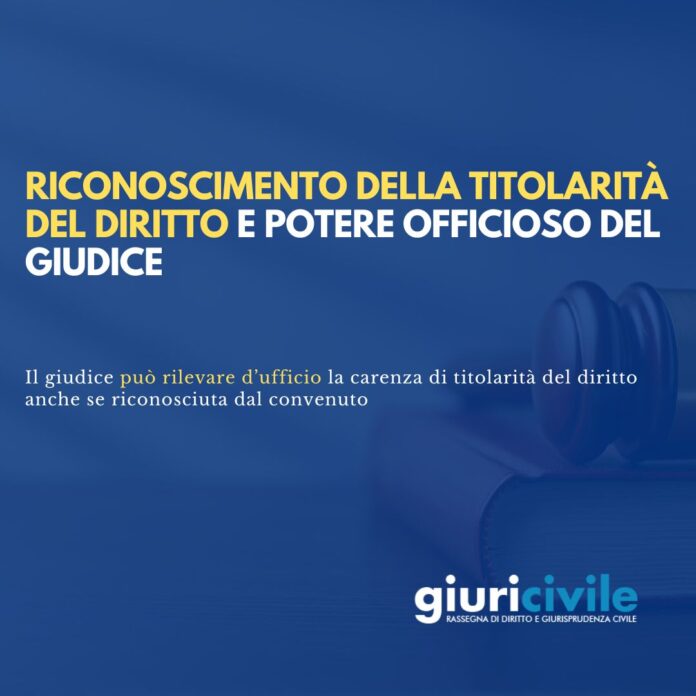
La recente Sentenza n. 1695/2025 della Corte di Appello di Bologna (R.G. 1076/2022) ha sollevato un dibattito di grande rilevanza processuale, in particolare per quanto riguarda il principio secondo cui l’eventuale riconoscimento della titolarità del diritto da parte del convenuto, pur esonerando dall’onere probatorio, non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio la carenza di titolarità. Tale assunto, apparentemente in linea con le Sezioni Unite (Cass. S.U. 2951/2016) che qualificano la titolarità attiva o passiva come elemento costitutivo della domanda, rischia di entrare in frizione con il principio dispositivo e l’economia processuale sancita dall’art. 115 c.p.c.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna
La decisione della Corte di Appello di Bologna è intervenuta in un complesso contenzioso originato, tra l’altro, dai limiti incontrati dal trasferimento del credito all’assuntore del concordato e dalla distinzione tra credito dell’attivo fallimentare e azioni di pertinenza della massa (ex art. 124 L.F.).
Nel merito, la Corte ha ribadito un principio che, sebbene non nuovo, è dirompente nella sua applicazione pratica: la titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda e, come tale, può essere oggetto di rilievo d’ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dalla condotta processuale della controparte. Il riconoscimento o l’ammissione del convenuto della titolarità del diritto in capo all’attore produce l’effetto della relevatio ab onere probandi (esonero dall’onere della prova), rendendo il fatto pacifico sul piano istruttorio.
Tuttavia, secondo la Corte, questa pacificazione della prova non vincola il giudice nell’accertamento sostanziale del diritto. Il potere officioso del giudice, in questa prospettiva, prevale sul principio di non contestazione se, dagli atti di causa, emergono elementi che inequivocabilmente fanno dubitare della reale titolarità.
Alcune considerazioni critiche
La tesi della Corte, pur fondata sull’idea che il giudice debba accertare l’esistenza degli elementi costitutivi della domanda, è stata oggetto di una fondata riflessione critica circa i suoi eccessivi limiti. L’art. 115, comma 1, c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Questa norma ha una duplice funzione: di economia processuale (evitando la prova inutile del pacifico) e di rispetto del principio dispositivo (la disponibilità della prova è rimessa alle parti).
Consentire al giudice di negare la titolarità, nonostante l’espresso riconoscimento o la non contestazione del convenuto, rischia di:
- Riscrivere il thema decidendum: il giudice non valuta ciò che è allegato o pacificamente accettato, ma lo mette in discussione motu proprio, supplendo a una carenza di contestazione della parte che, con il suo contegno, ha manifestato una disponibilità sul fatto.
- Reintrodurre l’obbligo di prova del pacifico: se il riconoscimento del convenuto non è sufficiente a rendere incontestabile la titolarità, l’attore sarà comunque costretto a fornire la prova, vanificando la relevatio ab onere probandi e appesantendo inevitabilmente il processo.
Potrebbero interessarti anche:
- Le Sezioni Unite sul giudicato implicito processuale: tra ragione più liquida e vizi fondanti
- Onere della prova sulla titolarità del diritto: effetti della mancata contestazione del convenuto
Potere officioso e principio dispositivo
Il potere officioso non può essere inteso come un’autorizzazione a ricercare la verità sostanziale al di fuori del perimetro delineato dalle allegazioni e dalle contestazioni delle parti, pena la violazione del principio dispositivo.
Una possibile chiave di lettura
Una chiave di lettura per conciliare il potere officioso e il principio dispositivo risiede nell’operare una netta distinzione tra titolarità del diritto e legittimazione ad agire.
- Legittimazione ad agire (legitimatio ad causam): costituisce una condizione dell’azione (art. 100 c.p.c.). Essa attiene alla corretta identificazione tra il soggetto che agisce (o è convenuto) e il soggetto che, secondo la prospettazione della domanda, è il titolare attivo (o passivo) del rapporto dedotto in giudizio. La sua carenza è un difetto formale che può e deve essere rilevato d’ufficio in ogni momento, poiché impedisce la decisione nel merito.
- Titolarità del diritto (merito): attiene invece al merito della domanda. È l’effettiva e concreta appartenenza del diritto controverso a chi agisce.
Secondo questa distinzione, se il giudice rileva ex officio una carenza di legittimazione, opera correttamente, poiché sta verificando una condizione necessaria per il valido esercizio dell’azione. Se, invece, il giudice rileva ex officio una carenza di titolarità, egli incide sul merito della lite. Il potere di rilievo d’ufficio in questo caso si giustifica pienamente solo quando dagli atti di causa (già acquisiti, anche per altre finalità) emergono elementi contrari all’affermazione di titolarità, rendendo l’affermazione del fatto pacifico (il riconoscimento del convenuto) manifestamente incoerente con il quadro probatorio.
In sintesi, il riconoscimento del convenuto esonera dall’onere probatorio (art. 115 c.p.c.), ma non può impedire al giudice di accertare d’ufficio la reale titolarità se il dato pacifico contrasta con gli elementi di merito già acquisiti. Il potere officioso non riscrive il thema decidendum, ma verifica la coerenza logico-giuridica tra il diritto fatto valere e il soggetto che lo fa valere, agendo come meccanismo di garanzia, pur mantenendo salvo il principio dispositivo.
Riflessioni conclusive
La pronuncia della Corte di Appello di Bologna ripropone in termini attuali e concreti il delicato equilibrio tra l’impulso di parte e il potere di direzione processuale del giudice. Il principio del rilievo d’ufficio della carenza di titolarità è un corollario logico della qualificazione della titolarità come elemento costitutivo della pretesa. Tuttavia, per non svuotare di significato l’art. 115 c.p.c., tale potere non può essere illimitato.
L’integrazione del principio offerta dalla distinzione con la legittimazione ad agire e l’idea che il giudice debba limitare il proprio rilievo alla coerenza con i fatti già allegati o provati in corso di causa, rappresenta la chiave per mantenere saldo il principio dispositivo, garantendo al contempo che la sentenza rispecchi la titolarità effettiva del diritto, elemento irrinunciabile per la giustizia della decisione.
Una rivalutazione della strategia difensiva
In una visione pratica, la pronuncia della Corte di Appello di Bologna impone un’attenta rivalutazione della strategia difensiva.
- Per l’attore, non è più sufficiente l’aspettativa che la mancata contestazione del convenuto garantisca l’acquisizione della titolarità come fatto pacifico. È imperativo predisporre una prova documentale della titolarità il più possibile robusta, specialmente in contesti complessi come i trasferimenti di credito, le cessioni aziendali o, come nel caso di specie, i rapporti conseguenti al concordato.
- Per il convenuto, l’atto di ammissione della titolarità deve essere ponderato: se da un lato snellisce il processo, dall’altro non elimina il rischio che il Giudice, in presenza di indici contrari emersi dagli atti (ad esempio, un difetto di forma nel titolo di trasferimento del credito), eserciti il proprio potere officioso.
L’equilibrio tra il diritto di difesa e la funzione nomofilattica del Giudice si gioca in questa sottile dialettica, richiamando l’avvocato ad una cura estrema non solo del petitum e della causa petendi, ma anche del corredo probatorio a sostegno di ogni elemento costitutivo della domanda, compresa la titolarità.
Riconoscimento della titolarità del diritto e potere officioso del giudice: in sintesi
Che cosa si intende per titolarità del diritto?
La titolarità del diritto è l’effettiva appartenenza del diritto sostanziale al soggetto che lo fa valere in giudizio. Si distingue dalla legittimazione ad agire, che riguarda la corrispondenza formale tra chi agisce e il soggetto indicato come titolare nella prospettazione della domanda.
Il giudice può rilevare d’ufficio la carenza di titolarità del diritto?
Sì, secondo la Corte di Appello di Bologna (sent. n. 1695/2025), il giudice può rilevare d’ufficio la mancanza di titolarità quando dagli atti di causa emergano elementi contrari rispetto alla versione pacifica accettata dalle parti. Tale potere trova fondamento nella natura costitutiva della titolarità, ma deve essere esercitato entro i limiti del principio dispositivo sancito dall’art. 115 c.p.c.
Che ruolo ha l’art. 115 c.p.c. nel bilanciamento tra principio dispositivo e potere officioso del giudice?
L’art. 115, comma 1, c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti. Esso rappresenta un presidio di economia processuale e di rispetto del principio dispositivo, in quanto impedisce al giudice di sostituirsi alle parti nella gestione del thema decidendum. Tuttavia, la giurisprudenza, come conferma la Corte di Appello di Bologna, riconosce che il giudice può disattendere il fatto pacifico solo quando dagli atti emergano prove contrarie manifeste, in grado di mettere in dubbio la coerenza della titolarità dichiarata.
Quali sono le conseguenze del riconoscimento della titolarità del diritto in capo all’attore da parte del convenuto?
Il riconoscimento della titolarità del diritto in capo all’attore, da parte del convenuto, o la mancata contestazione comportano la relevatio ab onere probandi, ma non vincolano il giudice qualora le risultanze di causa rendano dubbia la titolarità. In tal caso, il giudice può legittimamente verificarla anche in assenza di contestazione, purché la decisione si fondi su elementi già acquisiti al processo.
Qual è la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto?
La legittimazione ad agire è una condizione dell’azione (art. 100 c.p.c.) e riguarda la corrispondenza formale tra parte e rapporto dedotto. La titolarità, invece, attiene al merito e alla effettiva appartenenza del diritto. Il giudice può rilevare d’ufficio la carenza di legittimazione, mentre deve limitarsi a verificare la coerenza della titolarità solo se emergono elementi contrari dagli atti.
In quali casi il potere officioso del giudice è legittimo?
Il potere officioso è legittimo solo se esercitato entro i confini del materiale probatorio già acquisito e al fine di garantire coerenza tra la decisione e la realtà giuridica risultante dagli atti. Non può, invece, trasformarsi in un’iniziativa di indagine autonoma o sostitutiva delle parti, pena la violazione del principio dispositivo.