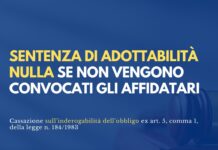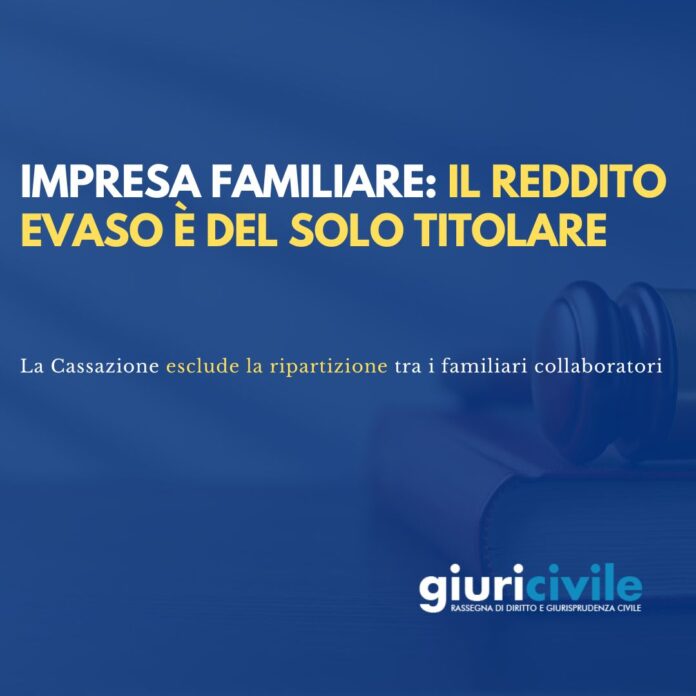
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 33149/2023 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha stabilito che, in caso di accertamento rivolto all’impresa familiare, il maggior reddito accertato deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro-quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili. Per un approfondimento su questi temi, consigliamo il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il dato normativo
L’impresa familiare è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. n. 151/1975 nota come Riforma del diritto di famiglia.
La norma di riferimento è l’art. 230-bis c.c., ma in essa la disciplina si presenta poco analitica, tanto da aver sollevato numerosi problemi interpretativi che hanno dato luogo ad amplissimi dibattiti.
Stando al dato letterale è impresa familiare quella in cui “il familiare (ossia, il parente fino al terzo grado e l’affine fino al secondo grado) presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa”.
In merito, va subito osservato che la formula d’apertura si serve di una locuzione residuale, «salvo che sia configurabile un diverso rapporto», intendendo esprimere che la collaborazione lavorativa in seno alla famiglia può non trovare come unica soluzione la costituzione di un’impresa familiare, ben potendosi plasmare sotto forma di lavoro subordinato o magari come partecipazione ad una società di fatto.
Ancora, sempre in linea generale, v’è da osservare che l’impresa familiare può sussistere indipendentemente dal regime patrimoniale con cui i coniugi hanno scelto di autoregolarsi, sia esso corrispondente alla comunione legale, convenzionale, alla separazione dei beni, al fondo patrimoniale o ad altra opzione gestoria condivisa.
Attraverso cosa opera l’impresa familiare?
Entrando nel vivo della disamina, sempre servendosi dell’analisi esegetica della norma, è possibile comprendere che l’impresa familiare, secondo lo schema del Legislatore, opera attraverso:
- il lavoro del familiare all’interno dell’impresa;
- il lavoro del familiare all’interno della famiglia (ad. es. svolgendo lavori domestici).
Da un lato, dunque, è garantita la posizione del familiare nei confronti del titolare dell’impresa, dall’altro, in perfetta armonia con i moti innovatori del ’75, si riconosce giusto valore al lavoro domestico, considerando che proprio il lavoro del coniuge impiegato nella gestione di tale incombenza consente all’altro di svolgere l’attività imprenditoriale.
Il diritto al mantenimento del familiare che presta la propria attività
A seguire, il familiare che presta la propria attività in famiglia ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipando agli incrementi aziendali in proporzione alla qualità/quantità del lavoro prestato. Il familiare che svolge la propria attività all’interno dell’impresa, inoltre, ed in aggiunta ai diritti di cui beneficerebbe se lavorasse in famiglia, prende parte alle decisioni (adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa) concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e, l’eventuale, cessazione dell’attività d’impresa.
A suggello di quanto espresso all’art. 37 Cost., inoltre, il secondo comma esplicita che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo, in perfetta armonia con il punto di svolta segnato dalla Riforma del ’95 in materia di “parità tra coniugi”.
Il diritto di partecipazione non è trasferibile
Da ultimo, al fine di non snaturare la gestione a conduzione familiare attraverso l’ingresso di estranei nella compagine operativa, la norma conclude specificando che il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore dei familiari e con il consenso manifesto di tutti i partecipanti; ed ove disposto, verrà liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro o in occasione dell’alienazione dell’azienda.
Infine, è previsto che il diritto di partecipazione assicuri l’esercizio della prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento d’azienda.
Potrebbero interessarti anche:
- Convivente di fatto e impresa familiare: le Sezioni Unite
- Convivenza more uxorio e impresa familiare: illegittimità artt. 230 bis e 230-ter
- Impresa familiare con convivente more uxorio: questione alla Corte Costituzionale
Inquadramento fiscale dell’impresa familiare
L’art. 5 del D.p.r. n. 917/1986 precisa che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La disciplina è applicabile solo alle imprese familiari produttive di redditi d’impresa, svolte in forma individuale, con esclusione delle attività diverse da quelle commerciali, ancorché nell’esercizio delle stesse il titolare si avvalga della cooperazione dei propri familiari (come ad es. le attività di impresa familiare produttive di redditi di lavoro autonomo).
Ancora, la disposizione si applica a condizione che:
- i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti:
- la dichiarazione annuale dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
È opportuno precisare, infine, che l’impresa familiare non costituisce, in nessun caso, un’ipotesi di società di persone, rimanendo all’interno della dimensione dell’impresa individuale. La collocazione della disciplina fiscale dell’impresa familiare nell’ambito dell’art. 5 del Tuir (avente ad oggetto i redditi che nascono dallo svolgimento di attività in forma associata), infatti, vale solo ai fini dell’applicazione del principio tributario di trasparenza per l’imputazione dei redditi prodotti.
La partecipazione agli utili
A seguire, si specifica che i familiari dell’imprenditore partecipano esclusivamente agli utili sicché, in caso di perdita, essa sarà fiscalmente imputata per intero nei confronti del titolare dell’impresa, successivamente riportata a compensazione dei redditi di altre categorie nello stesso periodo di imposta, o in quelli successivi, secondo quanto disposto dall’art. 8 del Tuir.
L’applicazione al convivente di fatto
Da ultimo, a seguito della disciplina civilistica delle unioni civili e delle convivenze (L. n. 76/2016), l’istituto dell’impresa familiare è applicabile, anche fiscalmente, al “convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente” (Agenzia Entrate risoluzione n. 134/E). In tali casi, quindi, sulla scorta dell’art. 230-ter c.c., al convivente di fatto spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
L’esclusione dall’IRAP e il regime forfettario
Alle imprese familiari si applica l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti attività d’impresa di cui all’art. 1, comma 8, della L n. 234/2021.
Infine, l’imprenditore individuale che esercita un’attività nella forma di impresa familiare può scegliere di optare per l’adozione del regime forfettario. L’imposta sostitutiva del 15% è calcolata sul reddito, al lordo delle quote assegnate al coniuge, ed ai collaboratori familiari. Pertanto, i collaborati familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi ai fini IRPEF, limitatamente ai redditi provenienti dall’impresa familiare.
Al contrario, il collaboratore familiare, qualora fosse in possesso di una partita IVA, non può accedere al regime forfettario per la sua attività, data la sua esclusione nelle ipotesi di partecipazione all’impresa familiare.
L’imputazione del maggior reddito accertato dell’impresa familiare
In caso di accertamento all’impresa familiare, il maggior reddito accertato deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro-quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa.
E ciò in forza del fatto che all’impresa familiare non si può applicare la disciplina prevista per le società.
In materia di impresa familiare, infatti, il reddito percepito dall’imprenditore titolare, che è pari al reddito conseguito dall’impresa, al netto delle quote di competenza dei familiari, costituisce un reddito d’impresa.
Diversamente, le quote spettanti ai collaboratori, che non sono contitolari dell’impresa familiare, costituiscono redditi di “puro lavoro” non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore (Cass. sent. n. 33149/2023).