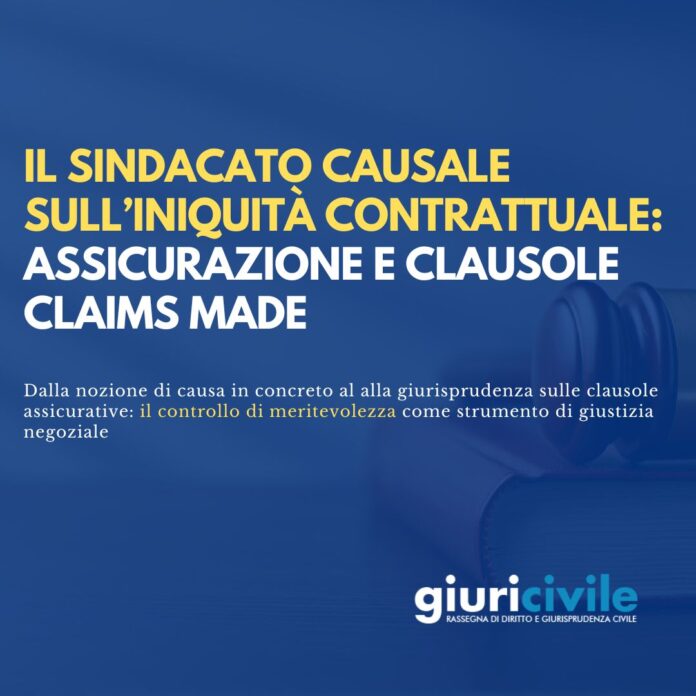
La progressiva affermazione della nozione di causa in concreto ha modificato profondamente il modo in cui si valuta la legittimità e l’equilibrio di un contratto, soprattutto alla luce dei principi costituzionali e dei meccanismi di giustizia contrattuale. Questo cambiamento si riflette in modo particolare nel contratto di assicurazione, nel quale la giurisprudenza ha mostrato un crescente interesse per i profili di meritevolezza e proporzionalità, soprattutto con riferimento alle clausole c.d. “claims made”. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
La nozione di causa in concreto e la nuova centralità dell’autonomia negoziale
L’introduzione della nozione di causa in concreto, intesa quale funzione economico individuale del contratto, ha dato nuova linfa al significato di autonomia negoziale. In particolare, sulla scorta dell’influenza europea e in virtù dell’abbandono della teoria dell’originalismo nell’interpretazione della costituzione economica, si è superato il dogma del contratto quale strumento di realizzazione di interessi economico sociali.
Il giudizio sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ha assunto connotati più elastici che prescindono dal tipo legale: il sindacato sulla meritevolezza dell’operazione negoziale ha ad oggetto non solo i contratti tipici, ma anche quelli atipici, nonché singole clausole o contratti collegati concernenti un’operazione unitaria.
La funzione della causa nella struttura del contratto
Il codice civile, all’art. 1325 c.c., nell’enucleare i requisiti del contratto fa riferimento all’accordo delle parti, alla causa, all’oggetto e alla forma, quando essa risulta prescritta dalla legge a pena di nullità.
La causa del contratto, nella declinazione in senso concreto avallata dalla giurisprudenza di legittimità, è intesa quale funzione economico individuale del contratto, come concreta composizione di contrapposti interessi che, attraverso il meccanismo contrattuale, vengono contemporaneamente soddisfatti. In particolare, ad avviso di autorevole dottrina, la causa rappresenta l’elemento che tecnicamente collega l’operazione economica cui il contratto dà vita, intesa nella sua globalità, ai soggetti che ne sono gli autori.
Differenze tra causa e tipo: dalla forma all’essenza dell’accordo
La teoria della causa concreta ha consentito di superare le obiezioni emerse rispetto alla rigidità del concetto di causa in astratto e di differenziare, in modo netto, la causa dal tipo. In particolare:
- la causa è la ragione pratica del contratto, sintesi di interessi contrapposti obiettivati nell’accordo;
- il tipo, invece, è lo schema astratto a predeterminato dal legislatore di una determinata fattispecie negoziale.
Questa distinzione consente non solo l’utilizzo di modelli predefiniti, ma anche la creazione di nuovi schemi negoziali, con conseguente ampliamento dello spazio di manovra per l’autonomia privata.
I limiti all’autonomia contrattuale: tra diritto interno ed europeo
L’autonomia contrattuale, tuttavia, non è illimitata. Nello specifico, i limiti posti a tutela dell’autonomia negoziale discendono:
- in primis, dall’ordinamento comunitario, in virtù dei principi di libera concorrenza e libero mercato;
- in secondo luogo, sono limiti diretti a vagliare la compatibilità del singolo negozio rispetto ad esigenze di solidarietà, giustizia e buona fede;
- e, in terzo luogo, si pone un problema di valutazione circa la conformità del programma negoziale ad una ragione che lo giustifichi.
Potrebbe interessarti anche:
Il sindacato sulla meritevolezza e il suo fondamento costituzionale
Il sindacato causale sull’equità contrattuale ha ad oggetto la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, a norma dell’art. 1322, comma secondo, c.c. La valutazione di meritevolezza, in particolare, si collega a parametri costituzionali quali l’utilità sociale e la buona fede solidaristica di cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione.
La causa, in altri termini, non può ritenersi meritevole di tutela quando l’interesse perseguito non risulta conforme alle esigenze della comunità rilevanti secondo i parametri costituzionali. Il contratto immeritevole si identifica, pertanto, con quello contrario ai principi costituzionali e, segnatamente, all’utilità sociale.
Quando un contratto è iniquo: soggezione, vantaggi sproporzionati, doveri violati
L’iniquità contrattuale può emergere:
- qualora il contratto attribuisca ad una delle parti un vantaggio ingiusto o sproporzionato;
- quando una parte sia in una posizione di soggezione rispetto all’altra;
- o nell’ipotesi in cui il regolamento negoziale costringa una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.
La nozione di ordinamento giuridico, quindi, di cui al secondo comma dell’art. 1322 c.c., dovrebbe ritenersi comprensiva non solo delle norme codicistiche, ma anche delle superiori norme di rango costituzionale.
Meritevolezza e liceità della causa: due concetti da non confondere
Pur esistendo opinioni che tendono a sovrapporre meritevolezza e liceità della causa, è necessario mantenerne la distinzione:
- la liceità, infatti, implica un controllo negativo relativo al non contrasto con i limiti esterni dettati da norme imperative, dall’ordine pubblico e dal buon costume;
- la meritevolezza, invece, innesca una verifica positiva in merito alla sussistenza di requisiti positivi che il contratto deve presentare per essere idoneo a perseguire una funzione utile per i contraenti.
Il controllo sulla meritevolezza causale, dunque, non è, diversamente da quello di liceità, un sindacato sull’autonomia contrattuale, ma una tecnica di tutela dell’autonomia, diretta ad assicurare l’idoneità del progetto negoziale a soddisfare in modo utile e soddisfacente gli interessi perseguiti dalle parti, secondo parametri di solidarietà e ragionevolezza.
Applicazioni concrete: assicurazione e clausole claims made
Per comprendere meglio quale sia l’oggetto del sindacato causale sull’equità contrattuale, si deve fare riferimento alla casistica giurisprudenziale sul contratto di assicurazione contro i danni e, nello specifico, alla complessa tematica delle clausole claims made miste o impure.
Cosa sono le clausole claims made?
Le polizze con formula claims made condizionano la copertura alla circostanza che il sinistro sia stato denunciato nel periodo di vigenza della polizza. Tali clausole si contrappongono alla logica loss occurrence prevista dall’art. 1917 c.c.
Differenze tra claims made e loss occurrence: la centralità del tempo
Le polizze con formula tradizionale, o c.d. loss occurrence, ai sensi del primo comma dell’art. 1917 c.c., coprono i sinistri verificatisi nel corso del rapporto assicurativo, anche se la richiesta risarcitoria sia pervenuta all’assicurato in un tempo successivo e, di conseguenza, questi ne abbia dato comunicazione alla Compagnia di assicurazione allorquando la polizza invocata non era più vigente.
La differenza tra le due formule risiede nel momento rilevante ai fini della copertura: il sinistro per la loss occurrence, la denuncia per la claims made.
Giurisprudenza sulle clausole claims made: gli orientamenti
Il peculiare meccanismo offerto dalle clausole claims made, stante la sua difformità rispetto a quello di cui al primo comma dell’art. 1917 c.c. che riferisce il periodo di copertura assicurativa al momento della realizzazione del fatto, indipendentemente da quando avvenga la denuncia, è stato sottoposto al vaglio della giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, tali clausole sarebbero da considerarsi nulle in quanto contrastanti con il disposto di cui all’art. 1917 c.c., e, in particolare, perché, mediante tali clausole si finirebbe per assicurare il cosiddetto rischio putativo, ossia quel rischio mai esistito o già cessato al momento della conclusione del contratto di assicurazione.
Altra parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto, invece, valide tali clausole, anche se poi si è divisa in relazione alla loro vessatorietà ai senti e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.
Le Sezioni Unite sulle clausole claims made
La Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta per dirimere i contrasti interpretativi sulle clausole claims made con due sentenze abbastanza recenti.
Sezioni Unite del 2016
Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza del 6 maggio 2016 n. 9140 (clicca qui per approfondire), hanno dichiarato nulle le clausole claims made per violazione dell’art. 1322, comma secondo, escludendo che le suddette clausole possano considerarsi nulle per violazione di norme imperative, non essendo l’art. 1917 cc una fattispecie inderogabile.
Nello specifico, nello scrutinare il giudizio di immeritevolezza della clausola claims made nel contratto di assicurazione contro i danni, la Suprema Corte ha statuito che, il giudice può intervenire o attraverso:
- la declaratoria di nullità parziale sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1419, comma secondo, c.c. e in applicazione del precetto di cui all’art. 2 della Costituzione, in combinato disposto con il canone di buona fede;
- oppure, potrebbe intervenire anche in senso modificativo o integrativo dello statuto negoziale, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti o a prevenire l’abuso del diritto.
Sezioni Unite del 2018
Le varie questioni sottese alla tematica delle clausole claims made hanno ricevuto con risposta definitiva con la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018 (clicca qui per approfondire).
Le Sezioni Unite, in particolare, hanno statuito che, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., ma alla verifica ai sensi dell’art. 1322 primo comma c.c., della corrispondenza delle conformazione del tipo al limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine riguarda la causa concreta del contratto, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale riguardando, anche, la fase precontrattuale e quella di attuazione del rapporto.
Conclusioni
La nozione di causa in concreto ha ridefinito i confini dell’autonomia negoziale, in senso positivo, incrementandone le forme di tutela. L’interpretazione costituzionalmente orientata della concetto di meritevolezza offre importanti spunti di riflessione soprattutto sulla scorta di argomenti comparatistici e in virtù dei principi di diritto unionale. L’esempio emblematico delle clausole claims made dimostra come il controllo di meritevolezza possa incidere profondamente sulla validità e sull’efficacia delle pattuizioni, fungendo da presidio contro squilibri ingiustificati e pratiche elusive.
Il sindacato giudiziale sulla causa diviene, così, una chiave interpretativa per risolvere tensioni tra autonomia privata e interessi collettivi, con uno sguardo attento alla concreta realizzazione della giustizia contrattuale.










