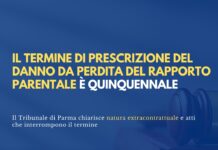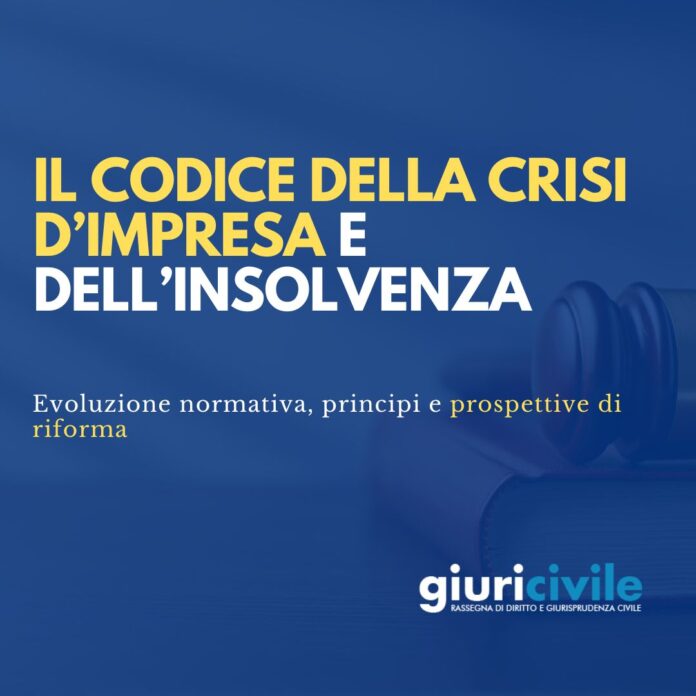
La riforma organica del diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, avviata con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – segna una svolta radicale rispetto al tradizionale impianto della legge fallimentare del 1942. Si tratta di un intervento legislativo di ampio respiro, ispirato alla necessità di superare un approccio meramente liquidatorio alla crisi e all’insolvenza, per valorizzare invece gli strumenti di emersione anticipata, prevenzione, ristrutturazione e continuità aziendale.
L’obiettivo dichiarato del legislatore è duplice: da un lato, costruire un sistema più efficiente, accessibile e coerente con i principi del diritto dell’Unione Europea; dall’altro, promuovere una nuova cultura imprenditoriale improntata alla responsabilità gestionale e alla tempestiva rilevazione delle situazioni di squilibrio economico-finanziario. Il Codice si fonda infatti su una serie di principi generali – sostanziali e processuali – che conferiscono centralità alla figura dell’imprenditore, al ruolo degli assetti organizzativi adeguati e al nuovo procedimento unitario per l’accesso alle procedure.
In tale contesto, il presente contributo si propone di analizzare in chiave sistematica le principali novità del CCII, evidenziando le implicazioni teoriche e applicative dei suoi istituti fondamentali, alla luce delle modifiche introdotte dai decreti correttivi (d.lgs. n. 83/2022 e d.lgs. n. 136/2024) e delle interazioni con il diritto unionale, in particolare con la Direttiva UE 2019/1023.
La riforma del diritto concorsuale italiano: dal Regio Decreto del 1942 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Dalla legge fallimentare al Codice
Con l’entrata in vigore, nel luglio 2022, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito “ccii”), si è compiuto un passaggio epocale nella storia del diritto concorsuale italiano. Il nuovo testo normativo ha formalmente sostituito, dopo oltre ottant’anni di vigenza, il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. legge fallimentare), la cui applicazione rimane tuttavia vigente per le procedure avviate anteriormente alla piena efficacia del nuovo codice, come stabilito dall’art. 390 ccii.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Composizione negoziata della crisi”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.

Composizione negoziata della crisi
Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.
Leggi descrizione
Monica Mandico, Pasquale Capaldo, 2025, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €

Composizione negoziata della crisi
Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.
Il Codice si propone come una disciplina sistemica e unitaria della crisi e dell’insolvenza di tutti i debitori, ad esclusione degli enti pubblici, inglobando per la prima volta anche la regolamentazione delle situazioni di sovraindebitamento del debitore “civile” e del consumatore (cfr. art. 65 ss. CCII), precedentemente disciplinate dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.
Origine della riforma e approccio anticipatorio
La riforma trae origine dalla l. delega 155/2017, che ha delineato l’obiettivo di riordinare l’intero impianto normativo in materia di crisi d’impresa e insolvenza, ispirandosi a criteri di semplificazione, efficienza e prevenzione. Il legislatore ha accolto un approccio “anticipatorio” rispetto alla crisi, favorendo strumenti di allerta e composizione assistita, oltre a modelli procedurali meno afflittivi e più orientati alla continuità aziendale.
Potrebbe interessarti anche:
Criticità storiche e tentativi di riforma
Nei decenni successivi al 1942, la legge fallimentare ha subito modifiche frammentarie, spesso eterogenee. In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha giocato un ruolo determinante nel correggere lacune e rigidità del testo originario, contribuendo, con sentenze additive e interpretative, ad armonizzarne i contenuti con i principi fondamentali della Costituzione italiana, come il diritto di difesa, il giusto processo e la parità di trattamento.
Parallelamente, il legislatore è intervenuto in modo selettivo soprattutto per introdurre discipline speciali, come quella dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, attraverso il d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e successivamente con il d.l. 347/2003 (cd. Decreto Marzano).
Verso una codificazione unitaria
A partire dal 2005, in risposta a uno scenario economico profondamente mutato – anche a causa della crisi finanziaria globale del 2008 – si è assistito a un ciclo intensivo di riforme. Con i decreti d.lgs. 5/2006 e d.lgs. 169/2007, la legge fallimentare è stata oggetto di una revisione profonda volta a valorizzare la funzione del risanamento e della continuità d’impresa, introducendo strumenti alternativi come il concordato preventivo con continuità aziendale e il piano attestato di risanamento.
Tali interventi, seppur significativi, hanno però generato un quadro normativo frammentato e in parte incoerente, che ha reso sempre più evidente la necessità di una codificazione unitaria, attuata infine con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Un codice moderno e europeo
Il CCII ha inaugurato una visione moderna e sistemica della crisi d’impresa, orientata alla prevenzione, attraverso l’istituzione di indicatori di allerta; alla semplificazione procedurale; alla riorganizzazione organica delle procedure, come l’unificazione dei riti concorsuali in un unico modello procedurale denominato “liquidazione giudiziale”, che sostituisce il fallimento.
Inoltre, con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency), il Codice si inserisce pienamente nel quadro unionale, promuovendo un armonizzato bilanciamento tra esigenze del mercato e tutela dei diritti dei debitori e creditori.
Obiettivo e campo di applicazione del Codice della crisi
Una disciplina universale e inclusiva
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce una regolazione ampia e polivalente delle situazioni di sovraindebitamento, rivolgendosi a un vasto target di debitori – da imprenditori commerciali e agricoli, anche di piccole dimensioni o no profit, fino a consumatori e professionisti – escludendo solo lo Stato e alcuni enti pubblici, talvolta subordinati a liquidazione coatta amministrativa.
L’art. 1, co. 1, c.c.i.i., stabilisce che il codice copre “le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore….persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo…”, secondo una prospettiva universalistica.
Estensione soggettiva e oggettiva della nozione di debitore
Il legislatore estende l’area dei soggetti “debitore” rispetto alla disciplina fallimentare previgente: rientrano ora nello schema normativo anche le imprese artigiane e agricole, le no profit, le associazioni, fondazioni, società pubbliche e gruppi societari, indipendentemente dalla loro natura.
Sono altresì inclusi i consumatori e i professionisti individuali (non qualificabili come imprenditori) con debiti di natura personale o familiare, con piena equiparazione nell’ambito delle procedure previste dal codice.
Il codice abbraccia ogni forma di crisi o insolvenza: dallo stato di difficoltà finanziaria o disallineamento patrimoniale (anche pre-insolutivo) fino all’insolvenza manifesta, ampliando il raggio applicativo rispetto al fallimento classico, riservato solo agli imprenditori commerciali e con soglie quantitative ben precise.
In particolare, la procedura di composizione negoziata può intervenire già in presenza di uno squilibrio “probabile” di crisi, senza attendere che insorga uno stato di insolvenza conclamata.
Approccio collettivo e superamento dell’esecuzione individuale
Il Codice introduce un paradigma di risoluzione collettiva del debito, promuovendo strumenti negoziali – come piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi – volti a preservare l’impresa e riequilibrare l’esposizione debitoria, evitando l’esdebitazione intempestiva. Il Codice accomuna i creditori in un contesto di concorso dinamico, integrando estinzione, ristrutturazione e liquidazione in un unico sistema.
Questa visione collettiva si pone in netta continuità, ma anche in tensione, con l’art. 2740 c.c., secondo cui “il debitore risponde… con tutti i suoi beni presenti e futuri”: il Codice mitiga la perpetuità del debito favorendo l’esdebitazione a fronte di una “seconda chance” concessa alla continuità aziendale.
La denominazione “Codice” non è retorica: l’intento è fornire una regolazione omnicomprensiva della crisi, struttura che raggruppa norme procedurali, contenutistiche e preventive, dalla diagnosi (allerta interna, composizione negoziata) fino alla liquidazione giudiziale.
Un sistema integrato e stratificato
La giurisprudenza e la dottrina interpretano il sistema come unitario ma articolato, in cui strumenti alternativi funzionano in modo convergente, pur con specificità: ad esempio, composizione negoziata (pre-crisi), concordato o accordi di ristrutturazione (fase d’insolvenza), liquidazione giudiziale sul piano sostanziale.
Il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, titolo più neutro che riflette un cambio di approccio, in linea con la legge delega 155/2017.
Le procedure emergenziali (concordato, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta) restano in vigore ma armonizzate con il nuovo codice, garantendo interoperabilità ma anche tensioni interpretative nelle criticità operative.
La dottrina muove obiezioni sulle ambiguità concettuali: in particolare riguardo alla definizione di “crisi” vs “insolvenza”, e all’identificazione dell’artigiano come figura distinta; sul coordinamento tra strumenti, ovvero criticità operativa tra liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e concordato; sul ruolo della prevenzione per gli obblighi di allerta interna e le misure di early warning che richiedono un quadro normativo più definito.
Struttura procedurale del Codice: articolazione per moduli
Il Codice della crisi si configura come un sistema integrato, concepito per affrontare ogni forma di squilibrio finanziario o patrimoniale del debitore, mediante un’ottica che privilegia il superamento della crisi attraverso strumenti preventivi e collettivi, contrastando la via delle esecuzioni individuali prolungate.
Pur perseguendo una universalità ideale, il sistema normativo e le prassi attuative evidenziano nodi interpretativi e operativi, a cui dottrina e giurisprudenza sono chiamate a rispondere, per garantire l’effettiva efficacia dell’impianto innovativo.
Le tre macro-categorie di procedure
Il Codice della crisi organizza un ricco ventaglio di procedure secondo tre macro-categorie:
a) Composizione pre-concorsuale negoziata della crisi (CNC):
Accesso all’istituto mediante esperto nominato per mediare un accordo preventivo, eventualmente evolutivo in concordato semplificato.
b) Strumenti di regolazione della crisi/insolvenza:
-
Piano attestato di risanamento;
-
Accordi di ristrutturazione dei debiti;
-
Convenzioni di moratoria;
-
Accordi su crediti tributari e contributivi;
-
Piano con omologazione;
-
Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
-
Concordato minore;
-
Concordato preventivo.
c) Procedure liquidatorie di insolvenza:
-
Liquidazione giudiziale;
-
Liquidazione controllata;
-
Liquidazione coatta amministrativa.
Pluralismo procedurale e criticità della bipartizione soggettiva
Il Codice si propone come quadro omnicomprensivo, ma al tempo stesso conserva una bipartizione soggettiva nella scelta delle procedure, distinguendo principalmente le imprese commerciali non minori – cui sono riservati strumenti “pieni” – dai debitori minori o “non fallibili” (artigiani, agricoltori, professionisti, consumatori) cui sono destinate procedure “alleggerite”.
Tuttavia, tale bipartizione risulta criticabile, poiché si colgono evidenti analogie fra procedure “maggiori” e “minori” (es. liquidazione controllata vs giudiziale; pianificazione del consumatore vs piano con omologazione), e perché variabili come dimensione o natura giuridica non escludono la potenziale idoneità del debitore a strumenti maggiori.
Il Codice della crisi si configura dunque come una cornice giuridica strutturata e articolata, caratterizzata da:
-
universalità dell’ambito applicativo;
-
eterogeneità procedurale differenziata;
-
una persistente – e forse superabile – bipartizione soggettiva.
Il Procedimento unitario nel Codice della crisi: limiti e prospettive di riforma
Finalità e impianto generale
Il “procedimento unitario” introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) aspira a fungere da contenitore processuale comune per l’accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza e alla liquidazione giudiziale, attuando la delega conferita con la l. 19 ottobre 2017, n. 155.
Pur rappresentando un progresso rispetto alla frammentarietà della vecchia legge fallimentare, la concretizzazione dell’unitarietà resta, allo stato, parziale e problematica, soprattutto nella fase applicativa.
I principi della legge delega e la codificazione
La legge-delega 155/2017 prescriveva «un procedimento unitario regolato da principi comuni», onde garantire rapidità e coerenza tra i diversi istituti concorsuali. Il CCII ha recepito l’indicazione nei suoi artt. 37–53, collocandola nel Titolo III.
L’art. 65, co. 2, CCII estende i principi generali a tutte le procedure, comprese quelle “minori”. Resta tuttavia esclusa la composizione negoziata della crisi, percorso stragiudiziale collocato sistematicamente fuori dagli “strumenti” ex art. 2, co. 1, lett. m-bis CCII. Questa scelta segna la prima, significativa, frattura nell’auspicata unitarietà.
Il contenitore processuale e la concentrazione
Dottrina e Relazione governativa lo descrivono come “contenitore processuale” nel quale confluiscono le domande – pattizie o liquidatorie – riguardanti la medesima crisi. L’art. 7 CCII impone, infatti, la riunione di tutte le istanze concernenti lo stesso debitore, garantendo il simultaneus processus e il vaglio prioritario delle soluzioni conservative.
La domanda (ricorso) si propone al tribunale in composizione collegiale, è rinunciabile ed è obbligatoriamente iscritta nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, con segnalazione delle eventuali misure protettive. Per le società, l’atto dev’essere deliberato a norma dell’art. 120-bis c.c.i.i..
L’art. 39 elenca un corredo documentale particolarmente gravoso – dai bilanci triennali allo “stato estimativo” – cui si aggiungono le certificazioni fiscali e contributive. Tale puntigliosità, pur funzionale alla trasparenza, spesso ritarda l’accesso effettivo agli strumenti.
Il ruolo del pubblico ministero e il principio di simultaneità
Ogni ricorso è trasmesso al P.M.. La novella amplia sensibilmente i poteri del P.M. rispetto alla vecchia legge fallimentare, ponendolo quale “parte necessaria” in tutte le fasi del procedimento.
Se pendono più istanze (es. richiesta di liquidazione giudiziale da parte dei creditori e, di contro, domanda di concordato del debitore), il tribunale deve trattarle congiuntamente, valutando per prima la domanda conservativa salvo manifesta inammissibilità.
Collegamento con le fonti UE e internazionali
Il procedimento è pensato per dialogare con il Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure d’insolvenza transfrontaliere, che fonda la competenza sul COMI ed esige rapide decisioni sulla giurisdizione. L’art. 27 CCII recepisce la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale, salvo prova contraria.
In materia di cooperazione giudiziaria, il CCII è compatibile con la UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997), fondata sul principio del “modified universalism” e sul riconoscimento della “foreign main proceeding”.
Profili critici e limiti applicativi
Dottrina recente sottolinea come la pretesa unitarietà resti soprattutto ideale: le norme speciali rimangono eterogenee e la concentrazione processuale è minata da regimi istruttori differenziati (es. art. 41 per la liquidazione giudiziale, art. 44 per le domande “con riserva”).
Inoltre, l’onere documentale ex art. 39 e l’intervento costante del P.M. rallentano la fase introduttiva, tradendo l’obiettivo di rapidità auspicato dalla direttiva 2019/1023 e dalla stessa legge-delega.
Le prospettive di semplificazione
Il “correttivo-ter” del 2024 annuncia semplificazioni – abolizione dell’irreperibile “area web” per le notifiche ex art. 40, co. 7, e riduzione del corredo documentale – ma la vera svolta dipenderà da:
-
standardizzazione telematica dei modelli di ricorso;
-
maggiore ricorso alla composizione negoziata in fase pre-contenziosa;
-
integrazione effettiva con la cross-border toolbox.
Il procedimento unitario è un primo passo verso la razionalizzazione, ma serve un ulteriore sforzo – normativo e prasseologico – perché diventi il motore di una giustizia concorsuale tempestiva, predicibile e realmente “orientata al futuro”.
Continuità aziendale o liquidazione: gerarchia normativa ed evidenze 2020–2023
L’art. 7, co. 2, c.c.i.i.: due regole processuali cardine
L’art. 7, co. 2, c.c.i.i. racchiude due regole processuali cardine:
-
Riunione obbligatoria dei procedimenti: tutte le domande concorsuali pendenti nei confronti dello stesso debitore confluiscono in un unico procedimento dinanzi al tribunale competente, prescindendo dall’ordine cronologico di presentazione;
-
Trattazione prioritaria delle soluzioni going-concern: fra le domande riunite, il giudice esamina per prime quelle rivolte a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, purché non manifestamente inammissibili o basate su piani manifestamente inadeguati e sia data evidenza della maggiore convenienza per i creditori.
Applicazioni pratiche del principio di priorità
In pendenza di istanza per la liquidazione giudiziale, il successivo ricorso del debitore per concordato preventivo impone la riunione ex officio e l’esame prioritario della proposta concordataria, con conseguente preclusione – in caso di esito positivo – dell’apertura della procedura liquidatoria.
Il principio opera simmetricamente quando l’ordine temporale delle domande è inverso: se un creditore chiede la liquidazione mentre è già pendente la domanda per concordato o per altro strumento, la cognizione sulle soluzioni negoziate resta comunque prioritaria.
La Cassazione ha ribadito che la traslatio iudicii imposta per ragioni di competenza comporta il trasferimento di tutte le domande al giudice indicato, il quale deve rispettare la priorità ex art. 7 c.c.i.i. anche quando la domanda di concordato era stata in precedenza dichiarata inammissibile.
Gerarchia normativa e riferimenti sovranazionali
L’art. 7 riflette la ratio complessiva del CCII di favorire la continuità aziendale e la gestione negoziata delle crisi, in attuazione:
-
dell’art. 2, lett. g), della L. 155/2017 (legge-delega);
-
della Direttiva (UE) 2019/1023, che impone agli Stati membri quadri di ristrutturazione preventiva accessibili precocemente e con adeguate misure protettive;
-
del Reg. (UE) 2015/848 (rifusione), il quale, nei contesti transfrontalieri, agevola l’apertura di procedure “secondarie” solo quando non ostino soluzioni più efficienti per la continuità;
-
dei testi UNCITRAL (Model Law 1997), che promuovono il coordinamento internazionale e la centralità dell’impresa come going concern.
L’art. 7 c.c.i.i. costituisce dunque l’architrave processuale che impone al giudice di privilegiare – tutte le volte in cui appaiano praticabili – le soluzioni di risanamento negoziato rispetto alla liquidazione coattiva, attuando così il paradigma di una “liquidation as last resort” già accolto dal diritto unionale e dagli standard internazionali.
La centralità normativa della continuità aziendale
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019, si fonda su una scelta legislativa netta: la liquidazione giudiziale deve rappresentare la soluzione estrema, da adottarsi solo quando non esistano alternative negoziate idonee a superare la crisi.
Questa impostazione risponde alla chiara volontà espressa dal legislatore delegante all’art. 2, co. 1, lett. g), della l. 155/2017, secondo cui:
“[…] dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta una idonea soluzione alternativa”.
Il dato normativo viene ripreso e sviluppato nell’art. 7, co. 2, c.c.i.i., che impone la trattazione prioritaria delle domande che mirino a regolare la crisi o l’insolvenza mediante strumenti diversi dalla liquidazione, a condizione che non siano manifestamente inammissibili o basate su piani inadeguati e che sia data evidenza della convenienza per i creditori.
L’ordine sistematico come espressione di valori
Anche l’architettura del Codice conferma la scelta del legislatore: i primi quattro Titoli della Parte Prima sono dedicati agli strumenti di regolazione negoziata e giudiziale della crisi (composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo), mentre solo nel Titolo V si affronta la liquidazione giudiziale.
L’ordine non è neutro né solo funzionale, ma esprime una precisa gerarchia assiologica: il legislatore privilegia strumenti che perseguano la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori, riservando la liquidazione giudiziale ai casi in cui tali strumenti non siano praticabili. Questo riflette un orientamento già emerso nella giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento.
Dati applicativi: il disallineamento tra norma e prassi
La previsione normativa, pur chiara, si scontra con la prassi giudiziaria e con la realtà economica: le procedure negoziate, e in particolare i concordati, registrano percentuali molto basse di successo, sia per la difficoltà nel costruire piani convincenti e finanziabili, sia per la resistenza dei creditori ad accettare soluzioni dilatorie e incerte rispetto alla liquidazione giudiziale.
Dati forniti dalla Banca d’Italia e da Cerved mostrano che:
-
nel triennio 2020–2023, oltre il 70% delle procedure di concordato sono state dichiarate inammissibili, revocate o non omologate;
-
solo in circa il 10% dei casi si è registrata una continuità aziendale effettiva e stabile oltre i due anni successivi all’omologazione.
Liquidazione giudiziale come strumento prevalente
Ne consegue che la liquidazione giudiziale, nonostante la sua collocazione subordinata nel sistema, continua ad essere la procedura di regolazione dell’insolvenza più utilizzata, anche nel caso delle imprese medio-grandi (quando non vi siano i presupposti per l’amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/1999).
La Direttiva (UE) 2019/1023, all’art. 4, impone agli Stati membri di garantire la disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva accessibili prima che l’impresa diventi insolvente, in modo da evitare la liquidazione. Il modello auspicato è quello del “going concern”, con piena protezione dei posti di lavoro e dei valori economici.
Anche la UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) e il Regolamento (UE) 2015/848 sul riconoscimento delle procedure transfrontaliere privilegiano la coordinazione e la continuità rispetto a scenari liquidatori.
La necessità di rafforzare la cultura del risanamento
La scelta legislativa operata dal Codice della crisi – coerente con la legge delega e con i principi unionisti – riflette una visione moderna della regolazione dell’insolvenza, orientata alla conservazione del valore e alla continuità dell’attività economica.
L’esperienza applicativa dimostra che, nonostante la priorità normativa delle soluzioni negoziate, la liquidazione giudiziale resta, di fatto, lo sbocco prevalente delle crisi d’impresa.
Questo disallineamento tra intento normativo e prassi giudiziaria richiede un intervento sul piano:
-
dell’educazione finanziaria;
-
della specializzazione degli attori (professionisti, tribunali, advisor);
-
dell’effettivo accesso al credito;
pena la perdita di efficacia del principio di “liquidazione come extrema ratio” che anima la riforma.
Il COMI come criterio cardine di giurisdizione e competenza nel Codice della Crisi d’Impresa
La centralità del COMI per la giurisdizione internazionale
L’art. 11 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14: «CCII») individua la giurisdizione internazionale del giudice italiano per le domande di apertura di uno strumento di regolazione della crisi o di una procedura liquidatoria quando il debitore:
-
(i) ha in Italia il centro degli interessi principali (COMI), oppure
-
(ii) dispone nel territorio di una semplice dipendenza organizzativa.
La disposizione recepisce – estendendola anche a rapporti extra-UE – la regola cardine fissata dall’art. 3, par. 1, reg. (UE) 2015/848, secondo cui la competenza principale spetta allo Stato in cui è situato il COMI.
Definizione di COMI e presunzioni operative
Il CCII fornisce la definizione interna di COMI (Centre of Main Interest) all’art. 2, co. 1, lett. m):
«luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».
Sul piano operativo, tale nozione si articola in:
-
Presunzione formale: coincidenza con la sede legale o con la residenza/domicilio della persona fisica;
-
Prevalenza del dato sostanziale: rileva la sede effettiva del governo d’impresa (art. 27 c.c.i.i.), anche quando essa diverga dalla sede statutaria;
-
Dipendenza: la presenza in Italia di una stabile articolazione dotata di autonomia operativa radica comunque la giurisdizione, pur in mancanza del COMI.
Meccanismi antielusivi e contrasto al forum shopping
La scelta del legislatore mostra chiaramente l’intento di contrastare forum shopping opportunistico. In particolare, l’art. 26 c.c.i.i. rende irrilevante, ai fini della giurisdizione, il trasferimento all’estero del COMI intervenuto nell’anno anteriore al deposito della domanda. Tale “periodo di raffreddamento” ricalca il meccanismo antielusivo del reg. 2015/848.
Orientamenti giurisprudenziali
A livello europeo
-
Eurofood IFSC (C-341/04, 2 maggio 2006): il COMI deve essere determinato con criteri «obiettivi e riconoscibili dai terzi», superabili solo con prova contraria rigorosa;
-
Interedil (C-396/09, 20 ottobre 2011): il giudice è tenuto a verificare d’ufficio la reale collocazione del COMI, valorizzando il luogo di amministrazione effettiva e i rapporti esterni con gli stakeholders.
A livello nazionale
-
Cass. civ., sez. VI-1, 5 agosto 2021, n. 22389: in tema di competenza territoriale fallimentare, il trasferimento della sede legale è irrilevante se avvenuto nell’anno che precede l’istanza, a tutela dell’affidamento dei creditori (principio ora trasfuso negli artt. 27 e 28 CCII);
-
Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2025, n. 6620: la presunzione legale è facilmente superabile quando la prova documentale e testimoniale individui altrove il baricentro decisionale dell’impresa.
Spunti dottrinali
La dottrina osserva che l’art. 11 CCII “nazionalizza” il COMI, elevandolo a criterio generale della giurisdizione anche verso soggetti extra-UE, in linea con la UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency del 1997.
-
Mucciarelli sottolinea come la prevalenza del dato sostanziale riduca, ma non elimini, lo spazio per pratiche di arbitraggio normativo;
-
Lamanna evidenzia il ruolo complementare giocato dall’art. 26, quale norma-cerniera fra giurisdizione internazionale e competenza interna.
Il criterio del COMI nella competenza territoriale
L’art. 29 c.c.i.i. individua il tribunale territorialmente competente per:
-
tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
-
le procedure liquidatorie;
-
tutte le controversie che ne derivano.
Il criterio è unico e inderogabile: coincide con il centro degli interessi principali (COMI) del debitore.
Per le grandi imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e per i gruppi societari di rilievo, il foro naturale diventa il Tribunale delle imprese del capoluogo regionale, in linea con la definizione di “large undertaking/group” contenuta nell’art. 3, parr. 6–7, dir. 2013/34/UE.
La verifica d’ufficio della competenza
Il sistema, mutuando l’art. 38 c.p.c., impone al giudice l’obbligo di verificare ex officio la propria competenza alla prima udienza utile, proprio per neutralizzare spostamenti opportunistici del COMI.
La giurisprudenza ha chiarito che:
-
la competenza territoriale si cristallizza alla data del deposito della domanda;
-
eventuali spostamenti successivi (o avvenuti entro l’anno precedente) non rilevano, salvo reale trasferimento del baricentro gestionale;
-
in presenza di un COMI estero ma di una dipendenza operativa in Italia, è legittima la competenza del tribunale nazionale, valorizzando il criterio di “prossimità” ai creditori.
Continuità e specializzazione nella gestione delle procedure
Il COMI interno assurge a criterio cardine tanto della giurisdizione quanto della competenza, creando un continuum che riduce gli spazi di forum shopping verticale (tra Stati) e orizzontale (tra tribunali).
L’attribuzione della competenza al Tribunale delle imprese per le realtà di maggior rilievo garantisce:
-
specializzazione;
-
omogeneità interpretativa;
-
miglior coordinamento con la disciplina dei gruppi.
La costruzione processuale degli artt. 29–31 c.c.i.i. – integrata dal filtro della Cassazione tramite il regolamento necessario ex art. 45 c.p.c. – realizza una “translatio senza regressione”: lo spostamento del fascicolo non azzera gli effetti utilmente prodotti, assicurando continuità ed economia processuale.
I principi processuali generali nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Un ruolo sistemico meno centrale ma funzionale
I principi processuali generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, delineati agli artt. 7 ss. c.c.i.i., assumono una minore centralità sistematica rispetto ad altri principi fondanti, pur mantenendo rilevanza nella disciplina delle procedure.
Durata delle misure protettive: art. 8 c.c.i.i.
In primo luogo, l’art. 8 c.c.i.i. prevede una limitazione temporale precisa per le misure richieste dall’imprenditore al momento dell’accesso alla procedura.
Tale limite è fissato in un periodo massimo di 12 mesi, anche non continuativi. Questo principio risponde all’esigenza di contenere in termini ragionevoli il ricorso a strumenti cautelari o conservativi, evitando possibili abusi.
Inapplicabilità della sospensione feriale e obbligo di difesa tecnica: art. 9 c.c.i.i.
In secondo luogo, l’art. 9 c.c.i.i. stabilisce:
-
l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini a tutti i procedimenti previsti dal Codice;
-
la necessità imprescindibile di assistenza tecnica mediante difensore qualificato, salvo diversa specifica previsione.
Questo assetto rafforza il principio del contraddittorio e assicura una corretta tutela processuale delle parti coinvolte.
Comunicazioni e strumenti digitali: art. 10 c.c.i.i.
L’art. 10 c.c.i.i. disciplina le modalità di comunicazione, prescrivendo:
-
l’obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) o di modalità telematiche indirizzate al domicilio digitale risultante dai pubblici registri;
-
solo in caso di mancato funzionamento o assenza di tali modalità, è ammesso il deposito diretto nel fascicolo informatico della procedura.
Tale previsione risponde ai principi di efficienza, tempestività e certezza giuridica.
Nomina dei professionisti e trattazione prioritaria: art. 5 c.c.i.i.
Ulteriori principi, di natura prevalentemente processuale, si rinvengono negli artt. 3–5 c.c.i.i., con particolare attenzione all’art. 5.
Questo articolo prevede che le nomine dei professionisti nelle procedure debbano avvenire nel rispetto dei principi di:
-
trasparenza;
-
rotazione;
-
efficienza.
Tali criteri assicurano imparzialità e competenza nella gestione delle procedure stesse.
Inoltre, lo stesso art. 5 stabilisce che le controversie in cui sia coinvolto un organo nominato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, nell’ambito di una procedura regolata dal Codice, devono essere trattate prioritariamente rispetto ad altre controversie pendenti innanzi allo stesso Tribunale.
Tale disposizione mira a garantire rapidità nella risoluzione di conflitti che potrebbero pregiudicare l’efficace svolgimento delle procedure concorsuali.
I principi generali del Codice della crisi d’impresa: obblighi sostanziali e processuali dei soggetti coinvolti
Obblighi organizzativi dell’imprenditore: prevenzione e tempestività
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede principi generali di rilevanza sia sostanziale sia processuale, identificando specifici obblighi in capo ai soggetti coinvolti nella gestione delle crisi aziendali.
Tra i principi cardine figura l’obbligo, imposto ad ogni imprenditore, di adottare misure e assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.
Tale dovere, previsto dall’art. 3 c.c.i.i. e richiamato dall’art. 2086 c.c., mira a prevenire o mitigare situazioni di crisi o insolvenza, assicurando una pronta reazione.
Buona fede, correttezza e trasparenza del debitore
L’art. 4 c.c.i.i. individua i doveri generali di buona fede e correttezza in capo al debitore e ai creditori durante le procedure di gestione della crisi.
Il debitore, in particolare:
-
deve tutelare gli interessi dei creditori;
-
è tenuto a illustrare con chiarezza e trasparenza la propria situazione economica durante le trattative per la composizione negoziata;
-
deve assumere iniziative tempestive e idonee a risolvere la crisi.
Durante le procedure regolative, il patrimonio e l’impresa devono essere gestiti nell’interesse prioritario dei creditori.
Obblighi informativi verso i lavoratori
Ulteriore rilevanza assume il dovere di informazione previsto per il debitore–datore di lavoro che occupa oltre quindici dipendenti.
In tal caso, l’art. 4, co. 3, c.c.i.i. impone la comunicazione ai soggetti sindacali delle decisioni aziendali rilevanti per l’organizzazione del lavoro, attivando procedure consultive finalizzate alla tutela dei lavoratori.
Obbligo di leale cooperazione dei creditori
Ai creditori è assegnato un generale obbligo di collaborazione leale, derivante:
-
dai principi civilistici di buona fede e correttezza;
-
dal principio costituzionale di solidarietà economica.
Essi devono:
-
cooperare con il debitore, con l’esperto incaricato nella composizione negoziata e con gli organi nominati dalle autorità competenti;
-
rispettare il dovere di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Trasparenza e accessibilità delle informazioni: principio di pubblicazione
Il Codice introduce, inoltre, il principio di pubblicazione delle informazioni, che garantisce l’accessibilità pubblica sui siti istituzionali ministeriali:
-
degli strumenti di anticipata emersione della crisi;
-
della “lista di controllo” per l’autovalutazione economico-finanziaria delle imprese.
Tale previsione mira a favorire la trasparenza e a prevenire l’emersione tardiva della crisi.
Principio di economicità e prededucibilità dei crediti professionali
Infine, l’art. 6 c.c.i.i. enuncia il principio di economicità delle procedure, sancendo la prededucibilità dei crediti professionali maturati durante le procedure concorsuali (ad es. crediti derivanti dalla consulenza per la domanda di concordato preventivo).
La prededucibilità:
-
tutela i professionisti coinvolti;
-
incentiva l’assistenza tecnica qualificata nelle procedure di gestione della crisi.
Conclusione
Il sistema delineato dal Codice assegna ai soggetti coinvolti – imprenditori, creditori, professionisti – obblighi chiari e puntuali, che si muovono su un piano sia sostanziale che processuale.
L’attuazione concreta di tali obblighi costituisce la chiave operativa per il successo delle finalità preventive e risanatorie sottese all’intera riforma.
Formazione in materia
Il corso online in diretta, di Formazione Maggioli, “Crisi di impresa e composizione negoziata 2025″ esamina il funzionamento della composizione negoziata con un taglio operativo. Verranno analizzati i ruoli dell’esperto, del giudice, delle banche e del fisco nei percorsi di risanamento della crisi d’impresa. L’obiettivo è quello di fornire strumenti concreti per la gestione della crisi, con un focus sulle misure protettive e autorizzatorie, le interazioni con il tribunale e le possibili soluzioni al termine delle trattative. <<<scopri di più e iscriviti qui>>>