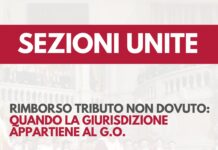La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13881/2025, del 25 maggio (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna a pronunciarsi su limiti e condizioni di operatività della compensazione tra crediti e debiti di natura fiscale nell’ambito del concordato preventivo. La decisione offre l’occasione per ribadire il principio cardine secondo cui il momento genetico delle reciproche posizioni creditorie e debitorie, posto in relazione con la “data di spartiacque” (c.d. cut-off date) rappresentata dall’apertura della procedura concorsuale, costituisce il criterio dirimente per stabilire l’ammissibilità della compensazione ai sensi degli artt. 56 e 169 L. F. La Corte, cassando la decisione di merito, riafferma la piena legittimità della compensazione tra posizioni sorte entrambe in epoca ante procedura.
Consiglio: ti occupi di crisi d’impresa e concordati? Il volume “Composizione negoziata della crisi”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, è uno strumento pratico ed essenziale. Normativa, giurisprudenza, casi risolti e soluzioni operative in un’unica guida aggiornata: perfetto per chi gestisce o assiste imprese in difficoltà.

Composizione negoziata della crisi
Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.
Leggi descrizione
Monica Mandico, Pasquale Capaldo, 2025, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €

Composizione negoziata della crisi
Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.
La vicenda processuale e la decisione della Corte
La controversia trae origine dal provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, il rimborso di un credito IVA, eccependo in compensazione l’esistenza di carichi tributari a ruolo a carico della società contribuente. Il punto nodale della vicenda, sul quale si innesta la decisione della Suprema Corte, risiede nella collocazione temporale delle rispettive pretese.
Nello specifico, il credito IVA chiesto a rimborso dalla società (poi ceduto a terzi) era maturato nel periodo d’imposta 2009. I debiti tributari opposti in compensazione dall’Ufficio, invece, afferivano a un periodo d’imposta ancora precedente, il 2007. La domanda di ammissione al concordato preventivo era stata presentata in data 8 giugno 2010, con successiva omologa nel maggio 2011.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte aveva ritenuto illegittima la compensazione operata dall’Amministrazione Finanziaria, accogliendo la tesi della società contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 169 L.F.[1], per aver il giudice d’appello precluso all’Ufficio la possibilità di compensare i propri crediti, sebbene sia il credito IVA del contribuente sia i debiti erariali fossero sorti in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, accoglie il ricorso dell’Ufficio. I giudici di legittimità, richiamando un orientamento ormai consolidato[2], chiariscono che l’elemento dirimente è la comune appartenenza delle posizioni creditorie e debitorie al patrimonio del debitore in bonis. Poiché sia il credito (anno 2009) sia il debito (anno 2007) sono sorti prima dell’apertura della procedura (anno 2010), essi sono omogenei e reciprocamente compensabili.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
L’istituto della compensazione nelle procedure concorsuali, disciplinato dall’art. 56 del R.D. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), rappresenta una significativa deroga al principio cardine della par condicio creditorum[3]. Esso consente ai creditori del soggetto insolvente di compensare i propri debiti verso quest’ultimo con i crediti che vantano nei suoi confronti, anche se non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Il rinvio recettizio operato dall’art. 169 L.Fall. estende tale disciplina anche al concordato preventivo, fissando come momento di riferimento la data di presentazione della relativa domanda.
Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno da tempo delineato un limite invalicabile all’operatività di tale istituto: la mancanza di reciprocità[4] tra i debiti del soggetto insolvente e i crediti sorti in capo alla massa dei creditori dopo l’apertura della procedura. Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, non è consentita “la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione”[5].
Questo principio si fonda su una netta alterità soggettiva: il credito sorto dopo l’apertura della procedura non appartiene più al patrimonio del debitore (il “fallito”), ma alla massa dei creditori, rappresentata dal curatore o, nel concordato, gestita dall’imprenditore sotto la vigilanza degli organi della procedura. Di conseguenza, un creditore dell’imprenditore ante procedura (come l’Erario per tributi relativi a periodi d’imposta precedenti) non può compensare il proprio credito con un debito che matura verso la massa, poiché verrebbe a mancare il requisito della reciprocità tra i medesimi soggetti[6].
La Cassazione, infatti, ha più volte affermato che “diversi sono […] i soggetti che vantano crediti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a seconda che il credito insorga prima o dopo l’apertura della procedura” (Cass., n. 6478/2014, richiamata nella pronuncia in commento).
Potrebbero interessarti anche:
Il discrimine temporale
L’errore in cui è incorsa la corte di merito risiede proprio in una errata applicazione del principio sopra descritto. Il giudice d’appello ha assimilato una fattispecie di crediti e debiti entrambi pre-concorsuali alla diversa ipotesi di contrapposizione tra un credito della massa (post-procedura) e un debito verso l’imprenditore (ante-procedura).
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13881/2025, riporta la questione nei corretti binari: il discrimine non è la data di formazione del ruolo o di notifica degli atti impositivi, bensì il periodo d’imposta in cui è sorto il fatto generatore dell’obbligazione tributaria e del corrispondente credito[7].
Nel caso analizzato:
- Il debito tributario dell’impresa è sorto nel 2007.
- Il credito IVA a rimborso è sorto nel 2009.
- La procedura concorsuale è stata aperta nel 2010.
È evidente che entrambe le posizioni giuridiche sono nate e divenute parte del patrimonio della società prima che questa accedesse al concordato preventivo. Entrambe, quindi, sono posizioni giuridiche riferibili al medesimo soggetto (la società in bonis) e non coinvolgono la “massa dei creditori” come soggetto autonomo.
Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’operatività della compensazione ex art. 56 L.Fall.: i crediti contrapposti sono omogenei, certi, liquidi ed esigibili, e soprattutto – ciò che qui rileva – il fatto genetico di entrambi è anteriore alla domanda di concordato.
Conclusioni
L’ordinanza n. 13881/2025 non introduce elementi di novità, ma conferma e arricchisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato. Viene confermato in modo inequivocabile che la linea di demarcazione tracciata dalla data di apertura della procedura ha un valore oggettivo e invalicabile. Tutto ciò che accade prima, in termini di maturazione di debiti e crediti, resta confinato nella sfera patrimoniale del debitore ed è soggetto alle regole ordinarie, inclusa la compensazione; tutto ciò che sorge dopo, invece, entra nella sfera della massa dei creditori, soggetta a regole proprie e a una rigorosa tutela della par condicio, derogabile solo nei casi espressamente previsti.
Formazione in materia
Il corso online in diretta, di Formazione Maggioli, “Crisi di impresa e composizione negoziata 2025″ esamina il funzionamento della composizione negoziata con un taglio operativo. Verranno analizzati i ruoli dell’esperto, del giudice, delle banche e del fisco nei percorsi di risanamento della crisi d’impresa. L’obiettivo è quello di fornire strumenti concreti per la gestione della crisi, con un focus sulle misure protettive e autorizzatorie, le interazioni con il tribunale e le possibili soluzioni al termine delle trattative. <<<scopri di più e iscriviti qui>>>
Note
[1] Ora, rispettivamente, artt. 155 e 295 del D.Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
[2] Si veda anche la recente Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, del 21 marzo 2025 n. 7512 – e la giurisprudenza ivi richiamata – nella parte motiva relativa al settimo motivo di ricorso.
[3] La ratio di tale deroga è stata ricondotta ad esigenze di equità, non ritenendo giusto chiedere ad un soggetto di soddisfare integralmente il proprio debito a fronte del pagamento parziale del proprio credito. Parte della dottrina tuttavia non condivide tale impostazione ritenendo che le regole del concorso dovrebbero prescindere dall’esistenza di rapporti debito-credito. Si veda NIGRO A., VATTERMOLI D., Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Il Mulino, 2023, pp. 190-191.
[4] Ai sensi dell’art. 1241 c.c., “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti […]”.
[5] Così Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002. Il principio è costantemente ribadito nella prassi successiva; cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 302 del 28 agosto 2020 e Risposta a interpello n. 536 del 6 novembre 2020.
[6] Cfr. Cass. Sez. V, 10 luglio 2003, n. 10349, citata anche nell’ordinanza in esame, che distingue tra il credito “trovato” dal curatore nel patrimonio del fallito e il credito sorto in corso di procedura, facente capo direttamente alla massa.
[7] Sul punto, sebbene in un contesto diverso, si veda Cass., Sez. V, n. 9064 del 1° aprile 2021, che approfondisce la distinzione tra fatto generatore, esigibilità e pagamento dell’imposta, chiarendo come il sorgere dell’obbligazione sia legato al verificarsi del presupposto materiale e non alle successive vicende formali di accertamento o riscossione.