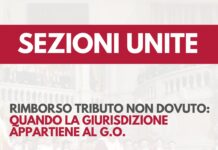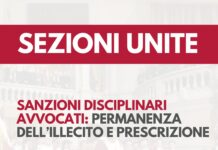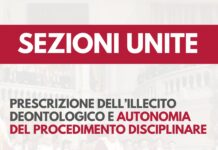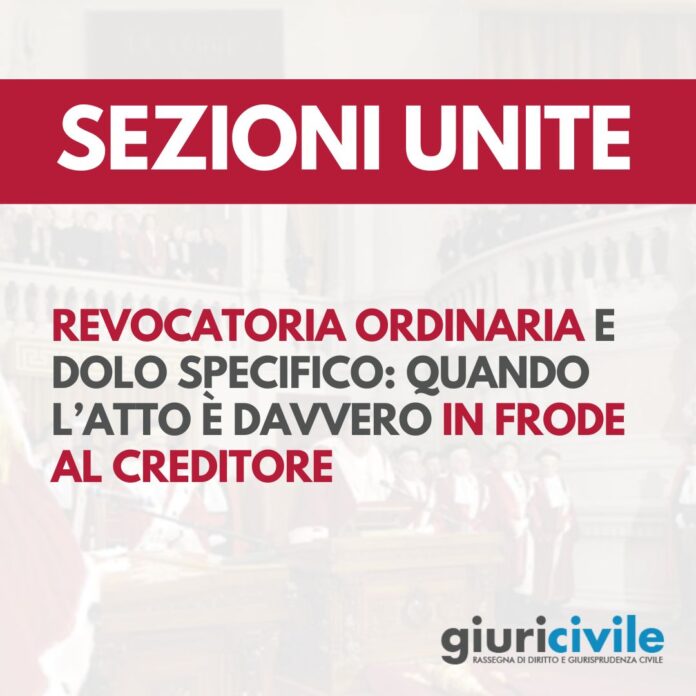
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), sono intervenute in modo risolutivo su una questione che da tempo divideva la giurisprudenza e la dottrina: quale sia il grado di consapevolezza richiesto in capo al debitore per rendere esperibile l’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 del codice civile, nei casi in cui l’atto dispositivo sia stato compiuto prima del sorgere del credito.
Il nodo interpretativo riguarda la natura del dolo necessario: se basti una consapevolezza generica del pregiudizio (il c.d. dolo generico), oppure se si esiga un intento finalistico, ossia la volontà di ledere il creditore futuro (dolo specifico). La risposta delle Sezioni Unite è netta: l’azione è proponibile solo se l’atto sia stato compiuto con dolo specifico, cioè con lo scopo preciso di pregiudicare il soddisfacimento del credito che verrà in essere.
Questo chiarimento non è di mero valore teorico: incide profondamente sulla configurabilità stessa dell’azione revocatoria e, di riflesso, sull’equilibrio tra esigenze di tutela del credito e principio di affidamento nei rapporti economici. Non si tratta, dunque, di una decisione isolata, ma di un passaggio sistematico rilevante, che si inserisce nel più ampio dialogo tra giurisprudenza, diritto civile sostanziale e prassi giudiziaria.
La struttura dell’azione revocatoria e la centralità dell’elemento soggettivo
L’azione revocatoria ordinaria, come noto, non è volta a colpire la validità dell’atto, ma la sua efficacia nei confronti del creditore che ne subisce pregiudizio. È un rimedio conservativo, che ha come funzione primaria quella di tutelare l’integrità della garanzia patrimoniale generica, prevista dall’art. 2740 c.c.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
L’art. 2901 c.c. richiede, per l’accoglimento della domanda revocatoria, tre presupposti fondamentali:
- L’esistenza di un credito certo, anche se non liquido o esigibile, al tempo dell’atto (o, come vedremo, anche se sorto dopo, ma con ulteriori condizioni);
- L’effettiva lesione della garanzia patrimoniale, cioè il compimento di un atto che renda più difficile la soddisfazione del credito;
- Un elemento soggettivo:
- Per gli atti a titolo gratuito: la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia patrimoniale;
- Per gli atti a titolo oneroso: in aggiunta, la consapevolezza del terzo contraente del pregiudizio arrecato al creditore.
Se l’atto è stato compiuto dopo il sorgere del credito, la prova del consilium fraudis (cioè della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore) si presenta meno problematica. Ma che accade se l’atto è anteriore al credito? È ancora possibile parlare di frode? E, soprattutto, su quali basi può un creditore – che all’epoca non esisteva giuridicamente – affermare di essere stato danneggiato da quell’atto?
Proprio su questo punto si è consumato lo scontro interpretativo, con due orientamenti giurisprudenziali opposti.
Il contrasto giurisprudenziale: tra dolo generico e dolo specifico
Una parte della giurisprudenza di legittimità, sostenuta da argomenti di carattere sistematico e funzionale, aveva ritenuto sufficiente il dolo generico del debitore, anche nei casi in cui l’atto fosse anteriore al credito. In quest’ottica, bastava che l’atto fosse compiuto con la generica consapevolezza che, in futuro, l’alienazione avrebbe potuto pregiudicare eventuali creditori. Tale orientamento si fondava sull’idea che l’art. 2901 c.c. sia strumento di tutela ampia, anche di crediti eventuali, futuri, o condizionali, e dunque la mala fede del debitore potesse ricavarsi da indici fattuali e contestuali, senza la necessità di dimostrare una vera e propria preordinazione fraudolenta.
Al contrario, un altro filone giurisprudenziale – più rigoroso – esigeva, per gli atti anteriori al credito, la prova di un dolo qualificato, finalisticamente orientato, cioè un comportamento del debitore volto a sottrarre scientemente beni alla futura garanzia patrimoniale, avendo già presente l’eventualità della nascita del debito. In assenza di un disegno preordinato, secondo questa linea, non potrebbe parlarsi di atto in frode, bensì soltanto di esercizio lecito dell’autonomia patrimoniale.
Le implicazioni pratiche dei due orientamenti sono evidenti: accogliere il primo avrebbe significato ampliare il raggio d’azione dell’art. 2901 c.c., a costo di sacrificare la certezza degli scambi. Accogliere il secondo significa ridurre lo spazio operativo della revocatoria, ma garantire che essa venga utilizzata solo nei casi effettivamente fraudolenti.
Potrebbero interessarti anche:
-
Azione revocatoria dell’atto di scissione societaria e competenza giurisdizionale: le Sezioni Unite
-
Azione revocatoria e fondo patrimoniale: gli effetti sui terzi
-
Eccezione revocatoria ex art. 2901 c.c. nella procedura ex L. 3/2012: effetti e condizioni
La decisione delle Sezioni Unite: la necessaria preordinazione fraudolenta
Con la sentenza n. 1898/2025, le Sezioni Unite hanno sposato la seconda opzione, sancendo un principio inequivocabile: quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, il creditore che agisce in revocatoria deve provare l’esistenza di un dolo specifico in capo al debitore, ossia una volontà consapevole e finalizzata a danneggiare quel determinato credito, sebbene ancora non esistente.
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’art. 2901 c.c. In primo luogo, viene richiamata la necessità che l’azione revocatoria sia correlata a una situazione giuridica concreta e non ipotetica: l’atto del debitore, per poter dirsi in frode al creditore, deve essere intenzionalmente volto a ledere la sua pretesa, e non solo potenzialmente idoneo a ciò. La semplice consapevolezza astratta di compiere un atto che potrebbe, un giorno, pregiudicare qualcuno non integra il requisito soggettivo richiesto.
In secondo luogo, la Corte sottolinea che non può essere compresso l’effetto reale di un atto dispositivo lecito solo per effetto di una ricostruzione postuma del comportamento del debitore, che risulterebbe lesivo solo in una fase successiva. Occorre, invece, che quell’atto sia già viziato nella sua origine da un intento fraudolento, cioè sia preordinato a nuocere al creditore futuro. Diversamente, si rischierebbe di ammettere una revocabilità oggettiva, senza colpa, fondata su presunzioni generalizzate, che contraddice la natura stessa dell’art. 2901 c.c.
Infine, le Sezioni Unite chiariscono che, in caso di atti a titolo oneroso, tale prova deve estendersi anche alla consapevolezza del terzo contraente, il quale deve risultare partecipe (o almeno conoscente) della finalità fraudolenta. Questo passaggio rafforza la protezione dell’affidamento del terzo di buona fede, evitando che egli possa subire gli effetti dell’azione revocatoria in mancanza di un suo coinvolgimento.
Le ricadute applicative e il rilievo sistematico della sentenza
La sentenza n. 1898/2025 incide profondamente sulle dinamiche processuali dell’azione revocatoria. D’ora in avanti, il creditore che intenda contestare un atto compiuto in epoca anteriore dovrà farsi carico di un onere probatorio aggravato, volto a dimostrare non solo il pregiudizio e l’esistenza del credito, ma anche l’intenzione fraudolenta del debitore, indirizzata precisamente al pregiudizio di quel credito.
Questo non significa rendere l’azione revocatoria inoperante, ma delimitarne con maggiore rigore l’ambito, rafforzando la sua funzione di strumento straordinario, e non ordinario, di tutela del credito. In un sistema ispirato alla libertà di iniziativa economica, all’autonomia patrimoniale e alla certezza dei traffici, l’inefficacia dell’atto negoziale non può essere dichiarata se non in presenza di una frode chiara, dimostrata e riferibile a un intento specifico.
A livello sistematico, la pronuncia riafferma la coerenza del diritto civile con i principi di buona fede, affidamento e certezza del diritto. Evita derive sanzionatorie o moralistiche del diritto delle obbligazioni, che rischiano di trasformare ogni atto dispositivo in un potenziale illecito, e restituisce all’art. 2901 c.c. la sua natura tipicamente fraudolenta, distinta dalla mera lesività.
Conclusione
La sentenza n. 1898/2025 rappresenta un punto di equilibrio maturo e coerente tra due esigenze fondamentali: da un lato, la protezione del creditore contro atti fraudolenti del debitore; dall’altro, la tutela della certezza e della stabilità degli atti giuridici compiuti in modo lecito e senza intenti elusivi. Con essa, le Sezioni Unite hanno ribadito che la revocatoria ordinaria non è una forma di responsabilità oggettiva, né un rimedio per sindacare a posteriori le scelte economiche del debitore, ma uno strumento residuale e rigoroso, che richiede la dimostrazione di un intento lesivo concreto e mirato.
Si tratta di una decisione destinata a incidere non solo nella prassi giudiziaria, ma anche nella riflessione dottrinale, ponendosi come riferimento imprescindibile per tutte le future elaborazioni in tema di responsabilità patrimoniale, abuso del diritto e conservazione della garanzia generica.