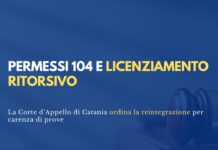L’art. 2652 c.c. stabilisce che l’anteriorità della trascrizione dell’acquisto da parte del terzo rende il suo diritto insensibile agli effetti della sentenza che accoglie una domanda giudiziale trascritta in un momento successivo, indipendentemente dal tempo intercorso tra le due trascrizioni.
Questo principio, tuttavia, presenta alcune criticità. L’esame delle diverse fattispecie mostra infatti che la sentenza di accoglimento non dovrebbe incidere sempre sull’acquisto del terzo, ma solo quando la trascrizione della domanda interviene dopo un intervallo temporale significativo, e non anche quando avviene entro un periodo relativamente breve.
La questione
L’art. 2652 c.c. prevede che la sentenza la quale dichiari risolto o rescisso il contratto, non pregiudica i diritti che terzi abbiano acquistato sul bene oggetto del contratto stesso, nel caso in cui la trascrizione del titolo di acquisto del terzo sia avvenuta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di rescissione e risoluzione.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
Stesso principio vale per quanto riguarda le domande giudiziali di:
- risoluzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per inadempimento dell’onere da parte dell’erede (o legatario) e del donatario;
- revocazione delle donazioni;
- autorizzazione, a favore dei creditori del chiamato il quale abbia rinunciato (benché senza frode) all’eredità, ad accettare in nome e per conto del rinunciante, al fine di poter soddisfare i propri crediti sui beni ereditari;
- esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre;
- rivendica della proprietà.
Si tratta di verificare se, per tutte le fattispecie sopra elencate, il principio in base al quale l’anteriorità della trascrizione del titolo di acquisto del terzo rende inefficace la sentenza (e quindi la previa domanda giudiziale), possa considerarsi effettivamente legittimo, oppure se, in base alla particolarità della singola fattispecie, esso possa prestarsi ad interpretazioni differenti.
La domanda di risoluzione per inadempimento nei contratti ad esecuzione istantanea e nel caso di condizione risolutiva espressa: la “naturale retroattività” della risoluzione
Occorre distinguere tra contratti a esecuzione continuata o periodica e contratti a esecuzione istantanea. Nei primi, l’art. 1458 c.c. limita gli effetti della risoluzione alle prestazioni non ancora eseguite. La parte che invoca la risoluzione non ha quindi diritto alla restituzione di quanto ha già eseguito. Nei contratti a esecuzione istantanea accade l’opposto: la risoluzione produce effetti restitutori e riporta le parti alla situazione anteriore.
In questa seconda categoria, la retroattività incide anche sulla tutela del terzo acquirente. Il principio secondo cui la sentenza dichiarativa della risoluzione non pregiudica l’acquisto del terzo dovrebbe operare solo quando la domanda giudiziale sia stata trascritta dopo un certo intervallo di tempo rispetto alla trascrizione del titolo di acquisto. Se la domanda arriva entro un termine breve, risulta discutibile salvaguardare comunque l’acquisto del terzo.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Condizione risolutiva espressa e ruolo della retroattività
Un’impostazione analoga si applica al caso in cui le parti abbiano inserito nel contratto una condizione risolutiva espressa ex art. 1360, comma 2, c.c., prevedendo l’effetto retroattivo dell’avveramento. Quando la sentenza accerta tale avveramento, la retroattività dovrebbe operare come nei contratti a esecuzione istantanea: l’acquisto del terzo può restare salvo solo se la domanda giudiziale è stata trascritta dopo un lasso di tempo significativo, e non anche quando interviene entro un periodo ridotto.
Clausola risolutiva espressa e tutela del terzo acquirente
Diverso è il regime della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. L’art. 1458, comma 2, chiarisce che la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi nemmeno quando sia “espressamente pattuita”.
La clausola risolutiva richiede un atto di volontà della parte interessata: opera solo se la parte decide di avvalersene. A differenza della condizione risolutiva, le parti non possono attribuirle effetti retroattivi.
Condizione e clausola condividono natura pattizia, ma funzionano in modo diverso. L’avveramento della condizione produce effetti retroattivi in modo pressoché automatico. La clausola, invece, dipende da una scelta successiva della parte, che può anche decidere di non attivarla. Se la parte voleva sin dall’inizio ottenere la risoluzione, avrebbe potuto apporre una condizione risolutiva. La scelta della clausola dimostra che il suo interesse alla risoluzione non era determinante.
Per questa ragione appare coerente, come prevede l’art. 2652 c.c., che l’anteriorità della trascrizione del titolo tuteli il terzo anche quando la domanda giudiziale venga trascritta entro un termine breve. La clausola risolutiva espressa, priva di retroattività legale, giustifica la piena salvaguardia dell’acquisto del terzo.
Restituzione del bene e liberazione per equivalente
Resta da valutare se la sentenza dichiarativa della risoluzione possa imporre al terzo la restituzione del bene anche quando la domanda giudiziale sia trascritta entro un termine breve. Si potrebbe sostenere che il terzo possa comunque liberarsi versando l’equivalente monetario al creditore che ha ottenuto la sentenza.
Su questo punto è utile il parallelismo con la ripetizione di indebito. L’art. 2033 c.c. consente a chi ha eseguito un pagamento non dovuto di ottenerne la restituzione. L’art. 2037 c.c. stabilisce l’obbligo del terzo acquirente di restituire la cosa ricevuta indebitamente e, solo in caso di perimento, permette di liberarsi pagando l’equivalente.
Parallelismo con l’indebito oggettivo
Nell’indebito oggettivo la parte trasferisce una cosa di sua proprietà per errore. Anche se la controparte aliena quella cosa a un terzo, la parte ha comunque diritto alla restituzione. Se questo vale in caso di errore, lo stesso diritto dovrebbe spettare alla parte che ha adempiuto regolarmente ma non ha ricevuto la controprestazione per inadempimento della controparte, e che ora agisce in giudizio per la risoluzione.
La risoluzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per inadempimento dell’onere: il ruolo del motivo e la legittimazione degli eredi
Disposizione testamentaria modale: il “motivo” come fondamento della retroattività
L’art. 648 c.c. stabilisce che qualsiasi interessato può agire per l’adempimento dell’onere e che la risoluzione per inadempimento è possibile solo se risulta prevista nell’atto e se l’adempimento costituisce il solo motivo determinante della disposizione.
Quando il testatore individua un unico motivo – cioè assicurarsi che il bene venga impiegato per una finalità specifica – l’apposizione dell’onere assume di fatto la natura di una condizione risolutiva espressa. In questa prospettiva, la retroattività conseguente all’inadempimento si avvicina a quella prevista dall’art. 1360, comma 2, c.c., per le condizioni risolutive.
Se la retroattività dipende dalla volontà del testatore, la sentenza che dichiara risolta la disposizione non dovrebbe lasciare intatto l’acquisto del terzo in ogni caso. Dovrebbe farlo solo quando la domanda giudiziale sia stata trascritta dopo un apprezzabile intervallo di tempo rispetto alla trascrizione del titolo del terzo, e non anche – come prevede l’art. 2652 c.c. – indipendentemente dal periodo trascorso. Se la domanda arriva entro un termine breve, la salvaguardia del terzo risulta meno coerente con la logica dell’onere quale motivo unico e determinante.
Donazione modale: legittimazione degli eredi e limiti alla tutela del terzo
Per la donazione modale, l’art. 793 c.c. consente al donante e a qualsiasi interessato di agire per l’adempimento dell’onere, anche durante la vita del donante. La risoluzione per inadempimento, inoltre, può essere richiesta dal donante o dagli eredi solo se risulta espressamente prevista nell’atto.
Il lungo arco temporale entro il quale si può chiedere la risoluzione – l’intera vita del donante – e la possibilità che anche soggetti terzi possano attivarsi impongono un equilibrio. Se né il donante né altri soggetti esercitano l’azione, l’acquisto del terzo che abbia trascritto prima della trascrizione della domanda deve rimanere intatto, anche se la domanda perviene entro un intervallo breve. Questo assetto coincide con quanto prevede l’art. 2652 c.c., che risulta quindi coerente sotto questo profilo.
Tuttavia, l’art. 793, ultimo comma, c.c. attribuisce agli eredi del donante la legittimazione ad agire per la risoluzione dell’onere. Questa legittimazione ha senso solo se può incidere sull’acquisto del terzo in caso di trascrizioni ravvicinate. Potrebbe infatti accadere che il terzo trascriva il proprio titolo prima dell’apertura della successione, impedendo di fatto qualsiasi iniziativa del donante e degli eredi. Se così fosse, la legittimazione degli eredi rischierebbe di divenire priva di effettività.
Per renderla coerente con il sistema, si dovrebbe ritenere che l’acquisto del terzo rimanga salvo solo se la domanda degli eredi arrivi dopo un intervallo temporale significativo. Se invece la domanda viene trascritta entro un termine relativamente breve dall’acquisto (ad esempio entro tre mesi dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario), la sentenza di accoglimento dovrebbe imporre al terzo la restituzione del bene. In tal modo il bene rientrerebbe nell’asse ereditario e potrebbe essere liquidato a beneficio dei creditori ereditari.
La domanda di rescissione: l’insanabilità del vizio e la permanenza della lesione al tempo della domanda
È vero che la rescissione, in base all’art. 1452 c.c., non pregiudica i terzi, ma è anche vero che, ai sensi dell’art. 1451 c.c., il negozio rescindibile non è convalidabile, a differenza del negozio nullo il quale invece, ex art. 1423 c.c., può essere convalidato ove la legge lo preveda (è il caso della volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, esecuzione la quale, determinando appunto la convalida dell’atto nullo, impedisce all’esecutore – erede od avente causa – di agire per far accertare la nullità).
Ebbene, è proprio perché il vizio di rescissione è “insanabile”, che la sentenza la quale accolga la relativa domanda dovrebbe comunque travolgere l’acquisto fatto dal terzo, in quanto quest’ultimo è derivato da un contratto che non è convalidabile e che quindi è “inderogabilmente illecito”.
Inoltre, ex art. 1448 c.c., “la lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta”. Proprio questa necessità di una “continuità”, ossia della “attualità della lesione” al tempo in cui la domanda viene proposta, dovrebbe comportare la necessità di garantire una certa “coerenza” tra il presupposto previsto per la domanda giudiziale (attualità della lesione) e quella che è l’efficacia della (favorevole) sentenza di accoglimento.
Pertanto, il principio per cui la sentenza dichiarativa della di rescissione non pregiudica il terzo il quale abbia trascritto il suo acquisto prima che venisse trascritta la domanda, dovrebbe applicarsi solo nel caso in cui la domanda sia stata trascritta dopo un certo tempo (p. es. 1 anno) dalla trascrizione del titolo di acquisto, e non anche nel caso in cui essa sia stata trascritta entro un tempo relativamente breve dalla trascrizione del titolo stesso.
La domanda di revocazione delle donazioni: legittimazione passiva degli eredi del donatario e diritto del terzo di liberarsi dall’obbligo restitutorio
Revocazione per ingratitudine e ruolo degli eredi del donatario
La domanda di revocazione della donazione – che l’art. 802 c.c. attribuisce sia al donante sia ai suoi eredi – può essere proposta non solo contro il donatario, ma anche contro i suoi eredi. Questo vale anche quando l’ingratitudine riguarda esclusivamente il donatario e non gli eredi.
Consiglio: il “Manuale pratico per la successione testamentaria e le donazioni”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre al professionista una guida ragionata per gestire le questioni legali più complesse in materia di successione ereditaria.
Può accadere che il donatario abbia successivamente alienato a un terzo il bene donato. In questa circostanza, l’art. 2652 c.c. stabilisce che, se la domanda di revocazione è trascritta dopo la trascrizione dell’acquisto del terzo, la sentenza non pregiudica tale acquisto. Questo principio opera anche quando la domanda viene trascritta entro un termine breve, senza alcun riguardo al tempo trascorso tra le due trascrizioni.
Le stesse considerazioni svolte per la risoluzione della donazione modale valgono anche qui. Poiché la revocazione può essere esercitata contro gli eredi del donatario anche molti anni dopo la donazione, avrebbe senso evitare che la sentenza di revoca tuteli sempre l’acquisto del terzo. La tutela dovrebbe operare solo quando il terzo ha trascritto il proprio titolo molto tempo prima della domanda di revocazione. Diversamente, l’art. 2652 c.c. rischia di svuotare di efficacia la legittimazione passiva degli eredi del donatario.
Si pensi al caso in cui il terzo trascriva l’acquisto prima dell’apertura della successione del donatario: in tale ipotesi, gli eredi non avrebbero avuto alcuna possibilità di proporre la domanda di revocazione, e la loro legittimazione resterebbe del tutto inefficace.
Inoltre, chi agisce in revocazione contro gli eredi del donatario assume la posizione di creditore del defunto. Se gli eredi hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario, l’attore acquista una posizione preferenziale rispetto ai creditori personali degli eredi.
Effetto liberatorio del terzo acquirente ex art. 808, comma 2, c.c.
L’art. 808, comma 2, c.c. dispone che il donatario che, prima della trascrizione della domanda di revocazione, abbia costituito sul bene donato diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante per la diminuzione subita.
Di conseguenza, anche se si introducesse il criterio temporale sopra richiamato (tutela del terzo solo se la domanda è trascritta dopo un certo intervallo significativo), il terzo conserverebbe comunque la possibilità di liberarsi dall’obbligo restitutorio pagando l’equivalente in denaro. Questa regola attenua, in ogni caso, gli effetti della revocazione nei confronti del terzo.
La domanda dei creditori dell’erede rinunciante ex art. 524 c.c.: oggettiva diversità rispetto alla fattispecie del “ripensamento” ex art. 525 c.c.
Può accadere che il chiamato all’eredità, in possesso di un bene ereditario, lo alieni a un terzo prima di comunicare la propria rinuncia. L’art. 2652 c.c. prevede che, se il terzo trascrive il proprio titolo prima che i creditori del rinunciante trascrivano la domanda di autorizzazione all’accettazione dell’eredità, la sentenza che accoglie tale domanda non pregiudica l’acquisto del terzo, anche se si tratta di trascrizioni molto ravvicinate.
L’art. 525 c.c. consente al rinunciante di accettare finché il diritto di accettare non sia prescritto, purché non sia intervenuta un’accettazione successiva e senza pregiudicare i diritti acquistati dai terzi. Il terzo, quindi, conserva l’acquisto anche se il rinunciante torna sui propri passi.
Tuttavia, questo scenario differisce profondamente dall’ipotesi degli art. 524 c.c., in cui i creditori del rinunciante agiscono per tutelare il proprio credito. In questo secondo caso non si tratta di un “ripensamento”, ma della tutela di una pregressa posizione debitoria dell’erede rinunciante. Proprio per questa diversità oggettiva, sarebbe più coerente prevedere che la sentenza di autorizzazione all’accettazione possa pregiudicare l’acquisto del terzo solo quando la domanda sia stata trascritta entro un termine significativo dalla trascrizione del titolo del terzo, e non sempre e comunque come dispone l’art. 2652 c.c.
Va inoltre considerato che l’azione ex art. 524 c.c. si prescrive in cinque anni dalla rinuncia. Per attribuire reale efficacia a tale termine, la domanda proposta dai creditori diligenti dovrebbe poter pregiudicare il terzo se presentata entro un periodo ragionevole dalla trascrizione dell’acquisto.
Resta però fermo che, qualora un altro chiamato abbia già accettato con beneficio d’inventario, i creditori del defunto prevalgono sui creditori del rinunciante, che potranno soddisfarsi solo in via subordinata.
Domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre: inquadramento nell’ambito della compravendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c.
Effetti della trascrizione e obbligo del contraente inerte
Può accadere che il promissario acquirente, pur non avendo ancora stipulato il definitivo, trasferisca il bene a un terzo. Il promittente venditore può allora agire ex art. 2932 c.c. per ottenere la stipula del definitivo.
L’art. 2652 c.c. stabilisce che l’acquisto del terzo rimane salvo se il terzo trascrive il proprio titolo prima della domanda giudiziale, senza considerare il tempo trascorso tra le due trascrizioni.
Tuttavia, la domanda ex art. 2932 c.c. è comunque posteriore alla trascrizione del preliminare. L’art. 2645-bis c.c. attribuisce alla trascrizione del preliminare effetto prenotativo per tre anni. Finché tale termine non decorre, il promittente venditore gode del vantaggio della prenotazione e, dunque, dovrebbe trascrivere la domanda il prima possibile.
Se non lo fa, la sua inerzia giustifica la tutela del terzo: non ha sfruttato la protezione derivante dalla trascrizione del preliminare ancora efficace.
La vendita di cosa altrui e gli effetti sulla posizione del terzo
L’alienazione compiuta dal promissario acquirente configura una vendita di cosa altrui. L’art. 1478 c.c. prevede che il compratore acquisti la proprietà del bene solo quando il venditore la acquista dal titolare.
Se il promissario acquirente non ha ancora adempiuto all’obbligo di stipulare il definitivo, non è ancora proprietario del bene. Di conseguenza, anche se il terzo trascrive il suo acquisto prima della domanda, la sentenza che accoglie l’azione ex art. 2932 c.c. dovrebbe comunque travolgere l’acquisto del terzo, perché quest’ultimo può acquistare solo quando e se il promissario acquirente diviene proprietario.
Domanda di rivendica: la rilevanza dell’imprescrittibilità dell’azione e la liberazione del convenuto dall’obbligo restitutorio
L’art. 2652 c.c. tutela l’acquisto del terzo che trascriva prima della domanda di rivendica, indipendentemente dal tempo trascorso.
Tuttavia, l’art. 948 c.c. rende l’azione di rivendica imprescrittibile, salvo usucapione. In teoria, questa imprescrittibilità dovrebbe permettere all’attore di recuperare il bene anche se trascrive la domanda con un lieve ritardo.
In pratica, però, l’ordinamento richiede a chi propone l’azione di rivendica la massima tempestività nella trascrizione della domanda, come contrappeso all’assenza di termini di prescrizione.
Inoltre, l’art. 948, comma 1, c.c. prevede che, quando il convenuto non può più recuperare la cosa alienata a un terzo, deve comunque soddisfare l’attore pagando l’equivalente. Questo meccanismo conferma che, in materia di rivendica, la tutela della stabilità dell’acquisto del terzo prevale sull’imprescrittibilità dell’azione.
Per questi motivi, la disciplina dell’art. 2652 c.c. risulta sostanzialmente coerente con il sistema.
Conclusioni
In conclusione, la disciplina dell’art. 2652 c.c. mostra un equilibrio solo parziale tra tutela dell’affidamento del terzo e coerenza sistematica delle singole fattispecie considerate. In alcuni ambiti – si pensi, in particolare, alla clausola risolutiva espressa, alla revocazione della donazione o alla rivendica – la salvezza dell’acquisto anteriore trova una giustificazione apprezzabile. In altri casi, invece, la neutralizzazione automatica della sentenza, a prescindere dall’intervallo temporale tra le trascrizioni, rischia di svuotare di effettività la tutela sostanziale riconosciuta all’attore. Ne emerge l’esigenza di una lettura dell’art. 2652 c.c. maggiormente calibrata sulla natura del rimedio azionato e, soprattutto, sul dato temporale, inteso come indice della meritevolezza dell’affidamento del terzo rispetto alla posizione del titolare pregiudicato.