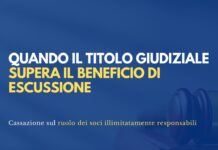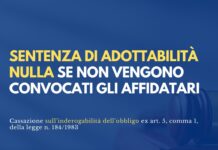Le società partecipate dallo Stato italiano svolgono un ruolo cruciale nell’economia nazionale, gestendo settori strategici e fornendo servizi pubblici essenziali quali energia, trasporti, sanità e telecomunicazioni. La loro governance, chiamata a bilanciare l’interesse pubblico con l’imperativo di efficienza economica, si trova a navigare in un contesto di sfide complesse e spesso antitetiche.
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175[1], noto come Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP), costituisce il cardine normativo per la gestione di queste entità, ponendo l’accento sui principi di trasparenza, meritocrazia e sulla necessità di arginare l’influenza politica nelle nomine degli organi di vertice (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 1).
Tuttavia, l’attuazione del TUSP ha incontrato resistenze, con persistenti interferenze politiche che continuano a condizionare il processo di selezione di dirigenti e amministratori. Tale situazione, come evidenziato da Bernardo Giorgio Mattarella, “rischia di compromettere la capacità delle società partecipate di raggiungere standard ottimali di efficienza e di adempiere al loro mandato di servizio collettivo, alimentando il sospetto di inefficienze e malgoverno”[2].
In questo contesto, si rende indispensabile un’analisi approfondita delle dinamiche operative delle società partecipate, delle criticità legate alle nomine politiche e delle riforme necessarie per promuovere una gestione autonoma, trasparente e orientata al risultato.
Struttura e organizzazione: un’analisi critica
Le società partecipate dallo Stato italiano sono generalmente strutturate come società per azioni (S.p.A.), conformemente al modello codicistico, e il loro assetto organizzativo si articola principalmente in tre organi: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (CdA) e il Collegio Sindacale.
L’Assemblea dei Soci, organo deliberativo, approva il bilancio d’esercizio, nomina e revoca gli amministratori e delibera sulle modifiche statutarie (art 2364 c.c.). Il CdA, organo di gestione, definisce le strategie aziendali, approva i piani industriali e assume le decisioni operative (art 2380-bis c.c.).
Il Collegio Sindacale, organo di controllo, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art 2403 c.c.).
Potrebbe interessarti anche:
Nonostante la formalizzazione di queste strutture, l’attuazione del Decreto Legislativo 175/2016 (TUSP) ha incontrato difficoltà nel limitare l’influenza politica nelle nomine degli amministratori. Infatti, come sottolineato da Bernardo Giorgio Mattarella, “la persistenza di interferenze politiche nelle nomine degli organi di vertice delle società partecipate rappresenta una delle principali criticità del sistema“[3], mettendo in luce quanto ancora resti da fare.
Ad esempio, pur essendo le normative a imporre la pubblicazione di bilanci e altre informazioni economiche, la qualità e la tempestività delle stesse risultano spesso insufficienti, alimentando il sospetto di inefficienze e fenomeni corruttivi[4].
Inoltre, i conflitti di interesse tra dirigenti e politici possono compromettere la qualità dei servizi erogati e la selezione dei partner economici. Nonostante queste difficoltà, il miglioramento delle pratiche di governance è fondamentale per accrescere l’efficienza e la trasparenza delle società partecipate.
Anche la Commissione Europea, nell’ambito del Semestre Europeo, ha più volte raccomandato all’Italia di proseguire con le riforme per limitare l’influenza politica e promuovere una gestione più autonoma ed efficiente delle società partecipate[5].
Per approfondire: alla luce delle sfide legate alla trasparenza e alla responsabilità nella governance delle società partecipate, si segnala il corso Maggioli Editore su Criteri ESG e corporate governance, che offre strumenti pratici su assetti organizzativi, gestione del rischio, privacy e contrasto al greenwashing. Un’occasione formativa utile per integrare i principi ESG nei modelli decisionali. Scopri di più e iscriviti qui
Nomine e interferenze politiche: il cuore del problema
Le nomine degli organi di amministrazione nelle società partecipate dallo Stato italiano sono disciplinate principalmente dal D.lgs. 175/2016 (TUSP), che promuove principi di selezione improntati su merito e competenza. Tale articolo introduce il principio della selezione basata sul merito, prevedendo che le nomine siano effettuate da un apposito comitato, il quale valuta i candidati sulla base di competenze ed esperienze professionali. Tuttavia, nonostante queste disposizioni, l’influenza politica rimane significativa, generando spesso tensioni tra principi meritocratici e logiche di appartenenza politica.
Secondo Sabino Cassese: “La gestione delle società pubbliche richiede un delicato equilibrio tra controllo politico e autonomia gestionale. L’eccessiva ingerenza politica può compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, mentre una totale assenza di controllo può favorire fenomeni di malgoverno e corruzione”[6]. In aggiunta, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sottolineato come “le nomine degli organi di vertice delle società partecipate debbano avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”[7]. Anche la Corte dei conti, nelle sue relazioni annuali, ha più volte evidenziato “la necessità di rafforzare i meccanismi di controllo sulle nomine, al fine di prevenire fenomeni di clientelismo e di nomine fiduciarie”[8].
Un altro aspetto critico riguarda la durata dei mandati. La Legge 175/2016 prevede che i mandati degli amministratori siano limitati nel tempo, ma in pratica molte volte la continuità politica influisce sulle decisioni riguardanti la riconferma degli amministratori, portando a una maggiore instabilità gestionale. Le politiche di nomina dovrebbero quindi essere orientate a favorire l’efficienza e l’autonomia delle società, ma la realtà spesso si scontra con la necessità di garantire continuità politica. I progressi sono visibili, ma non sufficienti per eliminare completamente le influenze politiche nelle nomine.
Il caso Federica Celestini Campanari: una riflessione sulla governance e la trasparenza
La nomina di Federica Celestini Campanari a Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù – AIG[9] nel 2023 ha scatenato un acceso dibattito sull’influenza politica nelle designazioni delle società partecipate.
La sua nomina è avvenuta dopo una modifica normativa introdotta dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023[10], che ha riformato la governance dell’Agenzia, istituendo la nuova Agenzia Italiana per la Gioventù e sopprimendo l’Agenzia Nazionale per i Giovani.
L’articolo 55 comma 4[11] del d.l. ha stabilito che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovesse essere “dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili“, requisito che sembra corrispondere al profilo di Federica Celestini Campanari, nominata Commissario Straordinario il 15 marzo 2023. Tale nomina ha suscitato perplessità a causa del tempismo e del possibile condizionamento politico, nonché per la mancanza del titolo di laurea magistrale, inizialmente richiesto per la candidatura.
L’interrogazione parlamentare[12] presentata dall’On. Ubaldo Pagano alla Camera dei deputati il 14 luglio 2023 ha evidenziato come Federica Celestini Campanari non fosse in possesso di tale titolo, sollevando dubbi sul rispetto delle normative e sulla legittimità della nomina. È importante sottolineare che, ad oggi, l’interrogazione parlamentare non ha ricevuto risposta da parte del Governo.
Un ulteriore elemento critico riguarda l’evento “Fenix – Lo chiameremo futuro”, organizzato dal movimento “Gioventù Nazionale”, vicino al partito Fratelli d’Italia, e promosso sui canali ufficiali dell’Agenzia. L’interrogazione ha denunciato l’utilizzo dei canali ufficiali dell’Agenzia per promuovere iniziative politiche legate a un partito politico, sollevando interrogativi sulla separazione tra politica e istituzioni pubbliche.
Il caso Celestini Campanari si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sulla governance delle società partecipate e sulla trasparenza dei processi decisionali. Il rispetto dei principi di meritocrazia e imparzialità nella selezione dei vertici delle istituzioni pubbliche è fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini.
Il Decreto Legislativo 175/2016 (TUSP) pone l’accento su questi aspetti, stabilendo criteri stringenti per la selezione dei dirigenti pubblici al fine di limitare interferenze politiche e assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche.
Rinnovi e tendenze: un’analisi dei dati
Nel 2024, sono stati rinnovati gli organi di amministrazione di 120 società partecipate dallo Stato italiano, per un totale di 524 nuove nomine. Tali rinnovi, programmati in coincidenza con le scadenze annuali di approvazione dei bilanci, hanno interessato società di diversi livelli, incluse quelle direttamente partecipate, quelle di secondo livello e quelle per azioni partecipate indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
Per il triennio 2025-2027, si prevede il rinnovo degli organi di amministrazione di ulteriori 212 società: 66 nel 2025, 77 nel 2026 e 69 nel 2027. Questi rinnovi testimoniano una pianificazione continua della revisione delle strutture di governance, volta a garantire standard adeguati di efficienza e gestione. I dati provengono dalla “Relazione annuale sulle società partecipate” della Camera dei deputati[13], che offre una panoramica aggiornata sulle dinamiche di rinnovo.
Tali rinnovi avvengono in un contesto in cui le società partecipate svolgono un ruolo sempre più strategico per l’economia italiana, in particolare per la transizione ecologica e digitale. Pertanto, la selezione di amministratori e dirigenti deve basarsi su criteri di competenza e professionalità, in linea con il d.lgs. 175/2016 (TUSP) e le linee guida dell’ANAC. Inoltre, questi rinnovi rappresentano un’opportunità per promuovere la parità di genere, in conformità con le normative recenti e le raccomandazioni dell’Unione Europea.
Parità di genere: la sfida incompiuta
La bassa presenza di donne negli organi di amministrazione delle società partecipate dallo Stato italiano è un aspetto critico.
Nel 2024, solo il 29,2% delle nomine è stato attribuito a donne, evidenziando la difficoltà nel garantire la parità di genere nelle posizioni di vertice. Nonostante la Legge 120/2011[14] preveda una rappresentanza femminile obbligatoria del 30% nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private quotate, l’attuazione di tale norma è ancora insufficiente. Come evidenziato dall’Istat, “la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate è aumentata negli ultimi anni, ma permangono divari significativi in altri settori dell’economia“[15].
Le Leggi 120/2011 e 205/2017[16] hanno introdotto incentivi e misure per promuovere l’inclusione delle donne, ma il percorso verso la parità di genere è ancora lungo. La persistente cultura aziendale prevalentemente maschile e le difficoltà strutturali ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi di inclusione. Secondo Giovanni Coppola, “l’introduzione di politiche più incisive, come incentivi fiscali per le aziende che raggiungono una maggiore rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione, potrebbe stimolare una concreta parità di genere nelle posizioni apicali“[17]. Inoltre, l’Unione Europea, con la Direttiva 2022/2381[18], ha fissato un obiettivo minimo del 40% di donne nei consigli di amministrazione delle società quotate entro il 2026. Pertanto, è necessario un maggiore impegno da parte di istituzioni e aziende per garantire la piena parità di genere.
Riforme necessarie: modelli e proposte
Le problematiche di governance e gestione che affliggono le società partecipate dallo Stato italiano richiedono interventi di riforma strutturale per migliorarne efficienza, trasparenza e responsabilità.
Diverse proposte sono state avanzate per superare le criticità legate alla politicizzazione delle nomine, alla gestione delle risorse pubbliche e all’inefficienza operativa. Tra queste, si evidenziano i modelli di best practices, modifiche legislative e nuove procedure di controllo. Una delle proposte principali riguarda la riforma del processo di nomina degli amministratori e dirigenti. Infatti, nonostante il D.lgs. 175/2016 (TUSP) abbia cercato di stabilire criteri basati su merito e competenze, la politicizzazione delle nomine resta un problema strutturale. Secondo Raffaele Marino, “l’introduzione di commissariamenti indipendenti, affidati a esperti esterni con comprovata esperienza nel settore, potrebbe rappresentare una soluzione efficace per ridurre l’influenza politica nelle nomine“[19].
Un altro aspetto cruciale per migliorare la governance è la trasparenza nelle decisioni aziendali. Best practices internazionali suggeriscono l’adozione di sistemi digitali avanzati per la pubblicazione tempestiva di bilanci e risultati aziendali.
La Legge 190/2012[20] (Legge Anticorruzione) ha introdotto misure di trasparenza, in particolare con gli articoli relativi all’accesso civico e agli obblighi di pubblicazione, ma la sua applicazione nelle partecipate è ancora limitata. Come sottolineato da Giovanni Coppola, “è necessario rafforzare il ruolo del Collegio Sindacale e introdurre piattaforme digitali trasparenti per una supervisione più efficace e partecipata“[21].
La burocrazia, che ostacola la competitività, è un altro punto critico. Secondo Marco Gatti, “la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in particolare per gli appalti pubblici e la gestione delle risorse, consentirebbe alle società partecipate di operare con maggiore flessibilità, pur mantenendo il controllo pubblico“[22]. Infine, alcune proposte mirano a trasformare le partecipate in società miste, con una significativa partecipazione privata. Secondo Luca Zampetti, “tale modello potrebbe aumentare la competitività, riducendo le difficoltà legate all’eccessiva regolamentazione pubblica“[23]. Tuttavia, come avverte Paolo Rossi, “tale trasformazione deve garantire un bilanciamento tra efficienza e controllo pubblico, al fine di tutelare l’interesse collettivo“[24].
In sintesi, le riforme proposte devono mirare a rafforzare la governance, la trasparenza e l’efficienza delle società partecipate. Un intervento legislativo coordinato e il coinvolgimento di esperti indipendenti possono risolvere le problematiche attuali e migliorare il funzionamento di queste entità economiche.
Conclusioni: verso una governance efficiente e trasparente
Le società partecipate dallo Stato italiano, pur rivestendo un ruolo essenziale nella gestione dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, presentano ancora criticità rilevanti nella governance.
Nonostante il D.lgs. 175/2016 (TUSP) abbia introdotto principi di trasparenza e meritocrazia, l’influenza politica persiste, minando l’autonomia e l’efficacia operativa. La scarsa trasparenza e la limitata inclusione femminile aggravano la situazione. È quindi imprescindibile adottare riforme strutturali e normative che rafforzino la selezione meritocratica, l’indipendenza gestionale e la trasparenza. Proposte come commissariamenti indipendenti, semplificazione burocratica e governance mista possono migliorare la gestione delle risorse pubbliche.
Tuttavia, è necessario un monitoraggio costante per bilanciare autonomia e controllo pubblico, come evidenziato dall’OCSE[25]. La parità di genere richiede misure più incisive per superare le difficoltà strutturali. Una revisione delle politiche pubbliche è auspicabile per una leadership più equilibrata. In questo senso, la Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022[26], riguardante un migliore equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate in borsa e misure connesse, rappresenta un punto di riferimento fondamentale.
In sintesi, nonostante i progressi, la riforma complessiva è ancora lontana. Le proposte qui presentate offrono una base per un intervento legislativo mirato, essenziale per modernizzare la governance pubblica in Italia. Come sottolineato dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale del 2023, “è necessario rafforzare i meccanismi di controllo sulle nomine, al fine di prevenire fenomeni di clientelismo e di nomine fiduciarie”[27].
Note
[1] Gazzetta Ufficiale, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
[2] B. G. Mattarella, Le società a partecipazione pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da S. Cassese, Milano, 2021, vol. II, p. 1253.
[3] B. G. Mattarella, Le società a partecipazione pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da S. Cassese, Milano, 2021, vol. II, p. 1253.
[4] Corte dei conti, Relazione annuale sul controllo delle società partecipate, 2023
[5] Commissione Europea, Relazione per l’Italia 2023, p. 45.
[6] S. Cassese, Lo Stato introvabile, Bari, Laterza, 1998
[7] ANAC, Linee guida in materia di nomine nelle società partecipate, 2020
[8] Corte dei conti, Relazione annuale sul controllo delle società partecipate, 2023
[9] L’Agenzia Italiana per la Gioventù – AIG è un ente pubblico non economico, istituito con la legge 14 gennaio 2003, n. 4, che ha come obiettivo quello di promuovere politiche a favore dei giovani, favorendo la partecipazione giovanile e l’integrazione europea. La sua riforma e la successiva creazione della nuova Agenzia, prevista dal Decreto-Legge n. 13/2023, rappresentano un cambiamento significativo nella governance delle politiche giovanili in Italia.
[10] Gazzetta Ufficiale, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
[11] Gazzetta Ufficiale, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, Art. 55 comma 4, “Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’attività degli uffici amministrativi dell’Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all’insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al periodo precedente, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili”.
[12] Camera dei deputati, Interrogazione a risposta scritta n. 4-01337 presentata dall’On. Ubaldo Pagano, Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista in data 13 luglio 2023.
[13] Camera dei deputati, Relazione annuale sulle società partecipate, 2024, Doc. XV, n. 245.
[14] Gazzetta Ufficiale, Legge 12 luglio 2011, n. 120, Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
[15] Istat, Rapporto sulla parità di genere, 2023
[16] Gazzetta Ufficiale, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
[17] G. Coppola, Trasparenza e controllo nelle società partecipate, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2021, n. 4, p. 85.
[18] Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.
[19] R. Marino, La governance delle società partecipate, in Rivista di Diritto Pubblico, 2020, n. 2, p. 120.
[20] Gazzetta Ufficiale, Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
[21] G. Coppola, Trasparenza e controllo nelle società partecipate, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2021, n. 4, p. 85.
[22] M. Gatti, La riforma della burocrazia nelle società partecipate, in Studi di Diritto dell’Economia, 2022, n. 1, p. 150.
[23] L. Zampetti, La privatizzazione delle società partecipate, in Economia Pubblica, 2020, n. 3, p. 200.
[24] P. Rossi, Società miste e controllo pubblico, in Diritto e Mercato, 2021, n. 2, p. 180.
[25] OCSE, Linee guida sulla governance delle imprese pubbliche, 2020.
[26] Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.
[27] Corte dei conti, Relazione annuale sul controllo delle società partecipate, 2023.