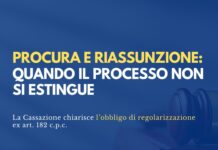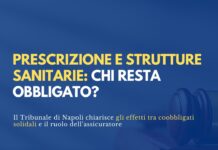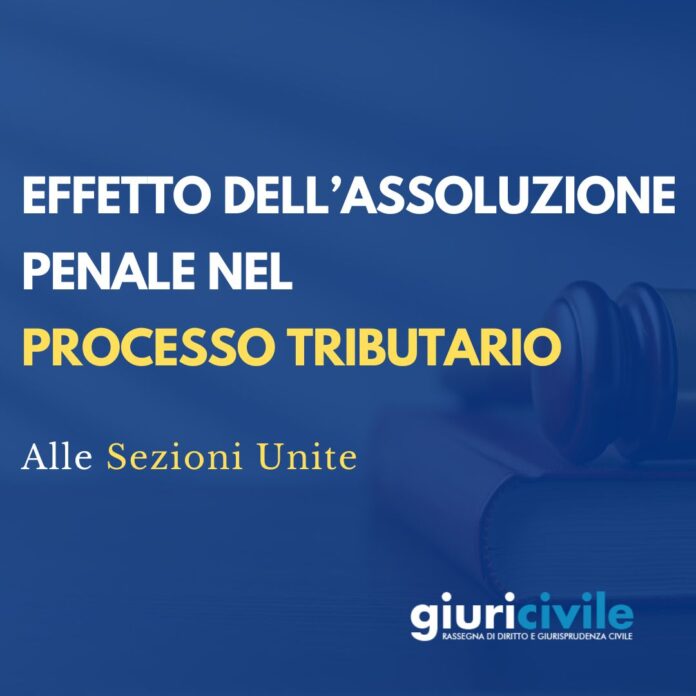
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Ordinanza 04 marzo 2025, n. 5714) invoca l’intervento delle Sezioni Unite ritenendo due questioni di massima particolare importanza: l’estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa a esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, nonché l’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal comma 2 dell’art. 530 c.p.p.
Consiglio: il Codice Tributario 2025 è uno strumento essenziale per i professionisti del settore fiscale perché raccoglie e aggiorna tutta la normativa più recente, integrando le novità della riforma fiscale e della Legge di Bilancio 2025.

Codice Tributario 2025
Il volume è aggiornato a: D.Lgs. 41/2024 (riordino del settore dei giochi); D.Lgs. 87/2024 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); D.Lgs. 108/2024 (adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale); D.Lgs. 110/2024 (riordino del sistema nazionale della riscossione); D.Lgs. 139/2024 (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA); D.Lgs. 141/2024 (revisione accise, imposte indirette sulla produzione e sui consumi); D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali); D.Lgs. 174/2024 (testo unico dei tributi erariali minori); D.Lgs. 175/2024 (testo unico della giustizia tributaria); D.Lgs. 180/2024 (aliquote dell’imposta sul valore aggiunto); D.Lgs. 192/2024 (revisione del regime impositivo dei redditi: IRPEF-IRES); L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e riporta:
Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionale
Parte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)
Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro, Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni e donazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)
Parte IV: Tributi locali e regionali
Parte V: Imposte straordinarie
Parte VI: Diritti del contribuente e interpello
Parte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscale
Parte VIII: Accertamento
Parte IX: Riscossione
Parte X: Agevolazioni fiscali
Parte XI: Sanzioni amministrative e penali
Parte XII: Contenzioso
Parte XIII: Riforma fiscale (Riforma del 2014, Riforma del 2024)
Parte XIV: Novità normative
Parte XV: Testi Unici
Chiude il volume l’indice cronologico
Luigi Tramontano
Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
Leggi descrizione
Luigi Tramontano, 2025, Maggioli Editore
36.00 €
34.20 €

Codice Tributario 2025
Il volume è aggiornato a: D.Lgs. 41/2024 (riordino del settore dei giochi); D.Lgs. 87/2024 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); D.Lgs. 108/2024 (adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale); D.Lgs. 110/2024 (riordino del sistema nazionale della riscossione); D.Lgs. 139/2024 (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA); D.Lgs. 141/2024 (revisione accise, imposte indirette sulla produzione e sui consumi); D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali); D.Lgs. 174/2024 (testo unico dei tributi erariali minori); D.Lgs. 175/2024 (testo unico della giustizia tributaria); D.Lgs. 180/2024 (aliquote dell’imposta sul valore aggiunto); D.Lgs. 192/2024 (revisione del regime impositivo dei redditi: IRPEF-IRES); L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e riporta:
Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionale
Parte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)
Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro, Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni e donazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)
Parte IV: Tributi locali e regionali
Parte V: Imposte straordinarie
Parte VI: Diritti del contribuente e interpello
Parte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscale
Parte VIII: Accertamento
Parte IX: Riscossione
Parte X: Agevolazioni fiscali
Parte XI: Sanzioni amministrative e penali
Parte XII: Contenzioso
Parte XIII: Riforma fiscale (Riforma del 2014, Riforma del 2024)
Parte XIV: Novità normative
Parte XV: Testi Unici
Chiude il volume l’indice cronologico
Luigi Tramontano
Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
La contestazione dei maggiori redditi percepiti in Italia
L’Agenzia delle entrate imputava a due donne i maggiori redditi percepiti in Italia tra il 2004 e il 2010 e sanzionava l’omessa dichiarazione di ingenti capitali mobiliari e immobiliari posseduti all’estero. L’effettivo domicilio fiscale delle contribuenti, secondo l’Amministrazione finanziaria, era in Italia e non in Svizzera, come formalmente risultante. La vicenda dopo il merito approda in Cassazione.
La questione
Si discute degli effetti nel processo tributario, anche di cassazione, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa a esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, con l’ulteriore appendice della disciplina applicabile all’assoluzione con la formula di cui al comma 2 dell’art. 530 c.p.p., alla luce dell’innovazione apportata dall’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, trasposto nell’art. 119 del T.U. giustizia tributaria vigente dal 1° gennaio 2026.
I fatti posti alla base degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione impugnati sono i medesimi di quelli oggetto dell’imputazione penale dalla quale le contribuenti sono state definitivamente assolte.
Il nuovo art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000
L’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, trasposto nell’art. 119 del T.U. giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, dispone:
“1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati”.
L’efficacia intertemporale della nuova norma
Si è chiarito che “L’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso)” (Cass. n. 1021/2025).
Si osserva che le disposizioni hanno natura processuale, incidendo sull’efficacia esterna nel processo tributario del giudicato penale (comma 1) e sulle modalità di produzione nel giudizio di cassazione (comma 2).
Effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario
Analoga convergenza non risulta ravvisabile per gli effetti che genera, nel processo tributario, anche di cassazione, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione che risponda ai requisiti di cui all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, essendosi formati a tale riguardo due, non conciliabili, orientamenti, di cui:
- il primo riconosce l’efficacia del giudicato penale pure ai fini dell’accertamento del presupposto impositivo, e dunque ai fini del rapporto tra contribuente ed erario;
- il secondo opera una lettura riduttiva della novella, che esplicherebbe i suoi effetti solo con riguardo alle sanzioni irrogate, mentre con riguardo all’imposta la sentenza penale, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, continuerebbe a essere una possibile fonte di prova, autonomamente valutabile dal giudice tributario, così come avveniva prima della recente riforma.
La rilevanza della sentenza penale pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p.
Non vi è convergenza di indirizzi sulla rilevanza nel giudizio tributario delle sentenze penali di assoluzione pronunziate ex art. 530, comma 2, c.p.p. Il primo orientamento è inteso a escluderne il rilievo ai fini della disciplina di cui all’art. 21-bis in esame (Cass. n. 4294/2025).
È stato affermato, che, pur dovendosi considerare che nel giudizio penale la prova positiva dell’innocenza dell’imputato (art. 530, comma 1) e la prova negativa della sua responsabilità (art. 530, comma 2) hanno pari valore, la giurisprudenza civile, invece, nell’interpretare gli artt. 651-654 c.p.p., ha distinto le due situazioni, attribuendo diverso valore alle ipotesi di assoluzione pronunciate a norma del comma 1 rispetto a quelle pronunciate a norma del comma 2.
La giustificazione dell’indirizzo che distingue la rilevanza ai fini civili tra i due commi viene inoltre ancorata alla circostanza che la base sostanziale dell’opzione di attribuire efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione (per le formule assolutorie di insussistenza del fatto e per non aver commesso il fatto, qui in rilievo) deriva dal maggior approfondimento istruttorio che contraddistingue il processo penale rispetto a quello civile (e tributario) e dalla possibilità, propria del processo penale, di ricostruire la situazione fattuale con estrema certezza.
Tale condizione (la ricostruzione della situazione fattuale con estrema certezza) si avrebbe solo nelle ipotesi ove la pronuncia di assoluzione sia resa ex art. 530, comma 1, c.p.p. (prova positiva che superi ogni ragionevole dubbio) e non nei casi ove la pronuncia di assoluzione sia resa ex art. 530, comma 2, c.p.p. (prova mancante, insufficiente o carente). La tesi contraria, favorevole alla estensione degli effetti dell’art. 21-bis pure alle sentenze di assoluzione con formula di merito pronunciate ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., è ravvisabile in Cass. n. 23570/2024 e Cass. n. 23609/2024.
La rimessione alle Sezioni Unite
Stante la non uniformità delle decisioni e la rilevanza dei principi, per il collegio sussistono i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del T.U. della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024) vigente dal 1° gennaio 2026, sia con riferimento al profilo dell’estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa a esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., gli atti sono stati rimessi alla Prima Presidente per le relative determinazioni in ordine all’eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza.