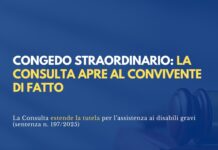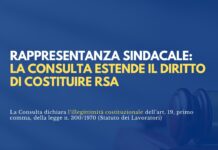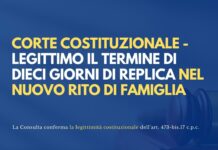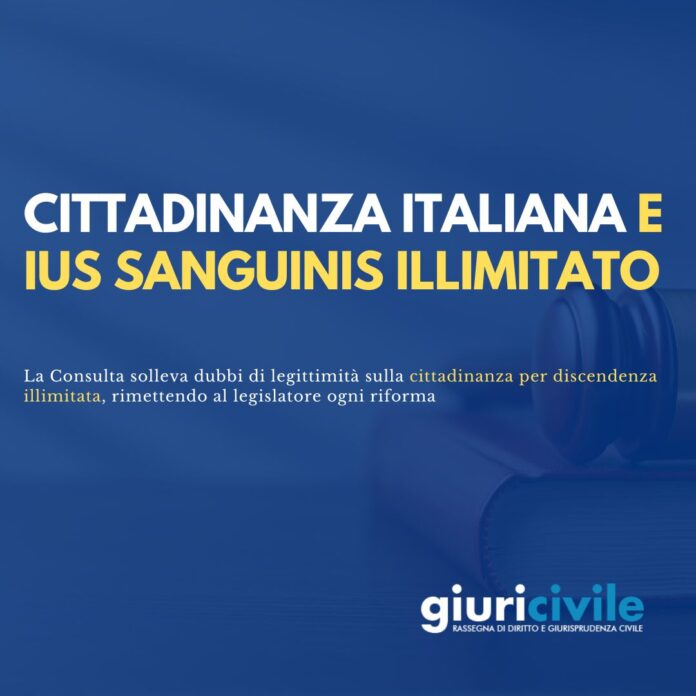
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142 depositata il 31 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha esaminato plurime questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) senza limiti di generazione. I giudici rimettenti avevano censurato la disposizione nella misura in cui consente l’attribuzione dello status di cittadino anche a soggetti privi di ogni legame sostanziale con la comunità nazionale, sollevando profili di incostituzionalità. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Inquadramento normativo
L’art. 1, comma 1, lett. a), L. 91/1992 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. La disposizione riproduce il criterio dello iure sanguinis tradizionalmente accolto dall’ordinamento italiano sin dall’unità, mai sottoposto, fino ad oggi, a limiti generazionali.
Il sistema normativo contempla altre modalità di acquisto della cittadinanza (artt. 4 e 5 L. 91/1992) che, a differenza della trasmissione per filiazione, prevedono condizioni ulteriori, quali la residenza legale, la conoscenza linguistica o la stipula dell’accordo di integrazione.
Ricostruzione della vicenda e delle questioni di legittimità
Le ordinanze di rimessione, provenienti dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze, hanno rilevato che la disciplina vigente determina un riconoscimento potenzialmente illimitato della cittadinanza per discendenza, esteso anche a soggetti nati e residenti stabilmente all’estero, titolari di altra cittadinanza e privi di qualsivoglia vincolo effettivo con lo Stato italiano.
Sono stati prospettati diversi parametri di illegittimità:
-
art. 1, comma 2, Cost., per il presunto vulnus alla nozione di “popolo” quale titolare della sovranità;
-
art. 3 Cost., per irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento rispetto ad altre modalità di acquisto della cittadinanza (art. 4, comma 1, e art. 5 L. 91/1992);
-
art. 117, primo comma, Cost., per asserita incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, in particolare con la cittadinanza europea quale definita dagli artt. 9 TUE e 20 TFUE.
In alcune ordinanze si è prospettata la necessità di introdurre un limite generazionale (ad esempio entro la seconda generazione) ovvero di subordinare il riconoscimento a requisiti ulteriori, quali un periodo minimo di residenza legale in Italia o l’accertamento di specifici legami culturali e linguistici.
Potrebbero interessarti anche:
-
Protezione internazionale e sicurezza nazionale: revoca dello status di rifugiato
-
Limiti del sindacato giurisdizionale sul Regolamento Dublino III (Sezioni Unite)
Motivazioni della Corte
Qualificazione della materia e discrezionalità legislativa
La Corte ha ribadito che la disciplina della cittadinanza appartiene alla discrezionalità del legislatore, che può modulare i criteri di attribuzione in base a valutazioni politico-istituzionali. Tale discrezionalità incontra limiti nei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, che legittimano il sindacato della Corte in ipotesi di manifesta irragionevolezza. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il vincolo di filiazione costituisce criterio tradizionalmente utilizzato per la definizione dell’appartenenza alla comunità nazionale e, in astratto, idoneo a realizzare la funzione propria dello status civitatis.
Inammissibilità delle questioni a contenuto manipolativo “di sistema”
Le questioni volte a introdurre un limite di generazione o ulteriori condizioni di effettività del legame con lo Stato sono state dichiarate inammissibili, poiché avrebbero imposto alla Corte un intervento manipolativo di tipo “additivo non costituzionalmente obbligato”, implicante scelte di politica legislativa riservate al Parlamento.
Esame delle questioni di disparità di trattamento
La Corte ha invece scrutinato nel merito i profili di violazione dell’art. 3 Cost., escludendo la comparabilità tra la cittadinanza per discendenza iure sanguinis e:
-
la fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, L. 91/1992 (acquisto da discendenti di ex cittadini), che richiede specifici requisiti temporali;
-
la cittadinanza per matrimonio (art. 5 L. 91/1992), che presuppone requisiti linguistici o di integrazione.
Secondo la Corte, la diversità di ratio e di struttura giuridica delle fattispecie esclude l’omogeneità necessaria per fondare un giudizio di irragionevolezza.
La decisione della Consulta
In tema di cittadinanza italiana, quindi, la disciplina dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che riconosce la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) senza limiti di generazione, rientra nella discrezionalità del legislatore, pur essendo soggetta al sindacato di costituzionalità nei limiti dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sono inammissibili le questioni volte a introdurre un limite generazionale o ulteriori requisiti di effettività del legame con lo Stato, in quanto comportano scelte di politica legislativa riservate al Parlamento. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost. nel raffronto con le fattispecie di acquisto della cittadinanza per matrimonio o per discendenza da ex cittadino, trattandosi di situazioni non omogenee.
Conclusioni: valore sistemico della pronuncia
La sentenza conferma la solidità del modello iure sanguinis vigente, ma lascia aperto lo spazio per un intervento legislativo volto a introdurre criteri di effettività del legame, in linea con le trasformazioni sociali e con le esigenze di tutela dell’identità nazionale. La Consulta, pur non dichiarando l’incostituzionalità della disciplina, sollecita implicitamente il legislatore a una ponderazione attuale della coerenza del sistema con il principio di effettività dell’appartenenza alla comunità statale.