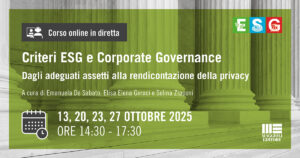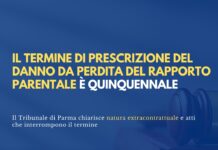Nell’ultimo articolo (lo trovi qui) ci siamo soffermati ulteriormente sulle attività utili per avvicinare i giovani al mondo della sostenibilità: partecipazione a progetti reali e networking nel settore green; rendicontazione ESG credibile, trasparente e pubblica; incentivare corsi green nelle scuole e università; promuovere tirocini ESG.
Nel nuovo approfondimento analizzeremo l’Sappiamo che l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con i suoi 17 Obiettivi (SDGs), si è saldamente affermata come la bussola strategica per le politiche europee, l’integrazione degli SDGs non è meramente simbolica; essi sono diventati il riferimento centrale che permea diversi meccanismi chiave dell’Unione Europea.
In primo luogo, gli SDGs influenzano direttamente il Semestre Europeo, il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri: ciò significa che le raccomandazioni[1] e le direttive che ogni paese riceve tengono conto dei progressi e delle sfide legate al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Inoltre, la Commissione utilizza indicatori forniti da Eurostat per valutare le performance nazionali rispetto agli SDGs, garantendo un monitoraggio rigoroso e basato sui dati.
Il mandato della Commissione 2019-2024 è stato esplicitamente strutturato attorno a sei priorità strategiche, tutte profondamente interconnesse con l’Agenda 2030.
Quest’ultimo intervento ha evidenziato un impegno costante e strutturale verso la sostenibilità, sebbene il percorso sia costellato di sfide sempre nuove, che richiedono un’adattabilità e una visione a lungo termine da parte delle istituzioni europee.
Green Deal Europeo, transizione sociale e digitale: tre priorità strategiche verso il 2030
Al cuore delle politiche dell’Unione Europea per il decennio 2020-2030 si colloca il Green Deal Europeo, lanciato nel dicembre 2019 dalla Commissione von der Leyen come strategia di trasformazione complessiva del modello economico, produttivo e sociale dell’UE[2]. L’obiettivo di fondo è ambizioso: raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, avviando, allo stesso tempo, una transizione ecologica giusta e inclusiva in grado di affrontare le disuguaglianze territoriali, generazionali e sociali.
Il Green Deal si articola in un insieme coordinato di regolamenti e strategie settoriali, tra cui il pacchetto “Fit for 55”[3], il Piano d’azione per l’economia circolare, la Strategia sulla biodiversità 2030 e la Legge europea sul clima, che impone giuridicamente il target di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990[4].
Si tratta di una trasformazione sistemica, che incide su settori chiave come l’energia, i trasporti, l’edilizia, l’agricoltura e l’industria, e che richiede un ingente sforzo in termini di investimenti, innovazione, formazione e governance.
Accanto alla transizione ecologica, la seconda priorità strategica dell’UE riguarda “un’economia che lavora per le persone”, tradotta concretamente attraverso il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, proclamato nel 2017 e rilanciato nel 2021 con un piano d’azione che definisce tre obiettivi quantitativi chiave da raggiungere entro il 2030[5]:
- Occupazione: almeno il 78% della popolazione tra i 20 e i 64 anni dovrebbe essere occupata (dato del 2023: 75,5%);
- Formazione continua: almeno il 60% degli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di apprendimento (dato del 2023: 47,6%);
- Riduzione della povertà: almeno 15 milioni di persone in meno a rischio di povertà o esclusione sociale, tra cui almeno 5 milioni di bambini.
Nonostante alcuni progressi, i rapporti periodici della Commissione e dell’Eurostat indicano che il raggiungimento di tali obiettivi richiede un ulteriore rafforzamento delle politiche attive per il lavoro, della protezione sociale, dell’inclusione e dei sistemi di istruzione e formazione[6].
La terza priorità, “un’Europa pronta per l’era digitale”, si lega in modo crescente alle sfide del Green Deal e della giustizia sociale[7]:
- Competenze digitali: almeno l’80% della popolazione adulta dovrà possedere competenze digitali di base;
- Digitalizzazione delle imprese: almeno il 75% delle imprese dovrà utilizzare tecnologie come cloud, IA e big data;
- Servizi pubblici digitali: il 100% dei servizi pubblici essenziali dovrà essere accessibile online;
- Infrastrutture digitali sicure e sostenibili: copertura 5G in tutte le aree popolate e maggiore efficienza energetica dei data center.
I più recenti regolamenti, come quello approvato nel giugno 2024 sulla neutralità climatica delle infrastrutture digitali, introducono criteri vincolanti di efficienza e sostenibilità ambientale per i fornitori di servizi digitali, in linea con gli SDGs e il principio “energy-efficient by design”[8].
Formazione – Criteri ESG e corporate governance
Il corso di Maggioli Editore sui Criteri ESG e corporate governance offre un approfondimento essenziale per avvocati, consulenti e professionisti aziendali che desiderano integrare i principi ESG nella strategia d’impresa. Strutturato in quattro sessioni, il programma affronta i requisiti normativi (finanza d’impatto, direttiva CSRD), le strategie di governance e gestione del rischio, la protezione dei dati personali e il reporting privacy, fino ai rischi di greenwashing e alle implicazioni della direttiva 825/2024. Un’opportunità per aggiornarsi sulle best practice di sostenibilità e compliance. Scopri di più e iscriviti qui.
L’Agenda 2030 come strategia di resilienza: l’evoluzione di REPowerEU
La capacità dell’Agenda 2030 di costituire un quadro strategico resiliente e adattabile è stata ulteriormente confermata dagli eventi critici degli ultimi anni.
In particolare, le ripercussioni geopolitiche dell’invasione russa dell’Ucraina (febbraio 2022) hanno imposto all’Unione Europea una revisione urgente delle proprie politiche energetiche e industriali.
In questo contesto, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) si sono dimostrati un riferimento chiave per orientare le scelte politiche, fungendo da “bussola” per le istituzioni europee nel coniugare sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.
Un esempio emblematico di questa impostazione strategica è il piano REPowerEU, presentato dalla Commissione Europea nel maggio 2022 con l’obiettivo di porre fine, “il prima possibile”, alla dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili russi[9].
Il piano si fonda su tre pilastri principali:
- Diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico;
- Accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili;
- Rafforzamento dell’efficienza energetica in tutti i settori dell’economia.
A due anni dal suo lancio, i risultati iniziano a manifestarsi in modo significativo. Secondo i dati pubblicati nel Pacchetto clima-energia di maggio 2024, per la prima volta nella storia dell’Unione Europea, la produzione di elettricità da fonti rinnovabili come eolico e solare ha superato quella derivante dal gas naturale[10].
Un traguardo che evidenzia non solo l’efficacia delle misure promosse da REPowerEU, ma anche la capacità del piano di interagire sinergicamente con le risorse del Next Generation EU e i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR), stimolando riforme strutturali e investimenti in infrastrutture intelligenti e sostenibili.
Nel dettaglio, gli investimenti in impianti fotovoltaici sono cresciuti del 40% tra il 2022 e il 2024, grazie a semplificazioni normative e incentivi diretti per l’autoconsumo e le comunità energetiche[11]. Parallelamente, l’eolico ha visto un incremento della capacità installata del 25%, trainato da nuovi progetti offshore nel Mare del Nord e nel Mediterraneo[12]. Anche il settore dell’efficienza energetica ha registrato progressi, con una riduzione dei consumi residenziali e industriali grazie alla digitalizzazione e all’introduzione di edifici a energia quasi zero (nZEB)[13].
Tali sviluppi dimostrano come l’Agenda 2030 non sia solo un insieme di obiettivi di lungo termine, ma anche uno strumento operativo capace di guidare risposte trasformative e coordinate a crisi sistemiche.
Il ruolo dell’Italia all’interno di REPowerEU
L’Italia ha assunto un ruolo strategico all’interno del piano REPowerEU, ponendosi come uno degli attori chiave nella ridefinizione dell’architettura energetica europea.
In quanto paese fortemente dipendente dalle importazioni di gas naturale, in particolare dalla Russia, che nel 2021 copriva circa il 40% del fabbisogno nazionale[14], l’Italia ha dovuto accelerare rapidamente le proprie politiche di diversificazione energetica e di transizione ecologica. Nel quadro del PNRR aggiornato nel 2023, l’Italia ha incorporato un capitolo dedicato a REPowerEU, con una dotazione finanziaria di circa 12 miliardi di euro, mirata a rafforzare la sicurezza energetica e a sostenere la transizione verde[15].
Le risorse sono state orientate su sei assi principali:
- Incremento della capacità rinnovabile, in particolare attraverso la semplificazione autorizzativa per fotovoltaico ed eolico e il potenziamento della filiera produttiva nazionale;
- Sviluppo delle reti elettriche intelligenti, per migliorare la capacità di integrazione delle rinnovabili e ridurre le perdite di rete, con investimenti in smart grid e accumuli;
- Promozione delle comunità energetiche rinnovabili, per rafforzare l’autonomia energetica dei territori e combattere la povertà energetica;
- Efficienza energetica negli edifici pubblici e scolastici, con una priorità per i territori più vulnerabili;
- Idrogeno verde e tecnologie innovative, con investimenti in progetti pilota per la produzione e lo stoccaggio;
- Riconversione industriale e formazione, per sostenere la transizione giusta nei settori a rischio di decarbonizzazione e aggiornare le competenze della forza lavoro.
Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) aggiornato nel 2024, l’Italia punta a raggiungere entro il 2030 una quota del 65% di elettricità rinnovabile e una riduzione delle emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990[16].
I dati aggiornati confermano che nel primo semestre del 2024 le rinnovabili hanno coperto il 52% della domanda elettrica nazionale, con un balzo significativo nel fotovoltaico (+24% rispetto al 2023)[17].
Questi sviluppi evidenziano come REPowerEU abbia fornito all’Italia un quadro di riferimento strategico per accelerare riforme e investimenti già avviati con il PNRR e con le politiche di decarbonizzazione previste dalla strategia europea. Tuttavia, permangono alcune criticità nella capacità di implementazione a livello regionale, nella stabilità normativa e nell’adeguamento delle reti e delle competenze, che richiedono un rafforzamento della governance multilivello[18].
Progressi, disparità e raccomandazioni per il futuro
Il Rapporto Europe Sustainable Development 2025 del Sustainable Development Solutions Network (SDSN), pubblicato a febbraio 2025, ha evidenziato una battuta d’arresto generale per gli SDGs in Europa.
Sebbene l’Italia abbia guadagnato posizioni nella classifica generale, il quadro complessivo mostra un andamento disomogeneo e un ritardo in molti Goal, prova ne sia che particolare preoccupazione è stata espressa per i sistemi alimentari e le sfide legate all’ambiente e alla biodiversità, settori in cui sono necessari interventi più incisivi.
Ad esempio, la pandemia di COVID-19 ha rivelato la fragilità dei sistemi sanitari e sociali (SDG 3 e 10), portando a un temporaneo regresso in alcune aree, pur stimolando investimenti in resilienza e preparazione alle crisi future. Allo stesso modo, le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali hanno evidenziato la necessità di rafforzare la produzione sostenibile e il consumo responsabile (SDG 12) all’interno dell’UE.
Per affrontare queste sfide e rilanciare l’impegno verso l’Agenda 2030, il Rapporto SDSN ha raccomandato quattro priorità chiave per la nuova leadership dell’UE:
- Aumentare gli investimenti in energia pulita e digitale: Un’accelerazione ulteriore degli investimenti in rinnovabili, efficienza energetica e infrastrutture digitali è fondamentale per la transizione verde e per la competitività economica;
- Rafforzare le misure sociali: È essenziale implementare politiche più incisive per ridurre le disuguaglianze, garantire un accesso equo a istruzione, sanità e opportunità lavorative, e sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione;
- Affrontare gli impatti negativi del consumo insostenibile: Serve un’azione più decisa per modificare i modelli di consumo e produzione, promuovendo l’economia circolare, riducendo gli sprechi e disaccoppiando la crescita economica dall’uso delle risorse;
- Valorizzare la diplomazia sugli SDGs/Green Deal: L’UE deve continuare a essere un leader globale nella promozione della sostenibilità, utilizzando la propria influenza diplomatica per incoraggiare l’azione climatica e lo sviluppo sostenibile a livello internazionale.
Queste raccomandazioni sottolineano che, nonostante i progressi tangibili in settori come l’energia, il cammino verso un’Europa pienamente sostenibile richiede un impegno costante e trasversale, capace di affrontare le interconnessioni tra i diversi SDGs e di adattarsi alle mutevoli realtà globali.
L’Italia e lo sviluppo sostenibile: dalle riforme costituzionali ai rapporti annuali
Negli ultimi anni, l’Italia ha rafforzato in modo significativo il proprio impegno verso lo sviluppo sostenibile. Un punto di svolta fondamentale è rappresentato dalla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, approvata nel febbraio 2022, che ha introdotto in modo esplicito la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica, sancendone la protezione anche nell’interesse delle future generazioni[19]. Parallelamente, l’iniziativa economica privata è stata vincolata al rispetto della salute e dell’ambiente, configurando una nuova gerarchia tra diritti economici e diritti ambientali.
Tale riforma costituzionale ha cominciato a produrre effetti concreti anche in ambito giurisprudenziale: la Sentenza n. 105/2024 della Corte Costituzionale, relativa al Decreto “Priolo”, ha confermato che la tutela dell’ambiente e della salute rappresenta un valore assoluto e che, eventuali deroghe ambientali, possono essere giustificate solo in casi eccezionali e in via temporanea[20].
A livello normativo e strategico, il principio dello sviluppo sostenibile si riflette nella programmazione economica nazionale: in particolare, gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), allegati al Documento di Economia e Finanza (DEF) e oggetto di una relazione annuale del MEF al Parlamento, consentono di monitorare in modo strutturato l’impatto delle politiche pubbliche sul benessere della popolazione³.
Dal punto di vista strategico, la Nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), revisionata nel giugno 2022 per allinearsi all’Agenda 2030, definisce le priorità italiane in chiave integrata e multidimensionale[21]. A supporto di essa, è stato rafforzato l’assetto istituzionale: il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), operativo dal 2021, coordina l’attuazione della transizione ecologica, promuovendo politiche settoriali coerenti con gli SDGs[22].
Infine, le Strategie Regionali e delle Province autonome per lo Sviluppo Sostenibile, insieme al Forum della società civile, contribuiscono a un approccio multilivello e multi-attore, valorizzando la partecipazione dal basso e l’adattamento territoriale degli obiettivi dell’Agenda 2030[23].
Il contributo di ogni attore sociale all’Agenda 2030
L’Agenda 2030 promuove un approccio sistemico e inclusivo, che richiede la partecipazione attiva di tutti i settori della società per realizzare una trasformazione culturale e strutturale verso la sostenibilità[24].
Ogni attore, pubblico, privato, educativo o individuale, può contribuire secondo le proprie responsabilità e competenze.
Le imprese, ad esempio, possono adottare strategie sostenibili, come l’economia circolare, per ridurre sprechi e aumentare competitività[25].
Le pubbliche amministrazioni, specialmente a livello locale, sono chiamate a integrare gli SDGs nei piani territoriali, promuovendo processi partecipativi e inclusivi[26].
Anche il settore finanziario è coinvolto nel reindirizzare risorse verso investimenti a basso impatto ambientale e ad alto impatto sociale[27].
E’ utile menzionare, anche nel mondo dell’educazione, il ruolo degli insegnanti in quanto hanno il compito di promuovere percorsi interdisciplinari sulla sostenibilità, sviluppando competenze critiche nei giovani.
I media e i giornalisti, invece, svolgono un ruolo centrale nell’informare l’opinione pubblica sulla complessità delle sfide globali e sulle interconnessioni tra fenomeni come clima, povertà e migrazioni[28].
Infine, anche i cittadini, a partire dagli studenti, possono contribuire attraverso scelte quotidiane consapevoli e azioni di sensibilizzazione, dimostrando che il cambiamento è possibile solo con un coinvolgimento diffuso e continuo[29].
Monitoraggio e prospettive future: il Rapporto ASviS 2024 e il Festival dello sviluppo sostenibile
Nel panorama italiano, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) rappresenta un punto di riferimento strategico per il monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030. Attraverso il Rapporto annuale ASviS, giunto all’edizione 2024, l’Alleanza offre una lettura approfondita dei progressi e delle criticità legate ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), mediante l’utilizzo di indici compositi e oltre 100 indicatori statistici[30].
Fondata nel 2016, l’ASviS riunisce oltre 300 soggetti tra università, enti pubblici, organizzazioni della società civile, sindacati e imprese[31].
La sua azione si articola su due fronti principali: da un lato, promuovere una cultura diffusa della sostenibilità, dall’altro influenzare le politiche pubbliche, contribuendo alla definizione di strategie nazionali e locali coerenti con l’Agenda ONU.
Tra le iniziative di maggior impatto figura il Festival dello Sviluppo Sostenibile, evento nazionale organizzato annualmente per 17 giorni (uno per ciascun SDG), volto a sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni attraverso eventi, incontri e laboratori su tutto il territorio[32]. Il Festival è diventato un importante catalizzatore di consapevolezza e partecipazione civica, dimostrando l’efficacia della collaborazione tra attori pubblici e privati per accelerare la transizione verso uno sviluppo equo e sostenibile.
Il Festival si svolge in diverse settimane (solitamente tra maggio e giugno) con centinaia di eventi in tutta Italia, coprendo tutti i temi della sostenibilità: dal clima alla povertà, dall’uguaglianza al lavoro dignitoso.
Quali sono gli obiettivi?
- Aumentare la consapevolezza sugli SDGs;
- Stimolare il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni, imprese, cittadini);
- Presentare soluzioni e buone pratiche per un futuro sostenibile;
- Promuovere azioni concrete a tutti i livelli.
È un appuntamento chiave per spingere l’Italia verso un futuro più sostenibile e inclusivo.
Note
[1] Le raccomandazioni specifiche per ciascun Paese non sono più solo orientate alla stabilità economica, ma anche alla promozione di una crescita inclusiva e sostenibile.
[2] Commissione Europea (2019), The European Green Deal, COM(2019) 640 final.
[3] https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fit-for-55.
[4] Parlamento Europeo e Consiglio (2021), European Climate Law, Regolamento (UE) 2021/1119.
[5] Commissione Europea (2021), Piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali.
[6] Parlamento Europeo (2024), Regolamento sulla sostenibilità ambientale delle infrastrutture digitali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 14 giugno 2024.
[7] Eurostat (2024), Progress towards the SDGs in the EU – Monitoring report 2024.
[8] Commissione Europea (2021), 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade, COM(2021) 118 final.
[9] Commissione Europea (2022), REPowerEU Plan, https://commission.europa.eu/repowereu_en.
[10] Ember Climate (2024), European Electricity Review – May Update, secondo cui nel primo trimestre del 2024 l’eolico e il solare hanno generato il 33% dell’elettricità dell’UE, contro il 32% del gas.
[11] SolarPower Europe (2024), EU Solar Market Outlook, che segnala una crescita record di installazioni residenziali e industriali in Germania, Italia e Spagna.
[12] WindEurope (2024), Offshore Wind Statistics 2024, che sottolinea l’espansione di impianti eolici offshore in Danimarca, Paesi Bassi e Italia.
[13] ENEA (2024), Rapporto sull’efficienza energetica in Italia, con stime di risparmio energetico del 12% nel settore edilizio grazie a interventi di riqualificazione sostenuti dal Superbonus e dal PNRR.
[14] Ministero della Transizione Ecologica (2022), Bilancio energetico nazionale.
[15] MEF (2023), PNRR – Aggiornamento 2023 con Capitolo REPowerEU, Documento ufficiale trasmesso alla Commissione Europea.
[16] MASE (2024), Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima – Revisione 2024.
[17] Terna (2024), Rapporto Sistema Elettrico Nazionale – Giugno 2024.
[18] SNAM (2024), Piano decennale delle infrastrutture gas 2024-2033.
[19] Parlamento Italiano (2022), Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. Modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione, G.U. Serie Generale n. 44 del 22-02-2022.
[20] Presidenza del Consiglio dei Ministri (2023), CITE – Stato di attuazione delle misure per la transizione ecologica, www.governo.it.
[21] CIPESS (2023), Delibera n. 79/2023 – Linee guida per la valutazione della coerenza degli investimenti pubblici con la SNSvS.
[22] ASviS (2023), Le strategie regionali e locali per lo sviluppo sostenibile: stato di avanzamento e criticità, www.asvis.it.
[23] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (2022), Nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Documento di revisione, www.mase.gov.it.
[24] Nazioni Unite (2015), Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
[25] Fondazione Symbola – Unioncamere (2023), Rapporto GreenItaly 2023.
[26] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (2023), Linee guida per l’integrazione degli SDGs nelle politiche locali.
[27] Forum per la Finanza Sostenibile (2024), Sustainable Finance in Italy: Trends and Opportunities.
[28] MIUR – Indire (2022), Linee guida per l’Educazione alla Sostenibilità nelle scuole italiane.
[29] Nazioni Unite, ActNow Campaign – www.un.org/en/actnow; ASviS (2023), Comunicare la sostenibilità: guida per media e giornalisti.
[30] ASviS (2024), Rapporto annuale “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, disponibile su www.asvis.it.
[31] ASviS (2023), Chi siamo – Organizzazione dell’Alleanza, www.asvis.it.
[32] ASviS (2024), Festival dello Sviluppo Sostenibile – Guida all’edizione 2024, www.festivalsvilupposostenibile.it.