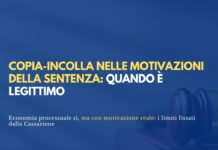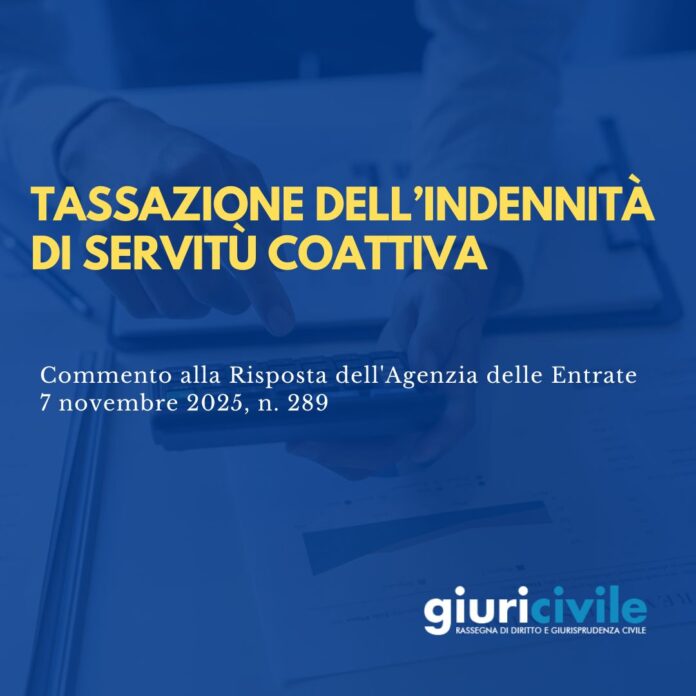
Con la Risposta n. 289/2025 (che puoi leggere cliccando qui), l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento interpretativo di estrema rilevanza in materia di tassazione delle indennità di servitù. La pronuncia si colloca nel solco delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare all’articolo 67, comma 1, lettera h). L’Agenzia sancisce in modo definitivo il superamento di un consolidato orientamento di prassi (Circolare n. 194/1998) che escludeva l’indennità per la costituzione di servitù dal campo di applicazione dell’IRPEF.
Il punto focale della Risposta è l’imponibilità dell’indennità anche quando la servitù è costituita coattivamente, nell’ambito di una procedura di asservimento per pubblica utilità. Viene così confermata la migrazione della fattispecie impositiva dalla tassazione eventuale delle plusvalenze immobiliari a quella, di più ampio respiro, dei redditi diversi, che impone la tassazione dell’intero corrispettivo percepito, indipendentemente dal periodo di possesso del bene o dalla natura volontaria dell’atto di costituzione. Questo mutamento normativo rappresenta un ampliamento significativo della sfera impositiva per le persone fisiche non in regime d’impresa.
Il caso
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate proviene da un contribuente (persona fisica) che, insieme ai suoi familiari, è proprietario di un immobile interessato da una procedura di pubblica utilità. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, l’area è stata oggetto di un asservimento finalizzato alla realizzazione di una linea elettrica, con conseguente costituzione coattiva di un diritto di servitù.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €

Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
La procedura, regolata dalle norme in materia di espropriazione (D.P.R. n. 327/2001, Testo Unico delle Espropriazioni per Pubblica Utilità – TUEPU), ha portato alla determinazione e successiva erogazione di un’indennità al proprietario. L’atto notarile per la costituzione della servitù è stato stipulato nel 2024, data cruciale poiché successiva all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.
L’istante, sostenendo la non imponibilità dell’indennità, si basava su due ordini di argomentazioni. La prima riguarda il regime delle indennità per servitù coattive sarebbe disciplinato da norme speciali (come l’art. 44 del TUEPU), le quali dovrebbero prevalere sulle norme tributarie di carattere generale (il TUIR), prevedendo l’esclusione dell’indennità dal novero dei redditi diversi. La seconda attiene alla servitù cui è stata imposta coattivamente per ragioni di pubblica utilità. Secondo l’Istante, la tassazione ex art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR richiederebbe un atto di costituzione su iniziativa del proprietario, requisito che verrebbe meno nel caso di un asservimento forzoso.
La prassi ante-2024: la non tassabilità dell’indennità di servitù
Prima dell’intervento legislativo del 2024, il trattamento fiscale delle indennità di servitù era pacificamente improntato alla non imponibilità per le persone fisiche non in regime d’impresa, salvo specifiche eccezioni. L’orientamento era cristallizzato nella Circolare n. 194/1998 dell’Agenzia delle Entrate. Tale documento chiariva che la plusvalenza tassabile, ai sensi del previgente articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, scaturiva unicamente da atti che comportassero la cessione del bene o di un diritto reale sullo stesso.
Nel caso della costituzione di una servitù prediale, l’indennità veniva esclusa dalla tassazione per il semplice ma fondamentale motivo che il proprietario conserva la piena proprietà del bene (fondo servente). A differenza dell’esproprio o della cessione (che privano il proprietario della proprietà o di un diritto reale preesistente, generando una plusvalenza), la servitù si limita a comprimere la facoltà di godimento, senza trasferire il diritto reale in capo al beneficiario.
La somma percepita era dunque considerata una mera compensazione per il mancato godimento o per la diminuzione di valore del fondo, non un corrispettivo per la cessione di un diritto. Questo principio era saldo e aveva permesso ai contribuenti di escludere dalla dichiarazione dei redditi tali indennità, a meno che non fossero correlate a terreni edificabili o lottizzati posseduti da meno di cinque anni, rientrando in quel caso nelle ipotesi tassabili previste dall’art. 67, co. 1, lett. a) o b) del TUIR.
La riforma del 2024: la “Migrazione” Impositiva nel TUIR
La Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha operato una revisione sistematica della tassazione dei diritti reali immobiliari con decorrenza dal 1° gennaio 2024, introducendo due modifiche normative cruciali.
La modifica all’articolo 67, comma 1, lettera h)
Il testo dell’articolo 67, comma 1, lettera h) del TUIR è stato modificato includendo esplicitamente tra i redditi diversi anche quelli derivanti: «[…] dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».
Il previgente testo includeva solo “la concessione in usufrutto e la costituzione delle servitù”. L’attuale formulazione, pur eliminando il riferimento specifico alle servitù, le ricomprende nella dizione più ampia di “altri diritti reali di godimento” (diritto di superficie, uso, servitù, ecc.). Questa modifica sposta la costituzione dei diritti reali di godimento (prima disciplinata, per alcuni aspetti residuali e non imponibili, dalla lett. b)) alla lettera h).
La lettera h), a differenza della b), disciplina fattispecie impositive che non richiedono il requisito del quinquennio (possesso del bene da non più di cinque anni) per la tassazione. Ne deriva che, a partire dal 2024, l’indennità percepita per la costituzione di una servitù è sempre imponibile, a prescindere dal periodo di possesso dell’immobile.
La modifica all’articolo 9, comma 5, TUIR
La seconda modifica rilevante concerne l’articolo 9, comma 5, del TUIR, norma che equipara la cessione di diritti reali alla cessione dei beni stessi. Il nuovo testo stabilisce che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.
Le due modifiche, lette in combinato disposto, portano a distinguere:
- cessione di diritti reali(es. vendita della nuda proprietà): continua a rientrare nella lett. b) dell’art. 67 (plusvalenza tassabile solo se il bene è posseduto da meno di 5 anni, salvo casi specifici);
- costituzione di diritti reali di godimento(es. servitù, superficie): rientra nella lett. h), con tassazione del corrispettivo per l’intero ammontare, a prescindere dal periodo di possesso.
La soluzione dell’Agenzia delle Entrate: imponibilità del corrispettivo integrale
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 289/2025, rigetta con fermezza entrambi gli argomenti sostenuti dal contribuente e conferma l’applicabilità del novellato articolo 67, comma 1, lettera h) del TUIR all’indennità di servitù coattiva.
L’irrilevanza della specialità della norma espropriativa
Relativamente al primo argomento (prevalenza delle norme TUEPU), l’Agenzia ribadisce un principio consolidato in materia tributaria: la qualificazione civilistica di un atto o la sua disciplina pubblicistica non ne esclude automaticamente la rilevanza ai fini fiscali. L’articolo 44 del TUEPU, che disciplina l’indennità di servitù in ambito espropriativo, ha natura speciale per quanto concerne l’aspetto indennitario e l’espropriazione, ma non interferisce con la successiva qualificazione fiscale del provento, che rimane disciplinata dal TUIR. L’indennità, in quanto corrispettivo per la costituzione di un diritto reale che comprime la facoltà di godimento, rientra oggettivamente nella nuova previsione della lettera h).
L’abbandono del criterio volontaristico
Il punto più significativo della Risposta è l’affermazione dell’irrilevanza della natura coattiva della costituzione del diritto. L’Istante, richiamando la relazione tecnica alla Legge di Bilancio, sosteneva che la norma si applicasse solo in caso di costituzione “ad opera del proprietario” (quindi volontaria).
L’Agenzia opera una lettura meramente oggettiva della norma: il dato rilevante non è la volontà del proprietario, bensì l’atto giuridico stesso che si perfeziona. L’asservimento coattivo per pubblica utilità, pur essendo imposto dall’autorità pubblica, si concretizza attraverso un atto a titolo oneroso che importa la costituzione di un diritto reale di godimento.
L’Agenzia equipara, pertanto, l’atto coattivo a quello volontario ai fini impositivi, in quanto entrambi realizzano il presupposto oggettivo previsto dalla lettera h) del novellato articolo 67 del TUIR. La conclusione è inequivocabile: la somma percepita a titolo di saldo dell’indennità di servitù, in quanto corrispettivo per la costituzione di un diritto reale di godimento avvenuta nel 2024, è assoggettata a imposizione come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR.
Determinazione del reddito e implicazioni dichiarative
Il regime dei redditi diversi di cui alla lettera h), in combinato disposto con l’articolo 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che tali redditi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Nel caso della costituzione di un diritto reale di godimento, il problema pratico più rilevante è l’identificazione di un “costo” deducibile. Non essendovi una cessione, l’indennità è finalizzata a compensare la compressione del diritto di proprietà e la conseguente diminuzione del valore del fondo.
La prassi e la dottrina più recenti tendono a ritenere che, in assenza di spese specifiche inerenti alla sola produzione del reddito (diverse dalle spese notarili per l’atto di costituzione, in genere a carico del beneficiario), il reddito tassabile sia costituito dall’intero ammontare percepito. L’indennità di servitù deve quindi essere inclusa nella dichiarazione dei redditi, in particolare nel Quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche o nel Quadro D del Modello 730, sezione II, in quanto “altri redditi diversi”.
Questa Risposta, pur concentrandosi su un caso di servitù coattiva, stabilisce un principio valevole per la costituzione di ogni diritto reale di godimento (come il diritto di superficie) su immobili, rendendoli uniformemente tassabili come redditi diversi e segnando un’importante svolta nel trattamento fiscale della proprietà immobiliare in Italia. L’impatto di questa interpretazione sulla liquidità dei proprietari asserviti, pur in presenza di un’indennità, non è trascurabile, introducendo un onere impositivo in una fattispecie precedentemente esente.